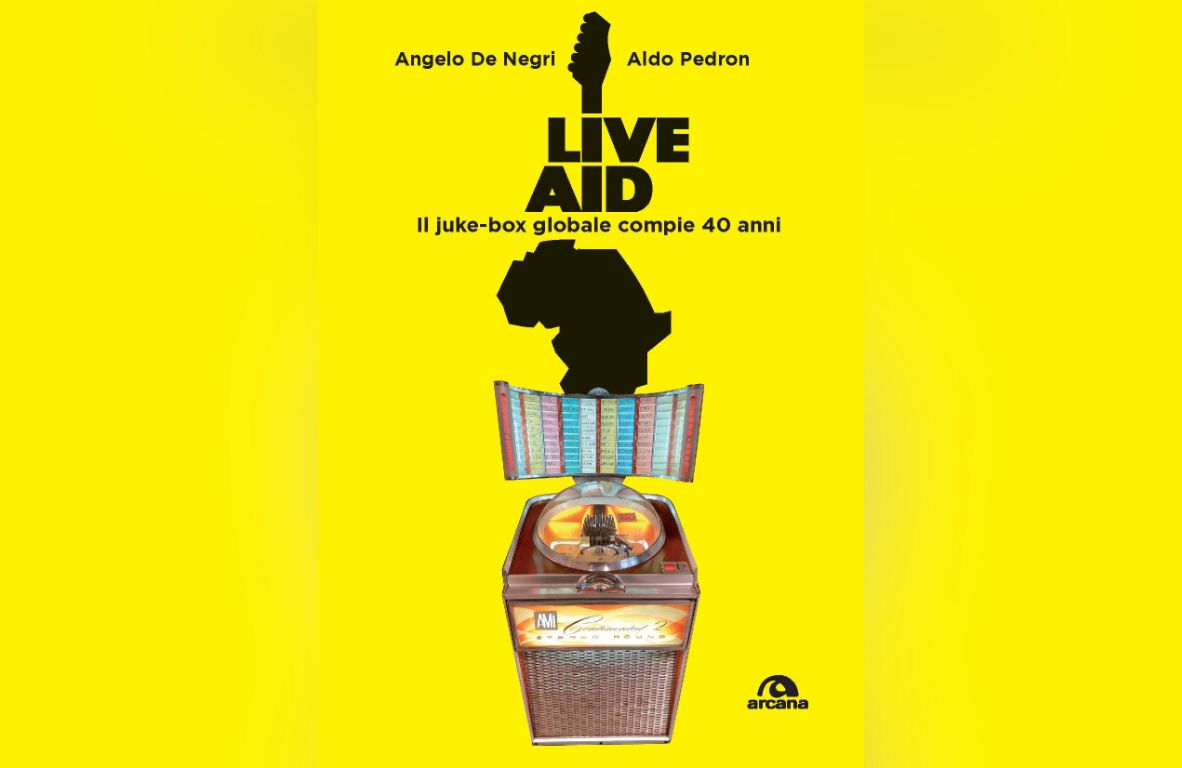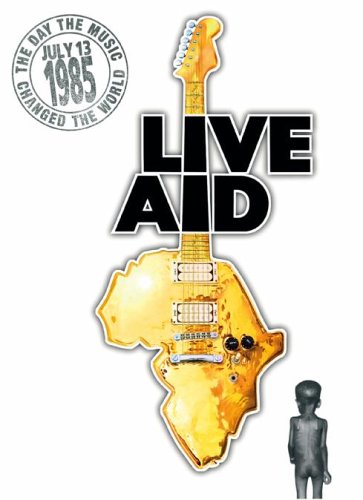40 anni di Live Aid
La lunga storia del juke-box globale nel nuovo libro di De Negri e Pedron
Il sottotitolo la dice lunga. Anzi tutta: il juke-box globale. Live Aid non fu solo il maggiore tv-show benefico della storia, ma anche una autentica parata di divi del pop e del rock, un “crocevia pazzesco” di giganti e di hit in un mondo completamente diverso da quello di sedici anni prima. Quello del 1969 e di Woodstock, inevitabile termine di paragone per dimensioni, partecipanti e impatto storico. Angelo De Negri e Aldo Pedron hanno passato in rassegna minuto per minuto la storia del Live Aid a quarant’anni dall’evento in LIVE AID. Il juke-box globale compie 40 anni (Arcana). Un volume di oltre 500 pagine dettagliato, appassionato ed esauriente. Ne parliamo con loro.
Juke-box globale, cari Angelo e Aldo: così avete definito il Live Aid, che non fu solo un concerto ma anche uno spettacolo televisivo. A quarant’anni di distanza possiamo dire che sia stato un vero e proprio modello per ogni benefit-show?
Sì, crediamo proprio che il Live Aid sia stato un modello, nel senso più ampio del termine. Per la prima volta la musica, la televisione e la solidarietà si unirono in un evento globale, capace di coinvolgere contemporaneamente milioni di persone. Da allora ogni grande benefit-show ha guardato a quel format, da Farm Aid fino a Live 8. E non è un caso che, poco dopo, nel 1985, nacque anche il progetto Sun City (creato da Little Steven alias Steve Van Zandt), con tanti artisti uniti contro l’apartheid in Sudafrica, o che nel 1988, a Wembley, si tenne il concerto per i 70 anni di Nelson Mandela: tutti figli, in qualche modo, di quello stesso spirito.
Quando parliamo di “juke-box globale” pensiamo proprio a questo: un gigantesco dispositivo collettivo dove ogni artista, ogni canzone, era come un “brano scelto” da un’umanità che per un giorno volle ascoltarsi e riconoscersi unita. Il Live Aid dimostrò che la musica poteva non solo intrattenere, ma anche smuovere coscienze e cambiare la percezione del mondo.
La storia del Live Aid è nota, sia nelle premesse umanitarie care a Bob Geldof, sia negli esiti artistici visti in tv. Il vostro studio ha fatto luce su aspetti meno noti o controversi?
Sì, abbiamo cercato proprio di andare oltre la narrazione ufficiale del Live Aid. Tutti conoscono la storia “in superficie”, l’impeto umanitario di Bob Geldof, la risposta planetaria, le performance leggendarie viste in tv. Ma dietro quella vetrina c’è un mondo molto più complesso, a tratti contraddittorio. Abbiamo ricostruito, per esempio, le tensioni organizzative, le scelte artistiche imposte dal ritmo televisivo e la gestione, tutt’altro che semplice, di 16 ore di diretta televisiva. Ci interessava capire non solo “cosa accadde”, ma come e perché accadde in quel modo. Il Live Aid non fu un miracolo spontaneo, ma una macchina colossale che anticipò l’era dei grandi eventi mediatici globali.
Ci sono poi aspetti meno noti come le critiche arrivate dall’Africa stessa, o le motivazioni di tanti artisti che hanno deciso di non farne parte. E sul piano artistico, abbiamo analizzato le dinamiche dietro le quinte, i presentatori televisivi e tutte quelle figure chiave che la diretta non mostrò mai.
In questo senso, il nostro lavoro vuole restituire al Live Aid la sua dimensione umana, politica e tecnica. Un evento epocale, certo, ma non privo di zone d’ombra. È proprio lì, in quelle contraddizioni, che si misura la sua vera grandezza: un sogno globale costruito con gli strumenti, e i limiti, del suo tempo.
Inevitabile fare il paragone con Woodstock, anche se si tratta di luoghi, contesti, epoche e anche partecipanti diversi. In che senso però può essere utile il raffronto col leggendario festival?
Il paragone con Woodstock è ricorrente, come ricorda anche Ezio Guaitamacchi nella prefazione, e la presenza nel libro del capitolo dedicato all’epopea dei grandi festival aiuta a fare un quadro generale più completo. È un confronto utile perché permette di capire quanto la musica abbia cambiato ruolo nel giro di una generazione.
Woodstock fu la celebrazione di un sogno collettivo, l’utopia di una gioventù che voleva cambiare il mondo attraverso la musica. Il Live Aid, invece, mostrò quella stessa musica ormai adulta, consapevole della propria forza e capace di usarla per una causa concreta e globale. Se Woodstock rappresentò l’ideale, il Live Aid fu l’azione. Lì dove nel ’69 si gridava “peace and love”, nel 1985 si agiva per “feed the world”. Metterli a confronto serve proprio a capire questa evoluzione: da una controcultura a una cultura condivisa, da un raduno generazionale a un evento planetario che aprì la strada a un nuovo modo di intendere la musica come responsabilità collettiva.
Crosby, Stills, Nash e Young, Who, Joan Baez e Santana furono gli unici a partecipare a entrambi gli eventi: le performance del 1969 furono storiche, e quelle del 1985?
È vero, Crosby, Stills, Nash & Young, The Who (che parteciparono anche al Monterey Pop Festival del 1967), Joan Baez e Santana furono gli unici a partecipare sia a Woodstock che al Live Aid: due momenti distanti nel tempo ma legati da un filo simbolico fortissimo. Nel 1969 erano il cuore pulsante di una rivoluzione culturale; nel 1985 erano diventati testimoni di un’epoca che aveva già fatto i conti con i propri sogni.
Le loro performance al Live Aid non ebbero forse la stessa carica “storica” o generazionale di quelle di Woodstock, il tempo aveva cambiato tutto: il pubblico, il contesto, perfino il linguaggio musicale. Ma avevano un valore diverso, quasi commemorativo e di continuità: rappresentavano il passaggio di testimone tra due idealismi, quello dei Sixties e quello più concreto e globale degli anni Ottanta.
In un certo senso, la loro presenza servì a ricordare da dove veniva tutto quel desiderio di cambiare il mondo solo che, nel 1985, quel sogno non si cantava più nei campi fangosi di Bethel, ma davanti a un miliardo e mezzo di spettatori collegati via satellite. Storico anche il fatto che sia gli Who che CSN&Y si riunirono giusto per l’occasione su insistenza di Bob Geldof che li volle coinvolti assieme ancora una volta.
Led Zeppelin, Bob Dylan e Black Sabbath, per alcuni versi lo stesso Paul McCartney, non tennero concerti memorabili, invece David Bowie, Phil Collins e Elton John furono esaltanti. Una parte della vecchia guardia era ormai tramontata o inadatta a un palco del genere?
Non possiamo dire questo in maniera tassativa, certo i set di 15/20 minuti non hanno aiutato star abituate a dare il massimo in concerto completi.
Page, Plant e Jones si ripresentavano sul palco per la prima volta dopo la morte di Bonham ed erano totalmente fuori forma e la scelta delle due batterie con Thompson e Collins non ha aiutato a semplificare le cose. Anche i Black Sabbath ritornavano sul palco assieme dopo tanti anni e a Philadelphia si sono esibiti poco dopo le nove del mattino, un orario non propriamente adatto ad una band del genere. Paul McCartney è stato poi penalizzato da uno dei pochi casi di malfunzionamento delle attrezzature ed ha cantato metà di Let It Be a microfono spento.
Al contrario, artisti come David Bowie, Phil Collins ed Elton John capirono perfettamente il linguaggio dello spettacolo anni ‘80: sintetico, visivo, immediato. Bowie, in particolare, fu magnetico – una performance elegante e potente, moderna nel suono e nella presenza scenica.
Ricordiamo il Live Aid, dal punto di vista prettamente spettacolare, per Queen, U2, Mick Jagger e Tina Turner, Madonna. Quanto fu importante quell’evento per artisti così presenti negli anni ’80?
Dal punto di vista spettacolare, il Live Aid fu un’esplosione di energia purissima. I Queen e Freddie Mercury si presero Wembley e il mondo intero: venti minuti che bastarono a riscrivere la storia del rock dal vivo. Gli U2 passarono da promessa new wave a band da stadio globale, grazie a quel momento magico in cui Bono scese tra il pubblico. Jagger e Tina Turner incendiarono Philadelphia con un duetto carico di adrenalina e ironia, mentre Madonna, ancora all’inizio della sua carriera, dimostrò di essere già una macchina da spettacolo perfetta, pronta a dominare il decennio.
Insomma, il Live Aid non fu solo beneficenza: fu una vetrina planetaria e un rito di passaggio. Quel giorno le star si trasformarono in icone pop globali, e la musica degli anni Ottanta trovò la sua immagine definitiva, potente, televisiva e indimenticabile.
Live Aid va letto nel contesto dell’epoca, sulla lunghissima onda del riflusso e della normalizzazione con l’avvento di MTV e del walkman. Quanto c’era di autentico e quanto invece di artefatto e condizionato dai nuovi linguaggi dei mass media (o dall’ego degli organizzatori e dei partecipanti)?
Possiamo dire che nel Live Aid convivevano entrambe le anime: quella autentica e quella costruita. L’autenticità stava nell’urgenza, nell’impulso vero di Bob Geldof e degli artisti di fare qualcosa di concreto di fronte alle immagini della carestia in Etiopia. Nessuno, nel 1985, aveva mai tentato nulla di simile: unire mezzo mondo attraverso la musica per una causa umanitaria. Ma è innegabile che il tutto fosse anche figlio della sua epoca, plasmato dai linguaggi di MTV, dalla logica televisiva e dall’egocentrismo di un rock ormai abituato ai riflettori globali. Il Live Aid era sinceramente idealista e, al tempo stesso, perfettamente consapevole del proprio impatto mediatico.
C’erano le star e i loro ego, certo, ma anche milioni di persone che per un giorno si riconobbero in un progetto collettivo. Il risultato fu un ibrido unico: solidarietà e spettacolo, empatia e autocelebrazione. È proprio questa ambiguità, raccontata anche nel nostro libro, a rendere il Live Aid così interessante ancora oggi – un evento in cui la musica si fece messaggio, ma anche immagine, mito e televisione planetaria.
Da Federico Guglielmi a Stefano Senardi, passando per Ermanno Labianca, avete intervistato vari testimoni dell’epoca. Ognuno ha il suo ricordo, ma qual è invece quello comune a tutti?
Quello che emerge dalle testimonianze è un sentimento comune: lo stupore. Tutti ricordano il Live Aid come qualcosa di irripetibile, un momento in cui la musica sembrò davvero capace di cambiare il mondo o, almeno, di farlo credere possibile. Al di là delle differenze di giudizio chi lo considera un capolavoro mediatico, chi una grande illusione ciò che accomuna tutti è la consapevolezza di aver assistito a un punto di svolta. Per un giorno, il rock smise di essere solo intrattenimento e diventò linguaggio universale, collettivo, planetario. E forse è proprio questo il ricordo condiviso: la sensazione di essere parte di qualcosa di più grande, di un’umanità che, attraverso la musica, trovava un suo momento di unità. Un sogno che durò poco, ma che ancora oggi a distanza di quarant’anni continua a farci discutere, ricordare e, in fondo, emozionare.
La raccolta delle donazioni ha sollevato polemiche e strascichi: ci raccontate come fu gestita l’erogazione?
La gestione dei fondi del Live Aid è uno degli aspetti più delicati e controversi dell’intera vicenda. Parliamo di una raccolta colossale – oltre 80 milioni di dollari nel solo 1985 – che, attraverso la Band Aid Trust di Bob Geldof, doveva finanziare progetti umanitari in Etiopia e in altre zone colpite dalla carestia. Una parte consistente di quei soldi arrivò davvero a destinazione, come confermarono gli audit dell’epoca. Ma non tutto andò liscio: il contesto politico era complicatissimo, con la guerra civile in corso e un regime autoritario al potere. È inevitabile che una parte dei fondi sia stata gestita in modo non sempre trasparente o sia finita nelle mani sbagliate, come denunciato in alcune inchieste successive.
Quello che emerge, però, è che il Live Aid non fu una truffa, ma un esperimento gigantesco di solidarietà globale che si scontrò con la realtà. L’entusiasmo mediatico e l’ingenuità umanitaria si incontrarono in un’operazione senza precedenti, dove idealismo e pragmatismo non sempre riuscirono ad andare di pari passo. In fondo, è anche questo che rende l’evento così umano: un progetto autentico nelle intenzioni, ma inevitabilmente condizionato dai limiti politici, logistici e mediatici del suo tempo.
Vent’anni dopo, nel 2005, Bob Geldof e Midge Ure idearono il Live 8: fu revival, nostalgia, rigurgito umanitario o altro?
Il Live 8 fu un po’ tutte queste cose insieme: revival, nostalgia e, in parte, un rigurgito di coscienza collettiva.
Vent’anni dopo, Bob Geldof e Midge Ure tentarono di riaccendere quella scintilla, ma il mondo era ormai cambiato: la fame in Africa non era più al centro dell’attenzione e la musica non aveva più lo stesso potere unificante del 1985. Il Live 8 fu più politico che umanitario perché pensato per spingere i leader del G8 ad agire sulla questione del debito africano e più mediatico che emotivo. C’era un forte senso di revival, con la reunion dei Pink Floyd come momento-simbolo, ma anche la consapevolezza che la magia del primo Live Aid fosse irripetibile.
In un certo senso, il Live 8 racconta la fine dell’innocenza: il sogno di cambiare il mondo con una canzone era diventato parte dell’industria stessa. Ma resta comunque una testimonianza potente: il tentativo, forse l’ultimo, di usare la musica pop come megafono globale per un’idea di giustizia.