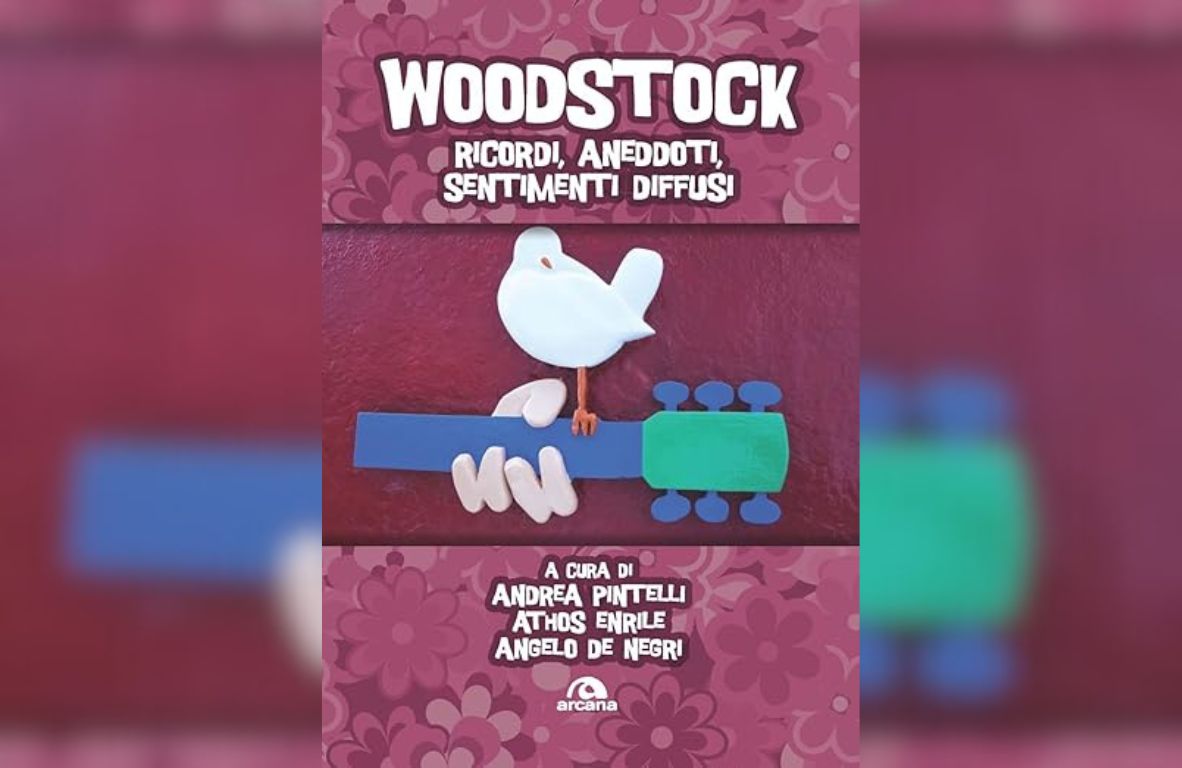Cinquantacinque anni da Woodstock
Pintelli, Enrile e De Negri raccontano il celebre festival per i tipi di Arcana
Quanto è stato scritto su Woodstock. Forse troppo, ma col senno di poi è sempre un bene che i grandi eventi della storia della musica siano ricordati, analizzati da nuovi e diversi punti di vista. Più vicino a un’ottica celebrativa – ma con senso e motivazioni – è il lavoro di Andrea Pintelli, Athos Enrile e Angelo De Negri, che hanno raccontato il festival con un respiro corale, tra interviste e contributi vari. Ne parliamo con Enrile, anima del magazine MAT2020.
Il sottotitolo del vostro libro parla di ricordi e aneddoti, ma anche di “sentimenti diffusi”. Partiamo proprio da questi: che tipo di sentimento evoca il pensiero di Woodstock?
È facile verificare come il termine “Woodstock” abbia assunto nel tempo un significato che supera l’evento specifico, ma ne abbiamo avuto la certezza nel corso delle tante presentazioni proposte sino ad ora, tutte cariche di entusiasmo e partecipazione, tutte a base di parole e set acustici tesi a presentare alcuni brani di quei giorni. Quindi, oltre al mio pensiero, posso aggiungere le tante fotografie virtuali scattate a chi abbiamo incontrato, essenzialmente non giovanissimi, ma in tutti ho trovato la voglia, quasi il bisogno, di ricordare, ascoltare, verificare un momento storico importante e, in automatico, compararlo con l’attualità. Tirando le somme, abbiamo chiacchierato poco di musica (ma l’abbiamo ascoltata) e dialogato di fatti storici, culturali, sociali, persino tecnologici.
Ho volutamente divagato, ma non sfuggo alla tua domanda. Nell’ultima festa ci siamo ritrovati in un agriturismo, il cui gestore è un “ragazzo” di 40 anni, uno che dopo aver provato l’impiego nell’industria ha deciso di cambiare vita. Tra i suoi tanti tatuaggi me ne ha mostrato uno con orgoglio, impresso su una gamba, il simbolo di Woodstock da tutti conosciuto. Alla mia curiosità legata al “marchio” e al suo cambiamento di vita ha risposto così: “Ho scelto la libertà”.
Ecco, i sentimenti più diffusi che mi vengono in mente quando penso a quei giorni, che ho vissuto come osservatore lontano e in miniatura, sono quelli che fanno riferimento all’indipendenza, all’emancipazione, al riscatto. Io ricordo tanta serenità, sensazione importante che avvertii quando, quattordicenne, appresi cosa era realmente andato in scena in quella campagna posta a un’ora da New York, a metà agosto del 1969.
Perché ancora oggi si parla di Woodstock Generation? Cosa accomunava il mezzo milione di persone accorse a Bethel?
Il fatto che una moltitudine di giovani si sia trovata a Bethel è abbastanza nella norma e il fenomeno è verificabile in ogni era, e ha a che fare con la necessità di fare parte di un gruppo, con la musica del momento a cementare la comunione di intenti. Grazie a qualche organizzatore volenteroso e illuminato si passò dal concerto contenuto a qualcosa di più grande, che era stato anticipato un paio di anni prima a Monterey. Musica, libertà, propositi comuni, l’ideologia dei figli dei fiori, una comune protesta contro guerra e violenza.
Ma la cosa che dovrebbe essere oggetto di studio – e forse lo è stata – è la cifra partecipativa, quel mezzo milione di persone che nelle previsioni dovevano essere cinquantamila, in tempi in cui internet non esisteva, e le informazioni così di nicchia trovavano poco spazio nei giornali e tutto era delegato al passaparola. Metterei quindi assieme i concetti di “appartenenza al gruppo” e “comunione di intenti”, probabilmente alimentati da uno slogan perfetto, che riuscì ad arrivare ad un numero impressionante di giovani.
Al di là della cronaca dei tre giorni, ormai narrati in modo persino chirurgico, proviamo a cogliere alcuni aspetti chiave. Penso ad esempio ai Santana. All’epoca era possibile che una band praticamente conosciuta da pochi potesse trionfare sul palco calcato da vere e proprie star…
La performance di Santana fu impreziosita dalla presenza di un batterista ancora minorenne, Michael Shrieve, che sbalordì per la sua bravura precoce. I Santana aveva il loro seguito, ma la dimensione era locale, e fu quella l’occasione, che anche altri sfruttarono, di mettersi in mostra davanti al grande pubblico, che così scoprì la forza della band. Ma la loro fortuna è legata ad una pellicola, quella girata da Michael Wadleigh e dalla sua troupe, all’interno della quale trovava posto un giovane Martin Scorsese. Le persone che facevano parte del team risultarono un problema/fastidio per gli organizzatori, che dovevano far fronte a esigenze enormi, legate soprattutto a una gestione pensata per un numero di persone più contenute. Girare una pellicola non sembrava certo una priorità, ma fu proprio grazie a quella che artisti come Carlos Santana & friends – e gli stessi organizzatori – trovarono immediata consacrazione.
Potere del film: a Woodstock c’erano anche Creedence e Grateful Dead ma l’assenza dalla pellicola ha pesato tanto sulla loro storia… quanto è stato importante quel contributo cinematografico, soprattutto in Italia?
Avevo 14 anni quando, nel ’70, vidi al cinema Woodstock, 3 giorni di pace amore e musica. Le regole di quei giorni permettevano visioni illimitate e io rimase per ore – tre giri di giostra – a guardare e ascoltare incantato. Quei momenti non mi hanno mai più abbandonato. Senza quella pellicola non sarebbe mai arrivata rapidamente la notorietà per Santana, Ten Years After, Country Joe, Melanie… eppure nel film mancano band importanti, come quelle che hai citato e che, seppur divenute famose, avrebbero visto amplificare a dismisura la loro notorietà, se avessero dato il consenso ad essere filmati. Un caso eclatante riguarda CSN&Y, con il solo Neil Young che non diede il permesso per la ripresa, e sicuramente se ne pentì.
Sul versante star, tra Hendrix, Who, Joan Baez e CSNY, c’era l’imbarazzo della scelta. Ogni big però è andato a Woodstock con aspettative e umori diversi. Più di mezzo secolo dopo, secondo te chi ha incarnato con autenticità lo spirito del festival?
Anche allora il dio denaro dominava sul palco e oltre, e nacquero diverse diatribe legate a consensi e a priorità di entrata in scena. Se penso alle vicende e alle storie personali che hanno contraddistinto il cammino di quegli artisti, almeno tra quelli che ho seguito nel tempo, mi viene in mente solo Joan Baez: secondo me la sua presenza non aveva solo un significato musicale, e nel prosieguo di carriera ha dimostrato grande coerenza e dedizione alla causa… alle cause!
Veniamo al nostro paese, dove Woodstock è stato un sogno, un’utopia, ancor prima che un evento. Avete raccolto ricordi e pensieri di tanti musicisti e addetti ai lavori, da Vittorio Nocenzi a Claudio Sottocornola, da Lino Vairetti a Riccardo Storti. Cosa ha rappresentato Woodstock per noi italiani?
Il libro è stato concepito in mood collegiale e abbiamo cercato i commenti e le opinioni di altri addetti ai lavori. Tutti i contributi impreziosiscono il book, ma vorrei proporre una mia esperienza personale per provare a disegnare l’atmosfera dell’epoca.
Sull’onda lunga del film, nacquero in tutta Italia piccole Woodstock, raduni con molte band, della durata di più giorni, che tentavano di copiare le gesta degli eroi di Bethel. C’era un certo ritardo, e il tutto si concentrò tra il ’72 e il ’75. Io ne ho vissuta una in prima persona, nel luglio ’74, appena diciottenne. Sto parlando del Festival di Altare, località posta nell’entroterra savonese, e il luogo specifico era soprannominato “la pozza”, per la presenza di un piccolo bacino che poi si sarebbe scoperto inquinato. Due giorni pazzeschi, con musica dei Circus 2000, Battiato, Alan e Jenny Sorrenti, Balletto di Bronzo. Quella fu una vera ricalcatura di Woodstock, con tanti ragazzi che, emulando ciò che avevano visto nel film, si buttavano nudi nella pozza.
Ricordo un po’ di disagio da parte mia… a parte l’esteriorità ero un “falso hippy”!
Qualche italiano c’è anche stato: racconta!
Spesso mi sono trovato a vedere concerti di band che erano state a Woodstock e la cosa mi ha sempre fatto un certo effetto positivo. Ma è stato piacevole conoscere anche “non musicisti” che erano sul posto, e sottolineo che partire dall’Italia e andare ad assistere ad un concerto dalle parti di New York non era certo agevole a quei tempi.
Il primo di cui posso parlare è quello che sarebbe diventato un famoso cantautore, Simon Luca, che conosco personalmente da molti anni. Nell’occasione di una presentazione del libro a Milano ha partecipato e ha raccontato direttamente al pubblico il suo status di allora, giovane alla ricerca di sé nella West Coast. Una volta tornato a New York per prendere il volo verso l’Italia, il passaparola a cui accennavo prima lo portò ad una facile decisione, quella di restare qualche giorno in più e vedere il festival, fatti ed emozioni che racconta nel libro.
La seconda persona che mi ha fornito testimonianza diretta è Lucio Salvini, che visse tutti i giorni dell’evento per scopi professionali, essendo all’epoca responsabile estero di una casa discografica. Fu quella l’occasione in cui stipulò un contratto con la Baez con cui collaborò per svariati anni.
Ho scoperto recentemente dell’esistenza di una signora di Alba, in Piemonte, che era presente, ma purtroppo è mancata.
Aggiungo tra i miei incontri sorprendenti quello con Eddie Kramer, ingegnere del suono a Woodstock, che intervistai sul palco genovese del FIM. La sua risposta sintetica alla mia semplice domanda: “Ma come fu realmente il festival?”, trovò la seguente disarmante risposta: “Un vero inferno!”. Non solo pace, amore e musica!
Pochi mesi dopo Woodstock fu la volta di Altamont: non più pace e amore ma rabbia. Che successe?
Il festival ha vissuto un “pre” e un “dopo” che hanno dettato alcuni limiti.
Il “pre” è rappresentato da quanto accaduto una settimana prima del festival, quando sulla costa ovest la famiglia Manson massacrava Saron Tate e ospiti, spacciandosi per hippy. Il concerto di Altamont risale invece al 6 dicembre, organizzato dai Rollling Stones per compensare la loro mancata adesione a Woodstock. La loro “geniale” idea di utilizzare come servizio d’ordine gli Hells Angels procurò un morto nel corso della performance, e questa giornata funesta è simbolicamente considerata la fine dell’illusione racchiusa negli ideali di Woodstock: la morte di un giovane è diventata così la fine dell’utopia racchiusa in quei tre giorni caratterizzati sulla carata dal motto “peace & love”.
Qual è il lascito di Woodstock nella cultura rock di oggi?
Se parliamo di musica, attraverso un ascolto attento è facile comprendere la grandezza di ciò che fu realizzato. Suggerisco ai giovani curiosi di avvicinarsi senza pregiudizi e, dopo la giusta scrematura, estrarre delle perle divenute immortali, anche se le varie performance furono certamente lontane dalla perfezione, anche a causa di certi abusi che non permettevano la piena lucidità dei protagonisti. Quei giorni hanno dimostrato che si può vivere in piena comunione, che si possono trovare strade alternative all’ortodossia imposta, ma anche che, per realizzare i nostri sogni, occorre trovare la giusta concretezza.
Mi rivedo al festival di Altare, dopo aver dormito sotto al palco, e ricordo il sollievo che provai quando alla sera del secondo giorno i miei genitori mi vennero a recuperare, mentre Battiato emetteva suoni che mi sembravano inascoltabili! Riguardando l’episodio con occhi attuali mi viene da pensare che i valori erano certamente tutti nobili, ma le strade da percorrere richiedevano pragmatismo, quello che certamente manca a vent’anni, in qualunque epoca, e la musica da sola, forse non basta a sistemare le cose!