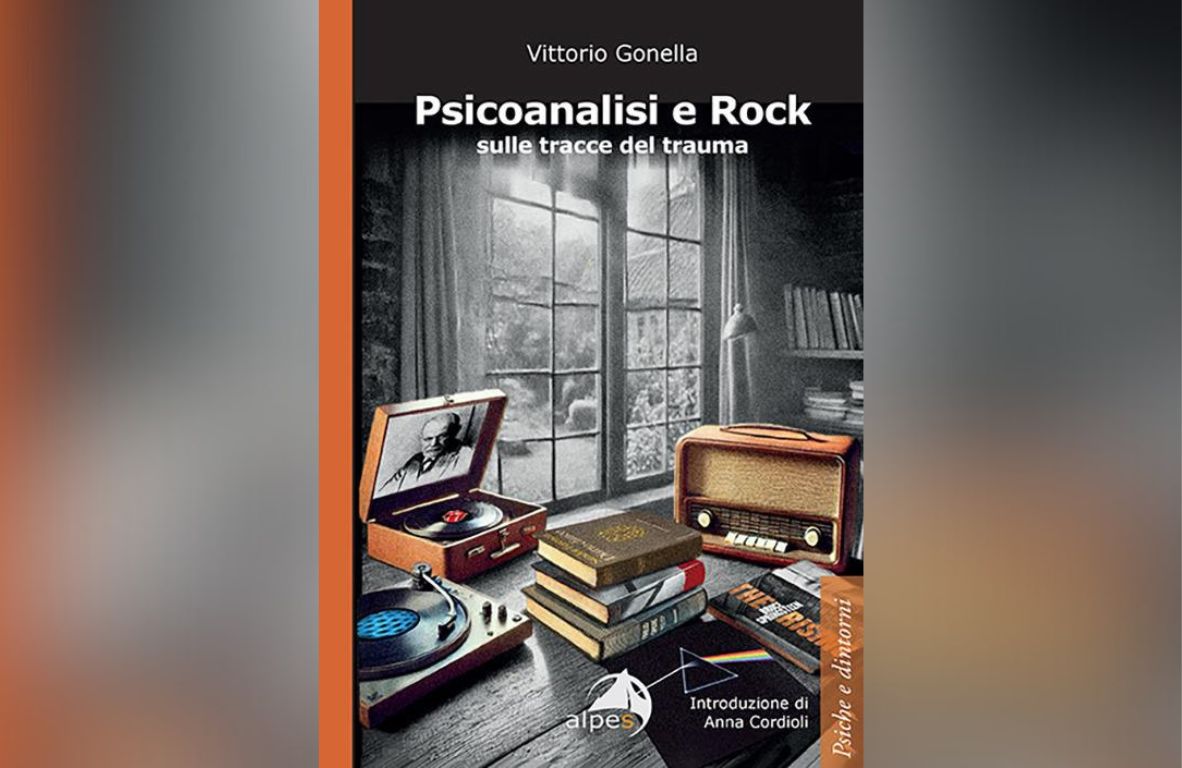Psicoanalisi e rock sulle tracce del trauma con Vittorio Gonella
Alpes pubblica il saggio dello psicologo appassionato di musica
Depressione, paranoia, nevrosi e psicosi di vario genere sono stati all’ordine del giorno nella storia del rock. Da John Lennon a Syd Barrett, da Ozzy Osbourne a Amy Winehouse, i disagi interiori dei protagonisti sono stati raccontati ampiamente, spesso con una aneddotica generosa ma senza entrare nel merito per comprenderne le cause e gli esiti. Psicoanalisi e rock – Sulle tracce del trauma (Alpes Italia) prova a colmare questa lacuna partendo da un dato centrale: la competenza. Vittorio Gonella non è solo un cultore rock, è principalmente uno psicologo e psicoterapeuta e per questo studio è partito dall’origine: dai traumi sublimati in arte. Ne parliamo con lui.
Penso proprio, caro Vittorio, che questo libro possa colmare una lacuna. Troppe volte l’editoria ha dato spazio a testi sui folli del rock, sui suicidi eccellenti, sui beautiful losers condannati al loro disagio, senza addentrarsi nelle cause. Può essere questo il tuo punto di partenza?
Assolutamente sì! Nel momento in cui nella mia mente si è creato un contatto tra la passione musicale e la formazione psicoanalitica, molto incentrata sul trauma e i suoi effetti sull’individuo, ho iniziato a scorgere, dietro le maschere e gli abiti delle rockstar, delle persone, spesso sofferenti e desiderose di essere viste, riconosciute e ‘ascoltate’ nella loro essenza umana. Il dramma, a mio parere, per alcuni di loro (penso in particolare a Jim Morrison, Janis Joplin e Kurt Cobain) è stato essere trasformati in idoli troppo in fretta, e io stesso riconosco di averlo fatto: il cantante, il musicista, l’artista, soprattutto quando noi ascoltatori siamo adolescenti in cerca di punti di riferimento e comprensione, sono soggetti a un processo di idealizzazione che ci porta a dimenticare la loro quota umana.
Le rockstar diventano spesso per l’ascoltatore una sorta di genio che nelle canzoni “parla di me, mi capisce, mi coccola, mi fa sentire visto”. Il dramma di questo processo di idealizzazione è che la nostra mente, e di conseguenza il nostro ascolto, inconsapevolmente rimuove e dimentica un aspetto fondamentale dell’arte: che l’origine della creazione artistica è nell’anima, nella mente, nella storia e nel corpo del soggetto che crea, tanto capace di esprimersi da costruire così qualcosa di simbolico e apparentemente poco personale in cui il fruitore dell’opera si sente riconosciuto e capito.
Citi subito una figura centrale per te e tanti tuoi colleghi, Donald Winnicott. L’interesse dell’esimio psicoanalista per John Lennon si fermava solo agli occhialini e all’aria irriverente del Beatle (e inevitabilmente al suo rapporto con il materno) oppure, per personalità distanti dal rock come lui, quel mondo rappresentava una occasione di studio allettante?
Penserei a una terza ipotesi: è vero che nel suo primo periodo, intorno all’inizio del Novecento, la psicoanalisi (ad esempio Sigmund Freud scrisse un saggio dedicato a Leonardo Da Vinci), così come la psichiatria, ha studiato gli artisti cercando di trovare dei collegamenti tra opera d’arte e profilo di personalità, genio e follia, una sorta di ‘psicoanalisi dell’arte’ che non è servita a nessuno, se non a rendere la psicoanalisi un po’ antipatica agli artisti, che si sono sentiti messi sotto una lente osservativa ‘medica’ e giudicante, che cercava di dare un senso a qualcosa che non era così chiaro nemmeno a loro.
Ciò che, invece, immagino abbia fatto Winnicott, ed è stato lo spunto per il primo capitolo-racconto del mio libro, è aver pensato a una ‘psicoanalisi dall’arte’, cioè che il rock, come ogni altra forma d’arte, potesse offrire alla psicoanalisi ulteriori spunti per la comprensione dell’animo umano e delle sue dinamiche.
Io immagino che Winnicott si sia interessato non solo all’importanza e al significato che i Beatles avevano per le giovani generazioni ma abbia colto anche la portata ‘umana’ e di sofferenza presente nell’opera di John Lennon; e che sia riuscito a sintonizzarsi, lui figlio di una madre molto depressa a cui aveva dedicato una straordinaria poesia intitolata L’albero, con il dramma di John (la perdita improvvisa e precoce della mamma) e il suo tentativo di trovare un’elaborazione di questo dolore nella stesura di brani come Julia – nel White Album dei Beatles –
e poi Mother.
Il caso Morrison è emblematico, rappresenta un’intera generazione: il conflitto con il padre militare, la fuga e la ricerca di un’identità nell’arte, l’indole autodistruttiva. La parola chiave, da te usata, è rispecchiamento: perché?
Torno brevemente a Winnicott: prima di diventare psicoanalista era un pediatra, questa esperienza professionale gli permise di portare l’attenzione sulla relazione precoce, dei primi mesi di vita, tra madre e bambino; comprese che la possibilità che il bambino sviluppasse, nel corso della vita, una personalità sana, un Sé autentico, dipendeva da questi primi scambi relazionali con la figura d’accudimento. Winnicott ipotizzò che anche la creatività, da cui si origina ogni forma d’arte, avesse origine in questa fase della vita: seguendo il lavoro del suo allievo Kenneth Wright, ritengo che l’opera d’arte (compresi quindi gli album e le canzoni) siano una creazione simbolica in cui l’artista cerca di ritrovare – o a volte: trovare per la prima volta se è mancata come esperienza infantile – una forma di ‘holding’, di contenimento simile a ciò che aveva offerto chi si prendeva cura di lui neonato. Questa funzione materna fu definita da Winnicott ‘rispecchiamento’ nel senso che la madre, come l’opera d’arte, non offre solo una esplicitazione dei vissuti dell’artista ma permette a quest’ultimo di entrare in contatto e dare significato anche a parti del Sé ancora sconosciute e inconsce, che possono venire alla luce grazie all’incontro con un qualcosa che ‘rispecchia’ ciò che una persona ha dentro di sé, e spesso si tratta di esperienza dolorose e tratti di fragilità personale.
In questo senso, per l’artista diventa fondamentale la presenza di un fruitore (nel caso della musica: gli ascoltatori) con cui proseguire questo processo relazionale: perché l’arte non è un semplice processo individuale narcisistico in cui l’artista si gode il proprio talento, è molto di più, è la ricerca di un incontro, di uno spazio di condivisione, perché è nell’incontro con l’Altro che ognuno di noi si sente visto e ascoltato.
La mia ipotesi, pensando alla storia di Jim Morrison e alla sua arte, è che gli sia mancata questa funzione di rispecchiamento da parte dei genitori, soddisfatti che fosse un bimbo intelligente e pieno di talenti ma sempre svalutanti e critici rispetto ai modi in cui lui dava voce al proprio Sé: una reazione così difficile da comprendere e tollerare per Jim che, poco dopo la nascita dei Doors e l’ennesimo mancato riconoscimento paterno, iniziò a dire a tutti che era orfano, volendo così cancellare la loro presenza nella sua vita.
Purtroppo, il dramma si ripeté nel rapporto con i fans: il suo fare dionisiaco, provocatorio, sopra le righe e oltraggioso, divenne troppo in fretta la sua identità: il personaggio pubblico Jim, istrione sul palco e nella vita, un modo in cui cercava, a mio parere di comunicare anche la propria fragilità e il proprio bisogno di essere visto (provate a cercare quanti riferimenti allo sguardo e agli occhi ci sono nelle sue canzoni!) si rivelò un boomerang, che fece sentire a Jim che le persone vedevano il mito (d’altronde Narciso crede di trovare nell’acqua un’altra persona e poi, quando capisce che è solo un suo riflesso, impazzisce) ma avevano perso completamente di vista il suo vero Sé autentico (fatto anche di aspetti narcisisticamente fragili e legati al bisogno di riconoscimento e approvazione) nascosto e spaventato dietro la maschera della rockstar.
Ancora oggi si pensa ai grandi del rock come personaggi persi tra vizi e trasgressioni, invece ci sono stati intellettuali come Jim: tra le sue letture, oltre a Nietzsche, Blake e Rimbaud, spuntava fuori anche Ferenczi. Ed è altrettanto noto l’interesse di Peter Gabriel per Jung. A tuo avviso come mai tante rockstar di quella generazione hanno voluto esplorare l’area dell’inconscio?
La psicoanalisi non ha scoperto l’inconscio ma il suo fondatore Sigmund Freud è stato il primo a dire: “Sapete che l’inconscio può essere conosciuto, compreso, interpretato? E sapete che ha una grande influenza in quello che fate?”
Penso che questo abbia reso l’inconscio un tema affascinante e ricco di suggestioni, l’artista spesso vive l’esperienza di creare opere che non erano consapevolmente presenti nella sua mente: nel libro, ad esempio, parlo di Tommy e della sua origine inconscia che riguarda le esperienze traumatiche vissute da Pete Townshend nell’infanzia.
Penso che cantanti e musicisti, avendo la possibilità di dedicarsi a un’arte frutto del dialogo tra più ambiti (testo, canto, musica) siano ancora più sollecitati su questi temi: il talento artistico, la forma che prendono le canzoni, accorgersi, magari dopo la pubblicazione, che l’album contiene aspetti personali che non erano previsti. D’altronde lo stesso Freud in uno scritto del 1906 disse che i poeti “nelle conoscenze dello spirito sorpassano di gran lunga noi comuni mortali, poiché attingono a fonti che non sono state ancora aperte alla scienza”.
L’artista è continuamente alla ricerca, la creatività (caratteristica di ogni essere umano) nel suo caso può prendere forme molto intime, profonde, apprezzate, ascoltate ma mai così direttamente esplicite, dirette nei significati: “Perché ciò che volevo esprimere ha preso questa forma?” è una domanda che immagino spesso gli artisti si pongano. Credo che in questi momenti la curiosità di sapere qualcosa in più sulla mente, il suo funzionamento e l’inconscio possa farsi sentire, e nessuna disciplina può offrire spunti migliori della psicoanalisi.
Gli anni ’60 e ’70 sono stati l’epoca dei concept e delle opere rock, occasioni ghiotte per raccontare delle vicende più ampie e sulla scia della cultura psichedelica molti provarono ad andare nel profondo. Pensiamo agli Who del già citato Tommy e ai Pink Floyd di Dark Side. L’esigenza di parlare di un’area oscura non faceva così paura, che ne pensi?
Altra domanda molto stimolante!
La mia idea è che spesso l’opera d’arte non sia un punto d’arrivo, il risultato di qualcosa che è stato previsto ed elaborato appieno prima di prendere una forma creativa; penso che spesso sia un punto di partenza che permette di intraprendere un viaggio verso parti più profonde di sé e, in generale, dell’animo umano. La caratteristica dell’opera d’arte di essere, come dice la filosofa Susanne Langer, una rappresentazione simbolica del sentimento umano, significa proprio questo: non ci troviamo di fronte a un lavoro che è ‘specchio’ dell’anima ma che è una trasformazione di aspetti del Sé, alcuni dei quali sono dentro l’opera ma inconsci, non riconosciuti, messi in forma simbolicamente creativa e, quindi, da maneggiare con cura, proprio per questo loro essere non del tutto chiari all’autore stesso.
Facciamo l’esempio di Dark Side of the Moon: nel capitolo in cui ne parlo, e in cui immagino Roger Waters che va in terapia da una psicoanalista londinese, il punto che ho voluto sottolineare è che, a mio parere e nel mio personale ascolto, Dark Side parla molto più di Syd Barrett di quanto lo stesso Roger immaginasse e abbia sempre riconosciuto; ma parla anche dell’angoscia dello stesso Roger, amico fraterno di Syd, cresciuto con lui, facendo le stesse esperienze, che lo vede crollare drammaticamente, e si chiede: “E se non fosse tutta colpa dell’LSD? Potrebbe capitare anche a me? Siamo tutti vulnerabili alla malattia mentale?”.
In questo senso penso che l’arte permettesse di entrare in contatto con angosce e paure profonde che sarebbe stato molto difficile affrontare attraverso le semplici parole, perché sarebbe stato un piano di contatto ‘senza filtri’, troppo diretto.
Quattro figure nordamericane ti hanno dato l’occasione per entrare in contatto con l’identità, la depressione, il dolore e la rinascita: Bob Dylan, Bruce Springsteen, Neil Young e Patti Smith. Cosa li ha accomunati?
Nella mia esperienza di appassionato di musica, li ho incontrati in momenti della vita mentalmente diversi, anche se cronologicamente ravvicinati: Bob era uno dei cantanti preferiti di mia mamma e ricordo con nostalgia ed emozione tanti pomeriggi in cui lo ascoltavamo e cantavamo insieme, sentivo che c’era qualcosa di speciale in quelle canzoni che mi rilassava e mi cullava durante i pomeriggi della preadolescenza, alle Medie.
Bruce è arrivato in Prima Liceo con Born in the Usa e fu una bomba, il suo entusiasmo ‘adolescenziale’, il suo rock così coinvolgente mi contagiò e mi fece sentire vivo. Conobbi Neil pochi anni dopo sulle note di After the Gold Rush e in quel disco ritrovai quella vena depressa e annoiata che si era impadronita di molte mie giornate; Patti è arrivata anni dopo, verso i venticinque anni, dandomi la sensazione che la sua autenticità, la sua attenzione a non farsi condizionare fosse un monito importante per ognuno di noi, un consiglio di tenere a mente per la vita. E nell’intervistarla nel 1975 a New York, come racconto nel libro, ci tenevo proprio a sottolineare questo punto!
Direi, quindi, che ciò che li accomuna è che con il loro talento e la loro musica sono riusciti a permettermi di entrare in contatto e dare voce a parti di me stesso, e questa è la straordinaria forza dell’arte.
Credo che questo legame personale così solido e sempre presente mi abbia permesso di immaginare dei racconti in cui la realtà storica si mescola con la fantasia, dando vita a storie che molti lettori hanno paragonato a dei sogni, e mi sembra un’idea azzeccatissima.
Patti è una delle poche figure femminili in un’epoca in cui dominava il maschile. Uno psicologo come potrebbe interpretare questo dato storico-sociologico?
Durante alcune presentazioni mi è stato fatto notare come ci sia una sola artista donna nel libro: questo rispecchia la mia esperienza di ascoltatore, avendo voluto scrivere di artisti che mi hanno accompagnato per molto tempo, il risultato non poteva che essere questo: solo negli ultimi vent’anni ho iniziato ad ascoltare molte più artiste, ad oggi Mary Gauthier, una straordinaria cantante americana che ha scritto canzoni commoventi e magnifiche sulle sue esperienze traumatiche, è il mio artista preferito in assoluto.
In adolescenza, però, Janis Joplin era quasi un’eccezione e penso che questo fosse un po’ l’abitudine di tanti, le artiste donne avevano poca visibilità, c’era un clima tendenzialmente ‘maschilista’, una sorta di associazione inconsapevole rock-maschio, risalente ai decenni precedenti ma che si è fatto sentire fino agli anni Novanta. Sicuramente tutto questo ha delle origini storiche, sociali e culturali, e io ci sono passato senza dargli particolare importanza.
Fortunatamente i tempi sono poi cambiati, e ho potuto conoscere grandi artiste, come Lucinda Williams, Dolores O’Riordan, Tracy Chapman, PJ Harvey, che apprezzo e ascolto soprattutto per la loro straordinaria sensibilità umana.
Hai scelto di soffermarti su alcuni protagonisti degli anni ’60 e ’70. Se tu volessi arrivare all’oggi, passando dagli anni ’80 e ’90 dei vari Bono, Michael Stipe, Michael Jackson, Prince e Kurt Cobain, troveresti un analogo dialogo tra psicoanalisi e rock?
Penso proprio di sì!
Penso che la musica cambia, si trasforma, i suoni, il modo di scrivere e cantare risentono sempre del periodo storico e culturale ma il significato che ha l’arte non cambia: offrire uno spazio dove, ad esempio, la rockstar può portare delle parti di Sé, sentire che l’album funge da contenitore e le persone lo ascoltano.
Come non commuoversi, ad esempio pensando che la prima canzone del primo album degli U2, I will follow, è un richiamo che Bono sente di dover fare alla propria madre scomparsa anni prima tragicamente? E la mia passione è mettermi in ascolto e provare a ‘sentire’ che cosa la musica sta comunicando: lo faccio spesso in una forma onirica, creativa, un po’ come nel libro, che non è certo una raccolta di schede ‘musicali’ o ‘psicologiche’, ma un gesto di gratitudine e dialogo personale con gli artisti che amo. Questo è stato un bisogno che ho sentito scrivendo, insieme al desiderio di dire a tutti gli appassionati: non ascoltate solo la rockstar ma provate a ‘sentire’ anche la persona, perché sono la stessa cosa; non esiste un Jim cantante e un Morrison uomo: facendo così ne sacrifichiamo una parte autentica!
Se ci sarà un secondo libro, terrò sicuramente conto dei tuoi suggerimenti! E qualche spazio lo vorrei offrire anche a Nick Drake, Vic Chesnutt e Ozzy Osbourne… ma anche a Lucinda Williams, Dolores O’Riordan, Mary Gauthier!