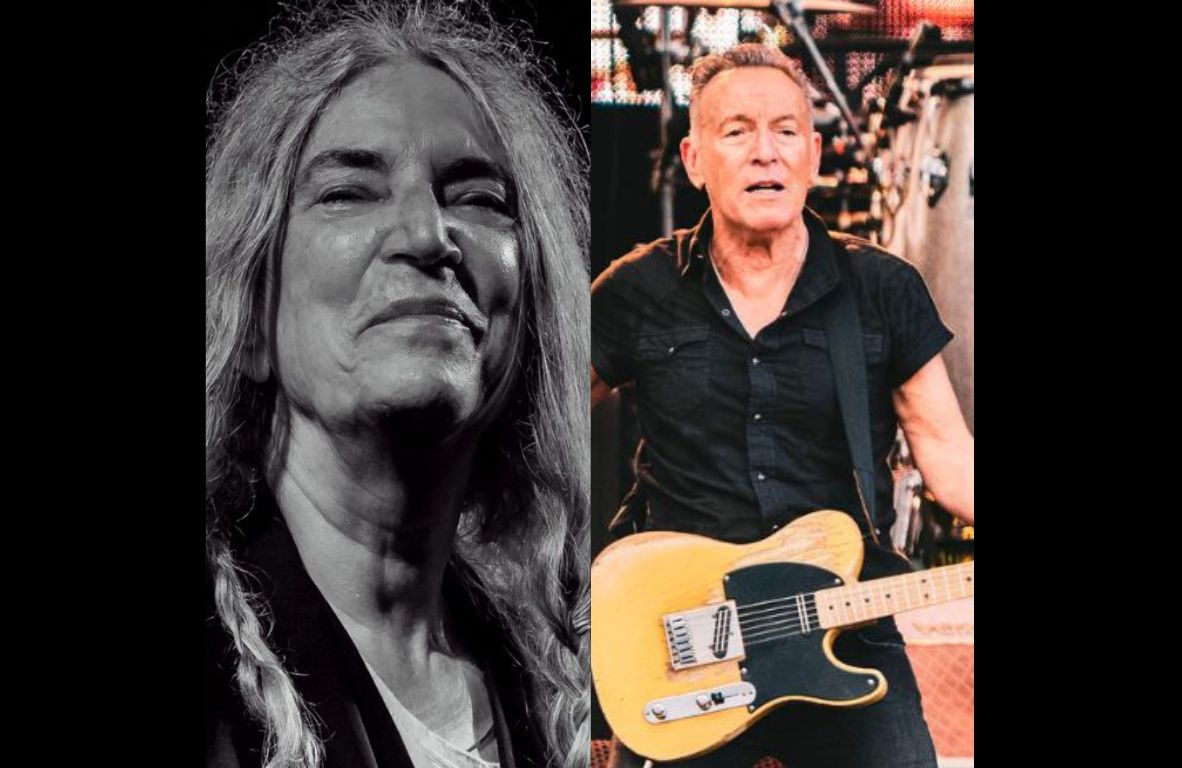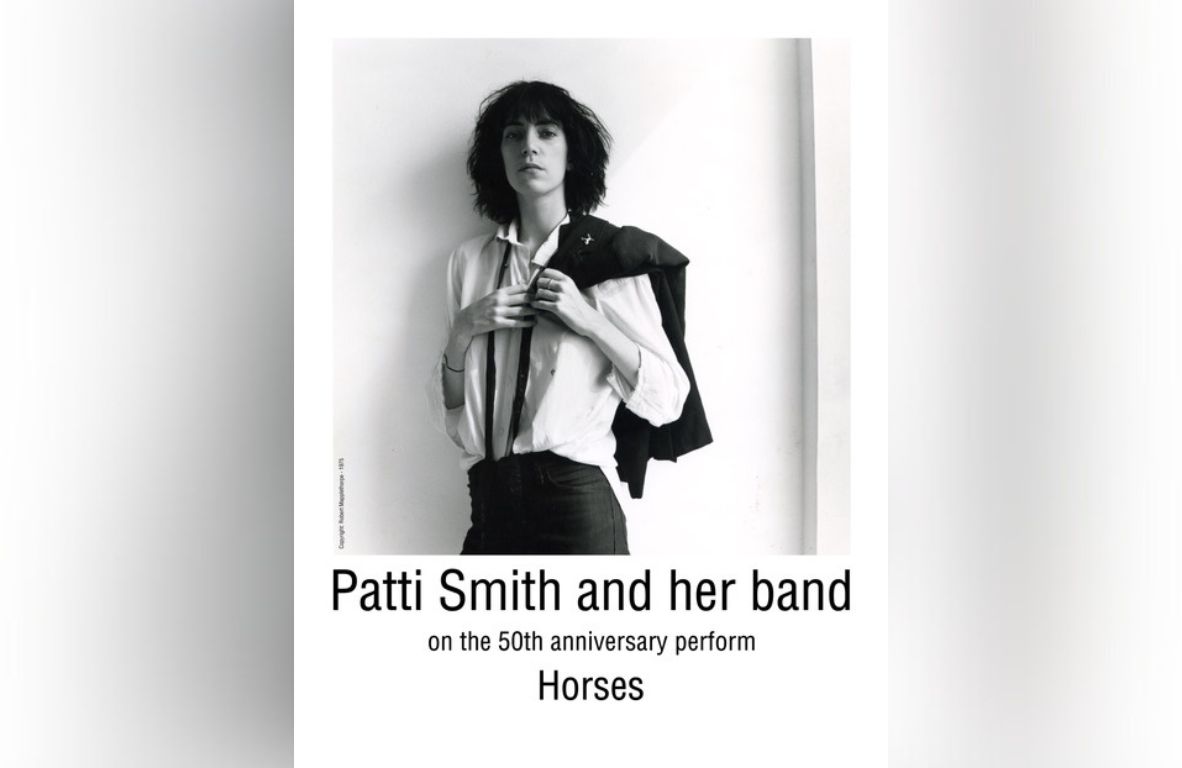L’annuncio della pubblicazione di un nuovo album di Patti Smith è sempre accompagnato da un turbinio di sentimenti che vanno dalla gioia alla curiosità spasmodica, il tutto permeato da un’unica certezza: comunque vada, non potrà passare inosservato. Inoltre, pensare all’esiguo numero di album pubblicati dall’autrice di People Have The Power in ormai quasi quarant’anni di carriera, lascia sempre una certa sensazione di malinconia: da un lato sembra di aver avuto solo in parte la possibilità di attingere dall’animo di una delle autrici più importanti degli ultimi cinquant’anni, e dall’altro per l’inevitabile retrogusto di amarezza legato a vicende personali che ne hanno segnato esistenza e carriera artistica. Anche Banga, che esce a distanza di cinque anni da Twelve, è un disco sofferto, ma in questo caso più per i contenuti che per il momento attraversato dalla cantante americana: la signora Smith sembra infatti aver ormai fatto pace con la vita, aver combattuto i propri demoni e trovato la pace interiore a lungo cercata. Dotata di una gentilezza rara, in grado di mettere a proprio agio già dopo pochi secondi passati in sua compagnia, Patti non ha perso quella curiosità e quella voglia di lottare per i propri ideali che sono da sempre il vero filo conduttore della sua poetica.
Credo che Banga sia uno degli album più onesti e intensi della tua carriera o comunque dal tuo ritorno sulle scene a metà anni ’90. Sei d’accordo?
«Non ho la pretesa di dirti se è il mio album più onesto, di sicuro è molto intenso. Non ho problemi a definirlo un album rock a tutti gli effetti. Penso che le ragioni siano da ricercare in un paio di aspetti fondamentali della mia vita: innanzitutto, negli anni, ho accumulato un sacco di esperienze che hanno arricchito la mia anima. Inoltre lavoro con musicisti che sono fonte d’ispirazione continua per la mia arte. Infine, sono riuscita a mantenere un approccio entusiastico nei confronti della vita, ogni giorno incontro cose in grado di ispirarmi e sono sempre in azione: lavoro in continuazione. Lavorare per me è fondamentale».
Perché hai deciso di concludere l’album con After The Gold Rush di Neil Young?
«Non volevo chiudere l’album con un testo apocalittico come quello di Constantine’s Dream: temevo che un testo molto dark, come del resto il mood dell’intera canzone, potesse lasciare un senso di sgomento nell’ascoltatore. Di colpo ho pensato alla prima strofa del brano di Neil Young: “Well, I dreamed I saw the knights in armor…” e ho capito che era perfetto. Anche lui parla di un sogno e lo fa con lo stesso linguaggio del mio brano, ma senza il senso di angoscia di cui ti parlavo. Inoltre, Neil ci ricorda che abbiamo tirato troppo la corda nei confronti della natura, che spesso ci presenta il conto in modo drammatico e devastante, ma mi è sempre piaciuto il fatto che il brano si concluda con un grande senso di speranza nel futuro. Quello che ho io in questo momento drammatico».
Forse il finale mi ha influenzato, ma mi sembra che la presenza di Young aleggi un po’ in tutto il disco…
È uno dei miei artisti preferiti e mi ritrovo molto spesso a cantare suoi brani in sala di registrazione; quindi, magari non intenzionalmente, credo di essere costantemente influenzata dalla sua poetica e dalla sua sensibilità. Maria, per esempio, mi ricorda in qualche modo lo stile di Neil: è un pezzo molto classico scritto dal mio bassista, con all’interno un ruvido assolo di mio figlio Jackson che dà un tocco anni ’70 al tutto. Le parole mi sono uscite di conseguenza: parlo proprio di quel periodo, di quando scrivevo Horses e di quando conobbi Maria Schneider. È il pezzo più nostalgico del disco».
Sembra anche uno dei brani portanti…
«In un certo senso lo è. Pur essendo molto semplice dal punto di vista musicale, uno dei più accessibili, è di sicuro uno dei più complessi per quanto riguarda le emozioni che mi ha evocato. Parla dello scorrere del tempo, di Maria, del suo guardare con nostalgia al passato, a quando era giovane, ma in realtà parla di me».
Grazie alla tua capacità di fondere due mondi apparentemente opposti, sei riuscita a dimostrare quanto rock’n’roll ci fosse nella poesia e viceversa. In pratica sei stata in grado di realizzare il più grande sogno di Jim Morrison.
«Jim fu la mia più grande fonte d’ispirazione quando iniziai, così come Jimi Hendrix e John Coltrane. L’idea di poter comunicare alle masse attraverso la fusione tra poesia e musica rock era molto radicata nei leader della mia generazione e la cosa mi toccò profondamente fin dall’adolescenza. Quando Jim morì capimmo che quell’idea non poteva morire con lui, che avremmo dovuto portare avanti il suo discorso. Per quanto mi riguarda, ci ho provato con tutta me stessa e sono onorata di aver raccolto il testimone di un’anima così grande».
Jim voleva essere ricordato come un poeta, non come una rockstar. La musica gli serviva come mezzo per portare alla massa i suoi versi. Tu da questo punto di vista dove ti collochi?
«Jim era un poeta. Non sei un poeta solo se qualcuno lo attesta in qualche modo, lo sei a prescindere. Penso spesso a lui. Ogni volta che entro in una libreria e vedo le sue poesie tra quelle di Rimbaud e Baudelaire mi si apre il cuore, perché penso: “Alla fine sei riuscito a raggiungere il tuo scopo, Jim”. Io vorrei essere ricordata come una persona che ha lavorato bene nella vita. Mi piace pensare a me come a una lavoratrice, non potrei mai dirti che sono una poetessa, una scrittrice, una cantante, una moglie o una mamma. Lavoratrice è il termine che mi piace di più».
Banga è anche un album molto italiano, ricco di riferimenti alla nostra nazione e soprattutto alla nostra cultura.
«Ho un rapporto molto profondo con il vostro Paese. Negli ultimi anni ho passato diverso tempo in Italia, in particolare ad Arezzo, dove è stato anche registrato parte del nuovo album. Ho un legame strettissimo con la band aretina Casa del Vento, che compare infatti in diversi brani del disco. Nessun Paese è riuscito ad eccellere in tanti campi come l’Italia: pittura, architettura, scrittura, cinema e musica. In particolare, per la musica penso a Puccini e Giuseppe Verdi. Quando ero piccola ascoltavo esclusivamente artisti come Bo Diddley, Little Richard e Puccini; guardavo film italiani ed ero ossessionata dai dipinti dei grandi artisti italiani di tutte le epoche. Credo che nessun pittore, al di fuori del vostro Paese, sia riuscito a mettere su tela i temi della cristianità con quell’umanità: se si presta attenzione, si nota che nello sguardo dei personaggi ritratti è insita la consapevolezza del proprio destino e questa è una prerogativa dei pittori italiani, della loro sensibilità. Penso a Leonardo Da Vinci, a Piero Della Francesca, ma gli esempi potrebbero essere centinaia. Tra i contemporanei il mio preferito è Marco Tirelli. Della stessa sensibilità è permeata l’intera opera di Puccini: lui è lo Smokey Robinson delle arie, c’è molta Motown nella sua musica. Basta avere in casa una qualunque delle sue opere per rendersi conto di quanto ogni aspetto della nostra vita sia presente nella sua musica: essere innamorati, abbandonati, aver paura o essere arrabbiati, tutto lo spettro delle nostre emozioni è racchiuso nelle sue arie. È sbalorditivo. Poi siete la patria di Francesco d’Assisi, l’esempio più eclatante di purezza nella storia dell’umanità. Potrei parlare per anni del mio rapporto con la vostra cultura».
Quando hai scritto This Is The Girl?
«Alla fine delle registrazioni di Banga. Eravamo agli Electric Lady Studios e stavamo ormai lavorando sulle sovraincisioni di chitarra, quando abbiamo appreso la notizia della morte di Amy Winehouse. Istintivamente mi sono messa a scrivere qualche strofa, ma senza l’intento di farne una canzone, anche perché ormai eravamo alla fine dei lavori. Poi il mio bassista Tony Shanahan, già autore di April Fool, Amerigo e Maria, mi ha detto che aveva ancora un brano da farmi sentire: d’istinto ho detto di no, perché volevo assolutamente concludere il disco, ma poi mi sono accorta che i miei testi si sposavano alla perfezione con la delicatezza del brano. Ogni mia parola, ogni mia pausa sembrava pensata per quella musica. A quel punto non registrarla sarebbe stato davvero stupido, quindi in pochissimo tempo l’abbiamo incisa e inserita nella track list. Non l’ho mai incontrata di persona, ma da cantante ti posso dire che era fantastico trovare in una ragazza così giovane un’anima musicale così vicina a quella della mia generazione. Ed è stata l’ultima voce ad aver creato un intero genere».
A qualcuno verrà in mente About A Boy per Kurt Cobain…
«Due tragedie immense, due ragazzi di 27 anni scomparsi in modo apparentemente diverso, ma alla radice ci sono problematiche molto simili. Per entrambi possiamo parlare tanto di autodistruzione quanto di suicidio. Pensare che Kurt si sia ucciso con le proprie mani e che la morte di Amy sia stata invece accidentale sarebbe ipocrita. Entrambi, prima della fine, hanno dato molti segnali che chi stava loro vicino forse non è riuscito a cogliere. D’altra parte non è mai facile farlo quando la situazione è vissuta in prima persona e, in ogni caso, è troppo facile banalizzare argomenti di questo tipo».
Si avverte qualcosa che riconduce ai Doors in Nine…
«Oh cool… [prende il cd e lo inserisce nello stereo per sentirla]. Dici davvero? So io cos’è che ti fa pensare questo: è la chitarra di Tom Verlaine. Credo che quello che ha fatto Tom su questo brano sia geniale e dimostra ancora una volta il suo talento. Ha improvvisato totalmente l’assolo su un brano che, in sostanza, è davvero semplice, rendendolo simile a un pezzo di fine anni ’60. Si sentono anche echi dei Byrds. È la chitarra a dodici corde che evoca subito certe sonorità».
Molti non sanno che nei primi anni ’70 avresti potuto diventare la cantante dei Blue Oÿster Cult.
«Lo scopro ora anche io! A parte gli scherzi, è vero, ne abbiamo parlato per diverse settimane, ma alla fine giunsi alla conclusione che non era la band che faceva per me in quel momento. In primis perché ero la compagna di Allen Lanier, il loro bassista, e non volevo mischiare la vita privata con quella della band; poi perché la mia poetica si sposava solo fino a un certo punto con la loro. Devo dire però che amo molto i brani scritti insieme. Non erano certo un gruppo comune all’epoca: toccavano tematiche che nessuno osava affrontare e che ancora oggi mettono i brividi, e la collaborazione con Sandy Pearlman si rivelò fondamentale in questo senso. Sandy era semplicemente un genio, stargli vicino significava essere bersagliati da continui spunti intellettuali su cui costruire interi mondi. Infine, musicalmente parlando, erano mostruosi: tutti polistrumentisti, pieni di idee inusuali e avveniristiche».
Credi ancora che il rock’n’roll possa cambiare il mondo?
«Penso che le persone possano cambiare il mondo. Penso che il rock’n’roll possa far capire qualcosa che magari le persone hanno dentro ma non sanno di possedere. Credo che la musica possa essere ancora un veicolo molto importante per le nuove generazioni. La globalizzazione ha portato persone lontane migliaia di chilometri a utilizzare lo stesso oggetto o a conoscere la stessa cosa. Spesso, però, si tratta di cose futili o del tutto stupide. Il messaggio culturale che deve passare è ancora lo stesso che arrivò a me, adolescente del New Jersey, una terra senza cultura, dove tutto quello che apprendevo arrivava dalla radio. La radio mi diceva cos’era la guerra in Vietnam e perché decine di persone come me perdevano la vita per una causa ignobile o per protesta verso un governo criminale. Le radio mi facevano sentire Ohio di Neil Young, davano uno scopo alla mia esistenza. Per questo una canzone non può cambiare il mondo, ma può spingere le persone a farlo».
Purtroppo però la sensazione è che questo tipo di messaggio sia ancora prerogativa degli artisti di quella generazione, che oggi hanno settant’anni. Come se il seme che piantarono fosse cresciuto fino a un certo punto, rendendo il futuro incerto.
«Finché le persone manifesteranno la propria opinione, in qualsiasi campo, con qualsiasi linguaggio, ci sarà un futuro per quel tipo di messaggio. Ogni generazione è stata in grado di trovare il proprio linguaggio per contribuire alla cultura del proprio tempo: Michelangelo e Leonardo lo facevano con la pittura, Jimi Hendrix con una chitarra, altri ancora scrivendo poesie. Non esiste un campo più nobile di altri, né tanto meno un’unica via. La mia generazione ha provato a farlo con la musica, fosse questa rock’n’roll, punk o quant’altro. Certo, non tutti possono mettersi davanti a una tela e dipingere la Gioconda, per questo forse il rock si è prestato maggiormente al ruolo di veicolo verso le nuove generazioni. Il rock è il genere più democratico che esista, soprattutto se pensi che permette anche a me di riuscire a scrivere un pezzo. Conosco tre accordi e nemmeno così bene, ma anche su questo album sono riuscita a scrivere per intero un paio di brani, Banga e Nine. Non so leggere la musica, non so fare niente, ma con tre accordi si può ancora dire molto. Per questo esiste un futuro per il rock’n’roll».