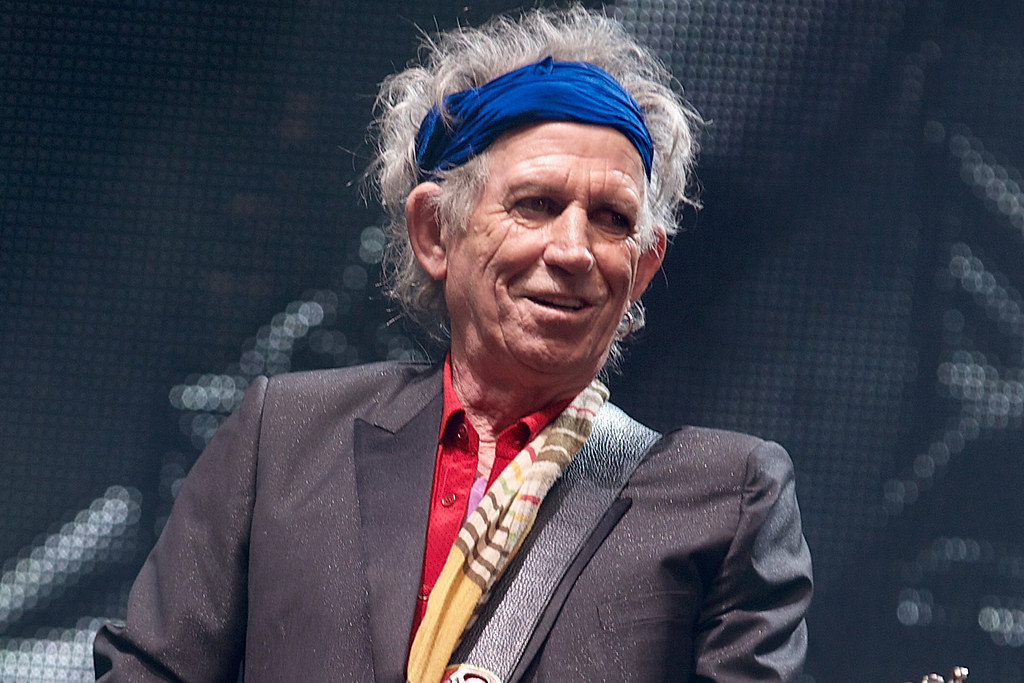Ovviamente, la porta d’entrata del Green Door Club è di colore blu. Ma è solo l’ultima, e di certo la più banale, delle tante anomalie di cui la vita di Giorgio Gomelsky è cromaticamente costellata.
Qualcuno ci chiede bruscamente di scansarci: stiamo ostruendo il marciapiede già ingombro di ponteggi e impalcature edili. Sarebbe divertente fermare il ragazzino con la t-shirt di Exile On Main Street che sta entrando nel palazzo accanto e raccontargli in quale misura il suo vicino di casa abbia influito sul suo guardaroba e sul contenuto del suo iPod. Ma probabilmente non ci crederebbe. In pochi, oggi, ricordano il nome e la storia di Giorgio Gomelsky, esiliato speciale sulla Ventiquattresima Strada. Di certo, però, non lo hanno dimenticato i Rolling Stones. Né lo ha fatto Eric Clapton. Né Jimmy Page. Né Jeff Beck. Né un sacco di altra gente che ad elencare renderebbe questa storia troppo simile a una statistica. Sì, è vero, forse non tutti, tra quelli che hanno messo la propria carriera nelle sue mani, ne hanno un bel ricordo. Ma, di certo, tutti ne hanno più di uno.
Gomelsky ci accoglie dalla cima di una ripidissima scala scricchiolante con l’aria leggermente scocciata, come se non fosse stato avvertito con sufficiente preavviso della nostra visita, ma si scusa per le perdite di acqua dal soffitto. L’appartamento, al piano superiore del club, non è nelle migliori condizioni. Una vecchia cucina ornata di stoviglie sporche; una stanza da letto che assomiglia un bordello di Istanbul; un bagno che nessuno di noi vedrà mai; gonfie macchie di umidità ovunque e il suo studio: un ammasso informe e nocivamente affascinante di monitor, tastiere, cavi, radio a transistor, posacenere stracolmi, televisori al tubo catodico, vhs non etichettate, pizze di pellicola, cd, lp, vecchie cassette audio e pile di libri alte così. Qualcuno crede anche di scorgere un ratto di notevoli dimensioni. Ma forse è solo stanco per il lungo viaggio.
Il padrone di casa ci indica un paio di vecchie sedie traballanti, di quelle che di solito si raccolgono sui marciapiedi la sera prima che gli autocarri per gli ingombranti vengano a fare giustizia. La luce è fioca attraverso le tapparelle abbassate e il caldo insopportabile. Manhattan, fuori, si prepara per la sera.
Gomelsky scarta la bottiglia di pregiato vino rosso che gli abbiamo portato in dono, si accende una sigaretta al mentolo e ci informa che ha smesso di bere per questioni di salute. Non ci offre nulla in cambio, oltre il racconto della sua vita. «Mi piacete perché avete portato il vostro culo fin qui», ci dice lisciandosi il pizzetto vagamente mefistofelico. «Beh? Iniziamo?».
La vita di Giorgio Gomelsky sembra uscita da un romanzo d’appendice. Di quelli peggiori, però. Quelli dove le sparano talmente grosse che tanto, comunque, neppure la casa editrice si aspetta in cuor suo di venderne una copia.
Il protagonista: cittadino svizzero di origini georgiane. Nasce nel 1934, probabilmente su un battello al largo di Genova. I suoi primi ricordi in assoluto sfrecciano sulla Bugatti Roadster di famiglia tra le curve a gomito della corniche di Montecarlo. Sua madre, c’informa, era di quelle parti. Per un motivo o per l’altro, il giovane Giorgio cresce però a Locarno, nella Svizzera italiana. Neppure maggiorenne lascia la famiglia per evitare un futuro scritto come un epitaffio e una paternità tutt’altro che desiderata. A Dover, appena sbarcato, riesce in qualche modo a convincere l’Immigrazione che i 78 giri di Charlie Parker e il Capitale di Marx nella sua valigia non sono necessariamente indice di pericolosità. Gli agenti, ingenuamente, gli credono e lo lasciano proseguire in treno verso una Londra ancora post bellica, i cui rossi muri in macerie sono swinging solo nel senso sbagliato. Poco dopo, grazie a una brillante Faema importata e al restrittivo orario di chiusura dei pub, aprirà il primo coffee club di un Regno fatto solo di tè bollente, birra tiepida e nebbia gelida. Le rivoluzioni iniziano anche dai cappuccini.
Il suo amico Harold Pendleton, ex boss del Marquee Club, lo ricorda come uno straniero piuttosto interessante. E all’epoca, irlandesi a parte, non è che si vedessero tanti stranieri in quella città scoraggiante e buia. Soprattutto se in cerca di opportunità nell’ancor più buio mondo dell’imprenditoria jazz. «Giorgio s’intrufolò nel mio ufficio verso metà degli anni ’50. Non sapevo da dove venisse, né se fosse svizzero, russo, italiano, o che diavolo altro. Per me era solo uno straniero affascinante. E ipnotico. Assomigliava a Rasputin». Pendleton ne ricorda anche un caratteraccio scorbutico e con vaghe tendenze maniaco-depressive quando, dal backstage del Marquee, dopo qualche vodka di troppo, amava attaccare sul senso della vita e altre sciocchezze tanto care ai ventenni di ogni tempo.
Incontriamo Pendleton sotto il sole di Ascona. Lui e sua moglie Barbara, nel loro meritato buen retiro, hanno tutta l’intenzione di non perdersi neppure uno dei tanti concerti jazz, dixieland e blues che i festival musicali della regione offrono ogni estate. Ricorda molto bene quando Giorgio Gomelsky iniziò a ricamarsi un’aura da eminenza grigia ben prima di diventarlo per davvero. Ricorda, senza un briciolo di animosità, come solo i vecchi amici sanno fare, quando lo affrontò mentre cercava di invitare i clienti del Marquee a seguirlo fino al Crawdaddy, il locale di cui Giorgio era diventato padre-padrone nei primissimi ’60. E il cinismo col quale, in un miscuglio di accenti esotici, aveva reagito ai suoi rimproveri di pirateria professionale e scorrettezza generale: «Così va il mondo, amico mio. È solo politica».
Gomelsky non ci sta a fare la parte del cattivo: «Sai, credo che ogni generazione debba distanziarsi il più possibile dalla musica della generazione precedente. Ed ero convinto che per costruire un nuovo movimento si dovesse tornare indietro; tornare indietro per costruire qualcosa di nuovo. E io volevo tornare al blues, perché tutto stava andando in malora. C’era solo lo skiffle, roba primitiva… e poi il jazz tradizionale… il folk… Nessuno credeva più nel blues! Avevo cercato di convincere Harold a fare delle serate blues al Marquee, ma lui non ne voleva sapere. E io volevo provargli che era in torto. Così, visto che mi incolpavano di rubare il pubblico al Marquee, ho affittato un vecchio albergo alla fine della District Line, lo Station Hotel di Richmond. Non si poteva andare più lontano; non potevi letteralmente andare più lontano: era la fine della District, la fine di Londra. E nessuno poteva più dirmi come fare le cose laggiù».
Alexis Korner, Cyril Davies e i Blues Incorporated erano già piccole star locali. Brian Jones, invece, non era ancora nessuno quando Gomelsky, esasperato dalla caparbietà del giovane chitarrista-armonicista, accolse la sua neonata band sulle assi del Crawdaddy, diventandone nel contempo manager ufficioso e mentore ufficiale.
Fedele allo spirito rivoluzionario di famiglia (suo padre, medico ed ex combattente nella Rivoluzione d’ottobre era abituale compagno di scacchi di Lenin), Giorgio decise che il mondo aveva bisogno di una nuova scossa. Lui avrebbe fornito i watt necessari, la giusta illuminazione e la via da seguire. I Rolling Stones, invece, energia eterna.
Scacco matto.
Se ne accorsero anche i Beatles. Furono convinti a fermarsi a Richmond per dare un’occhiata a quel sestetto – sì, erano ancora in sei – di cui tanto si parlava in giro. «Avevo incontrato i Beatles durante un viaggio ad Amburgo, così quando hanno cominciato ad avere successo sono andato da Brian Epstein e l’ho convinto a fermarsi al Crawdaddy e vedere cosa stava succedendo a Londra». La più celebre rivalità pop di tutti i tempi nacque quella sera del 1963. Durò solo un paio d’ore, però: dopo il concerto, nell’appartamento di Brian e Keith a Edith Grove, le due band ratificarono un’amicizia secolare, scambiandosi accordi e progetti per il futuro sotto gli occhi a fessura di Gomelsky.
«I Beatles dovevano fare un concerto alla Royal Albert Hall e ci avevano regalato i biglietti per andarli a vedere. Alla fine della serata, mentre gli altri davano una mano ai roadie a caricare le casse sul furgone, io e Brian [Jones] uscimmo fuori dal camerino degli artisti per andarci a prendere un tè. Appena fuori, però, Brian venne assalito da decine di ragazzine isteriche che piangevano e gridavano “Autograph!”. Non so perché: Brian era biondo e nessuno dei Beatles lo era. Forse quelle non erano riuscite ad entrare al concerto. O forse non si ricordavano le facce dei Beatles e lo hanno scambiato per uno di loro. Brian mi chiese cosa doveva fare. Gli risposi: “Che te ne importa? Firma, firma!”. Quando la situazione si fece incontrollabile riuscii a strapparlo via e scappammo verso quella scalinata monumentale dietro l’Albert Hall ridendo. Appena ci fermammo per riprendere fiato, Brian mi prese per il braccio e mi guardò serio negli occhi. Era pallido… impressionato da quello che gli era appena successo. “È questo quello che voglio, Giorgio. È questo!”. Gli ho risposto che l’avrebbe avuto, ma che doveva essere pronto a pagarlo caro».
Se la stima tra i componenti delle due band si rivelò a tutti gli effetti lunga e solida, l’ascendente di Gomelsky sugli Stones durò molto meno. Jones e l’apprendista impresario Andrew Loog Oldham (uomo pronto a promettere molto più di quanto Giorgio fosse disposto a mantenere) attesero la morte del padre di Giorgio per far scattare il golpe. Gomelsky ne fu informato solo dopo il suo rientro dal funerale in Svizzera. Poco male: aveva già riconosciuto in un’oscura band dei sobborghi, e nel suo timido chitarrista, il nuovo sound della rivoluzione.
Gomelsky fece degli Yardbirds ciò per cui ancora oggi sono sostanzialmente noti: l’unica band al mondo che può vantare tra le proprie fila tre dei quattro più grandi chitarristi mai visti prima di allora. Il rapporto tra Giorgio ed Eric Clapton, però, si rivelò da subito ruvido: d’accordo, impossessarsi di una sua composizione originale e accreditarsela con lo pseudonimo di O. Rasputin non è forse il modo migliore per un manager di salvaguardare la carriera di un musicista. Ma, stando alla biografia del chitarrista, sembrerebbe proprio che a Gomelsky della serenità del suo pupillo più promettente importasse pochino. Giusto quel tanto per fargli lasciare la band in modo più o meno spontaneo. Di poco migliore si rivelò la relazione con Jeff Beck, chiamato a sostituire Clapton dopo il suo allontanamento. E con Jimmy Page, curiosamente impiegato nei primi tempi come bassista.
Degli Yardbirds post Clapton, ormai eletto a Dio dai muri della capitale inglese, se ne accorse anche il cinema. Nel ’66 Michelangelo Antonioni li volle e li ottenne per il suo Blow-Up, schizzo in technicolor della neonata Swinging London. Il colpaccio risultò però il canto del cigno per il brillante sodalizio. «La storia del rock, di solito, è fatta di band umorali e manager pacati», ci ricorda saggiamente Pendleton, «ma nel caso di questa band le cose funzionavano esattamente al contrario!». Fino a quando il gruppo non ne ebbe abbastanza e licenziò il manager.
Gomelsky, per nulla fiaccato, continuò per il resto del decennio a irrobustire il suo nome come impresario, produttore discografico e talent scout dal fiuto infallibile. Il suo ufficio di Chelsea accoglieva gente come Rod Stewart, Soft Machine, Vangelis e un sacco di altre persone che si sarebbero fatte notare in futuro. Giorgio riuscì addirittura a fare della presidentessa del fan club degli Yardbirds, Julie Driscoll, la metà di un duo di forte impatto commerciale, accoppiandola con il virtuoso dell’Hammond Brian Auger e producendole gli album migliori. Le cose andavano bene: i vertici della Polydor lo corteggiavano mentre lui fondava etichette discografiche, battezzava studi di registrazione e ordiva sempre più in grande. Sembrava davvero che in città ci fosse un nuovo Re.
31 dicembre 1969. Un giorno importante. Che succede non è chiaro. Forse l’incontro con una nuova donna. Forse dei problemi di affari. Forse tutt’e due. Di sicuro c’è solo che Gomelsky decide di mollare tutto, seconda paternità compresa. E tanti auguri.
Con noi è schivo. Ci dice semplicemente che era stanco. Stanco di vedere la gente con la quale aveva cominciato tradire la causa, quale che fosse, e suonare negli stadi solo per soldi. Stanco della routine della sua vita. Un Nuovo Ordine che ha cambiato il volto della cultura pop per sempre e il fantasma di Charlie Parker che lo sfida: tutto qui quello che sai fare?
Oltremanica, a Parigi, si occuperà principalmente degli alfieri dell’art rock francese Magma, cercando di trasformarli inutilmente in icone generazionali. Sette anni lunghissimi e logoranti. E come è andata a finire lo sappiamo: i Magma non sono diventati i Pink Floyd, la lingua kobaiana è rimasta vocabolario per pochissimi progressive freaks, e l’esplosione del punk ha seppellito qualsiasi possibilità di commistione tra incorruttibilità artistica e cultura commerciabile (trapassando, alla fine, con esse). Il resto è pura, spietata, vita da romanzo: l’ennesima donna incinta che gli indica le sue responsabilità; un altro viaggio solitario; New York; un lucroso impiego presso la RCA; la promessa – mai mantenuta – di un’etichetta discografica tutta sua; la voglia di sovvertire di nuovo le regole; la no wave sulle assi traballanti di un nuovo club underground tutto suo (il Green Door Club dell’inizio di questo scritto); gli anni che passano; l’ennesimo, timido enfant prodige di cui non si prenderà cura a sufficienza (un giovanissimo Jeff Buckley che usa il Green Door come sala prove); e, in definitiva, un’integrità a prova di bomba.
«Quando la musica cambia, le mura della città crollano», declama ai suoi ospiti in uno sbuffo di fumo e menta.
La rivoluzione può attendere.
Sempre che non ci sia già stata.
Ha collaborato Fabrizio Coli