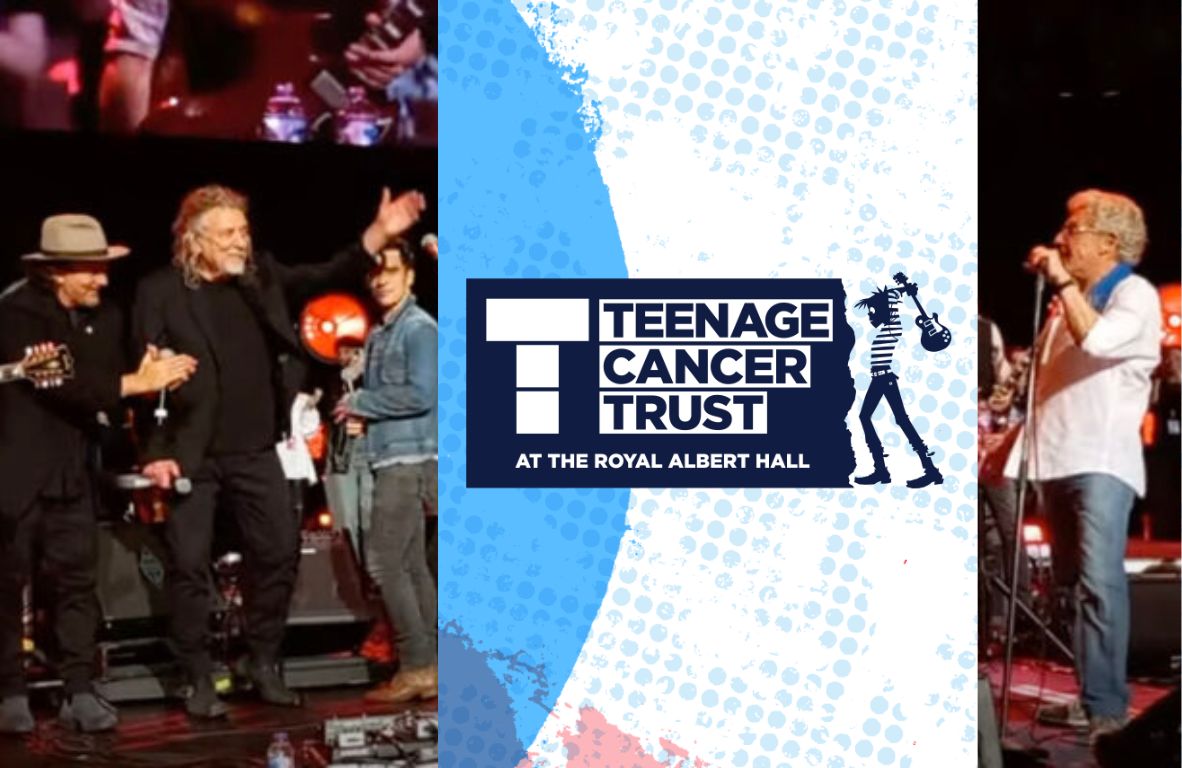Il testo di Yellow Leadbetter, brano di chiusura di gran parte dei concerti dei Pearl Jam, non ha una versione definitiva. Eddie Vedder se lo aggiusta sul momento, a seconda dell’umore della serata, verrebbe da dire, ma c’è una strofa che rimane costante e che recita “And I know, and I know I don’t wanna stay”. Quando il frontman della band di Seattle pronuncia queste parole durante il bis del concerto milanese (primo dei tre italiani di questo 2018), lo si vede chiaramente scuotere la testa, sorridendo, come a dire “no, non lo penso, perché è qui che voglio stare”.
Un piccolo gesto, quasi impercettibile ma estremamente significativo, se visto alla luce delle poco incoraggianti premesse (la laringite di Vedder che fa saltare la seconda data londinese e mette in forse le successive italiane), e che la dice lunga sulla passione che anima questi ragazzi e sul legame speciale con il pubblico italiano.
Un legame antico, più volte sottolineato e ribadito da Vedder e testimoniato da esibizioni sempre generose. Come quella di venerdì sera, appunto, in cui pure la voce del 53enne di Evanston è palesemente sotto tono. Lui ne è consapevole e non lo nasconde, da subito chiedendo aiuto al pubblico, invitato a unirsi alla band sulle note di Release. Fa fatica Eddie, la voce si spezza più volte e lui prende fiato appena può. Lo soccorrono i compagni, certo: Mike McCready sfoggia tutto il suo virtuosismo misurandosi con Eruption dei Van Halen (non sfigurando affatto), e persino Stone Gossard canta, intonando (senza sbagliare l’attacco, come invece gli era successo in passato) Mankind. Pause preziose, evidentemente, in cui ricaricare le pile delle corde vocali, e permettersi poi performance molto sentite e riuscite con brani per nulla scontati come I Got Id e Footsteps, probabilmente, quest’ultima, un omaggio al compianto Chris Cornell che ne aveva cantato una sua versione (intitolata Times of Trouble) all’epoca dei Temple of the Dog. Alla fine, dopo (solo) due ore di concerto e la spia della riserva accesa da un pezzo, Vedder si arrende e, forse pensando anche ai concerti a venire, saluta il pubblico, che capisce e ringrazia: tutti sembrano comunque soddisfatti e molti dicono “andrà meglio a Padova o a Roma”.
E dicono bene perché in Veneto, soltanto due giorni dopo, è proprio un’altra musica. Sarà che è una bella e dolce serata estiva, sarà che lo stadio Euganeo è colmo come quando il Padova giocava in serie A, sarà che il cortisone fa miracoli, ma la voce di Eddie sembra rinata. Se a Milano la stessa scaletta denunciava la volontà di non correre rischi, pescando fra i classici della band e limitando al massimo le escursioni fuori pista, qui i Pearl Jam mettono subito le cose in chiaro: siamo in gran forma, sembrano dire, e stasera ci divertiamo. Si attacca con Pendulum. La gente si guarda e dice “beh…mica male”, ma è con la canzone successiva, Low Light, che sono tutti d’accordo: “Eddie sta bene” è il commento generale. E sulle note altissime di Last Exit viene spazzato via ogni dubbio. Definitivamente. Il resto è un crescendo di emozioni e di musica di altissima qualità e, spesso, velocità, come quando la band dà sfogo alla propria anima grunge con brani come Spin the Black Circle (dedicata a Jack White, dichiarato amante del vinile) e Mind Your Manners. Uno a uno vengono toccati tutti gli LP della band (con l’unica eccezione di Backspacer). Tecnicamente parlando, non ci sono canzoni nemmeno di Riot Act (loro settimo album) ma c’è Down, uscito all’epoca come b-side del singolo I Am Mine e forse nemmeno questo è un caso. La canzone infatti contiene il verso “You Can’t Be Neutral On A Moving Train” (“Non puoi rimanere neutrale su un treno in movimento“), già titolo dell’autobiografia di Howard Zinn, storico radicale americano, morto nel 2010 a 88 anni, e amico della band. Nel 2004, durante il Vote For Change Tour (che si proponeva di impedire il secondo mandato di George W. Bush alla Casa Bianca), Zinn, allora professore emerito del Boston College, fu invitato sul palco del Fleet Center di Boston durante il concerto dei Pearl Jam a testimoniare il proprio sostegno. Ora che tempi altrettanto bui sembrano essere tornati, i cinque di Seattle, che non hanno mai nascosto le proprie idee progressiste, non le mandano a dire: “Se mi chiamassi Ivanka, sputerei in faccia a mio padre e gli darei un calcio nelle palle”, dice in italiano Eddie prima dell’attacco di Daughter. Certo, se si pensa a come andarono poi le cose con Bush, c’è poco da stare allegri. Il male può manifestarsi in molti modi, dice Vedder prima di Red Mosquito. Meglio trovare rifugio nella musica, che sia nelle note rabbiose della trascinante Porch o in quelle malinconiche di Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town, che nel frattempo apre la prima serie di bis. A seguire l’intensa Inside Job, con McCready alla 12 corde elettrica per quella che è sicuramente la sua canzone più bella e autobiografica. C’è spazio per le immancabili Black e Betterman e per la splendida cover di Crazy Mary, con quel diavolo di un Mike McCready che riesce a infilare l’incipit dell’assolo di Stairway to Heaven dopo aver duettato con le tastiere di Boom Gaspar. Rearviewmirror, con cui si chiude il primo encore, sembra suonata persino più veloce del solito ed è adrenalina pura. Le luci del palco si spengono, ma nessuno crede che sia finita: pochi minuti, infatti, e i ragazzi tornano ai loro strumenti. Si parte con il candore contagioso di Smile, si prosegue con la rabbia liberatoria di Alive e si chiude, come a Torino nel 2006, con un’incendiaria Baba O’Riley seguita dalla sofferta Indifference. Stavolta è davvero finita. Se Milano è stato un bicchiere di acqua fresca, Padova è stato come bere Southern Comfort direttamente dalla bottiglia: “Take a bottle drink it down“…
Due giorni dopo, martedì, si replica a Roma, Stadio Olimpico, dove “non suonavamo da 22 anni”, urla Eddie tra gli applausi. Poi imbraccia la chitarra e intona Interstellar Overdrive (dei Pink Floyd), prima cover di una serata in cui verranno eseguite anche Again Today (di Brandi Carlile), Eruption (Van Halen), Imagine (c’è bisogno di dirlo?), Comfortably Numb (ancora Pink Floyd), e la quasi immancabile Rockin’ In The Free World del loro mentore Neil Young. Prima di eseguire Imagine, Vedder dice: “Siamo via da casa e quando torneremo il nostro Paese sarà cambiato. Pace”, mentre l’intero stadio è illuminato da migliaia di smartphone e sul maxi-schermo campeggia l’immagine di un volantino virtuale, da giorni in rete, un appello al salvataggio dei migranti abbandonati in mare inviato alla Guardia Costiera insieme a un testo che fa appello al senso di umanità che ha sempre contraddistinto la Guardia Costiera Italiana. E fa un po’ specie pensare che i Pearl Jam dicano quello che nessun artista italiano ha ancora avuto il coraggio di dire. Ma in fondo è anche questa la loro grandezza e uno dei motivi per cui sono tanto amati. Vedder, sta bene, anzi no, la band sta bene. Sono maturi professionisti in cui lo spirito ribelle non si è lasciato ammansire dal meritato successo; persone genuine e serene, ma che sanno di non poter essere pienamente felici se anche gli altri non lo sono. Non possono, né vogliono, cambiare il mondo, e allora si accontentano di suonare la loro musica in giro per il mondo. In questa data romana lo hanno fatto per più di tre ore, alternando dolore e gioia, il ruvido metallo delle Fender di State of Love and Trust e la carezza gentile dell’ukulele di Sleeping By Myself, la rabbia dei disillusi di Can’t Deny Me e la soave malinconia di Just Breathe.
E scusate se è poco.
Un piccolo gesto, quasi impercettibile ma estremamente significativo, se visto alla luce delle poco incoraggianti premesse (la laringite di Vedder che fa saltare la seconda data londinese e mette in forse le successive italiane), e che la dice lunga sulla passione che anima questi ragazzi e sul legame speciale con il pubblico italiano.
Un legame antico, più volte sottolineato e ribadito da Vedder e testimoniato da esibizioni sempre generose. Come quella di venerdì sera, appunto, in cui pure la voce del 53enne di Evanston è palesemente sotto tono. Lui ne è consapevole e non lo nasconde, da subito chiedendo aiuto al pubblico, invitato a unirsi alla band sulle note di Release. Fa fatica Eddie, la voce si spezza più volte e lui prende fiato appena può. Lo soccorrono i compagni, certo: Mike McCready sfoggia tutto il suo virtuosismo misurandosi con Eruption dei Van Halen (non sfigurando affatto), e persino Stone Gossard canta, intonando (senza sbagliare l’attacco, come invece gli era successo in passato) Mankind. Pause preziose, evidentemente, in cui ricaricare le pile delle corde vocali, e permettersi poi performance molto sentite e riuscite con brani per nulla scontati come I Got Id e Footsteps, probabilmente, quest’ultima, un omaggio al compianto Chris Cornell che ne aveva cantato una sua versione (intitolata Times of Trouble) all’epoca dei Temple of the Dog. Alla fine, dopo (solo) due ore di concerto e la spia della riserva accesa da un pezzo, Vedder si arrende e, forse pensando anche ai concerti a venire, saluta il pubblico, che capisce e ringrazia: tutti sembrano comunque soddisfatti e molti dicono “andrà meglio a Padova o a Roma”.
E dicono bene perché in Veneto, soltanto due giorni dopo, è proprio un’altra musica. Sarà che è una bella e dolce serata estiva, sarà che lo stadio Euganeo è colmo come quando il Padova giocava in serie A, sarà che il cortisone fa miracoli, ma la voce di Eddie sembra rinata. Se a Milano la stessa scaletta denunciava la volontà di non correre rischi, pescando fra i classici della band e limitando al massimo le escursioni fuori pista, qui i Pearl Jam mettono subito le cose in chiaro: siamo in gran forma, sembrano dire, e stasera ci divertiamo. Si attacca con Pendulum. La gente si guarda e dice “beh…mica male”, ma è con la canzone successiva, Low Light, che sono tutti d’accordo: “Eddie sta bene” è il commento generale. E sulle note altissime di Last Exit viene spazzato via ogni dubbio. Definitivamente. Il resto è un crescendo di emozioni e di musica di altissima qualità e, spesso, velocità, come quando la band dà sfogo alla propria anima grunge con brani come Spin the Black Circle (dedicata a Jack White, dichiarato amante del vinile) e Mind Your Manners. Uno a uno vengono toccati tutti gli LP della band (con l’unica eccezione di Backspacer). Tecnicamente parlando, non ci sono canzoni nemmeno di Riot Act (loro settimo album) ma c’è Down, uscito all’epoca come b-side del singolo I Am Mine e forse nemmeno questo è un caso. La canzone infatti contiene il verso “You Can’t Be Neutral On A Moving Train” (“Non puoi rimanere neutrale su un treno in movimento“), già titolo dell’autobiografia di Howard Zinn, storico radicale americano, morto nel 2010 a 88 anni, e amico della band. Nel 2004, durante il Vote For Change Tour (che si proponeva di impedire il secondo mandato di George W. Bush alla Casa Bianca), Zinn, allora professore emerito del Boston College, fu invitato sul palco del Fleet Center di Boston durante il concerto dei Pearl Jam a testimoniare il proprio sostegno. Ora che tempi altrettanto bui sembrano essere tornati, i cinque di Seattle, che non hanno mai nascosto le proprie idee progressiste, non le mandano a dire: “Se mi chiamassi Ivanka, sputerei in faccia a mio padre e gli darei un calcio nelle palle”, dice in italiano Eddie prima dell’attacco di Daughter. Certo, se si pensa a come andarono poi le cose con Bush, c’è poco da stare allegri. Il male può manifestarsi in molti modi, dice Vedder prima di Red Mosquito. Meglio trovare rifugio nella musica, che sia nelle note rabbiose della trascinante Porch o in quelle malinconiche di Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town, che nel frattempo apre la prima serie di bis. A seguire l’intensa Inside Job, con McCready alla 12 corde elettrica per quella che è sicuramente la sua canzone più bella e autobiografica. C’è spazio per le immancabili Black e Betterman e per la splendida cover di Crazy Mary, con quel diavolo di un Mike McCready che riesce a infilare l’incipit dell’assolo di Stairway to Heaven dopo aver duettato con le tastiere di Boom Gaspar. Rearviewmirror, con cui si chiude il primo encore, sembra suonata persino più veloce del solito ed è adrenalina pura. Le luci del palco si spengono, ma nessuno crede che sia finita: pochi minuti, infatti, e i ragazzi tornano ai loro strumenti. Si parte con il candore contagioso di Smile, si prosegue con la rabbia liberatoria di Alive e si chiude, come a Torino nel 2006, con un’incendiaria Baba O’Riley seguita dalla sofferta Indifference. Stavolta è davvero finita. Se Milano è stato un bicchiere di acqua fresca, Padova è stato come bere Southern Comfort direttamente dalla bottiglia: “Take a bottle drink it down“…
Due giorni dopo, martedì, si replica a Roma, Stadio Olimpico, dove “non suonavamo da 22 anni”, urla Eddie tra gli applausi. Poi imbraccia la chitarra e intona Interstellar Overdrive (dei Pink Floyd), prima cover di una serata in cui verranno eseguite anche Again Today (di Brandi Carlile), Eruption (Van Halen), Imagine (c’è bisogno di dirlo?), Comfortably Numb (ancora Pink Floyd), e la quasi immancabile Rockin’ In The Free World del loro mentore Neil Young. Prima di eseguire Imagine, Vedder dice: “Siamo via da casa e quando torneremo il nostro Paese sarà cambiato. Pace”, mentre l’intero stadio è illuminato da migliaia di smartphone e sul maxi-schermo campeggia l’immagine di un volantino virtuale, da giorni in rete, un appello al salvataggio dei migranti abbandonati in mare inviato alla Guardia Costiera insieme a un testo che fa appello al senso di umanità che ha sempre contraddistinto la Guardia Costiera Italiana. E fa un po’ specie pensare che i Pearl Jam dicano quello che nessun artista italiano ha ancora avuto il coraggio di dire. Ma in fondo è anche questa la loro grandezza e uno dei motivi per cui sono tanto amati. Vedder, sta bene, anzi no, la band sta bene. Sono maturi professionisti in cui lo spirito ribelle non si è lasciato ammansire dal meritato successo; persone genuine e serene, ma che sanno di non poter essere pienamente felici se anche gli altri non lo sono. Non possono, né vogliono, cambiare il mondo, e allora si accontentano di suonare la loro musica in giro per il mondo. In questa data romana lo hanno fatto per più di tre ore, alternando dolore e gioia, il ruvido metallo delle Fender di State of Love and Trust e la carezza gentile dell’ukulele di Sleeping By Myself, la rabbia dei disillusi di Can’t Deny Me e la soave malinconia di Just Breathe.
E scusate se è poco.