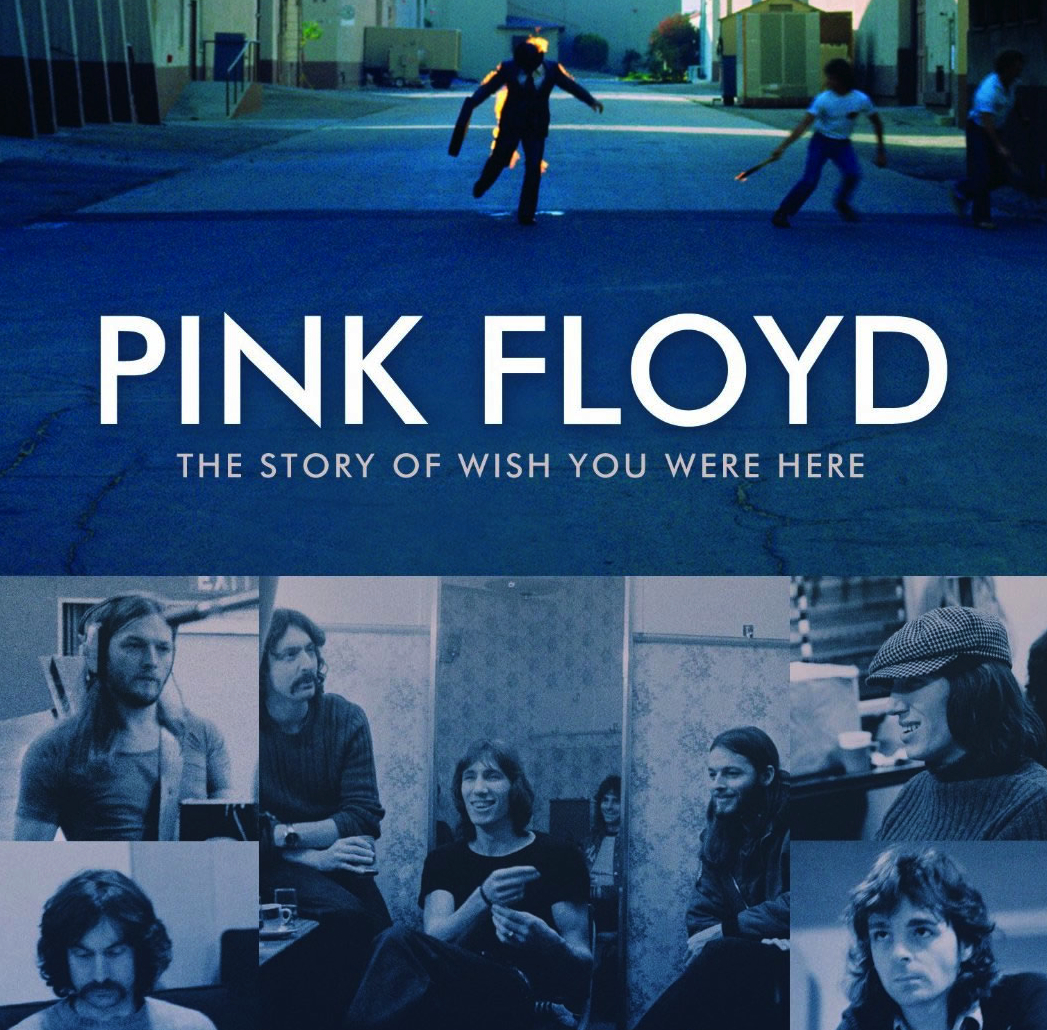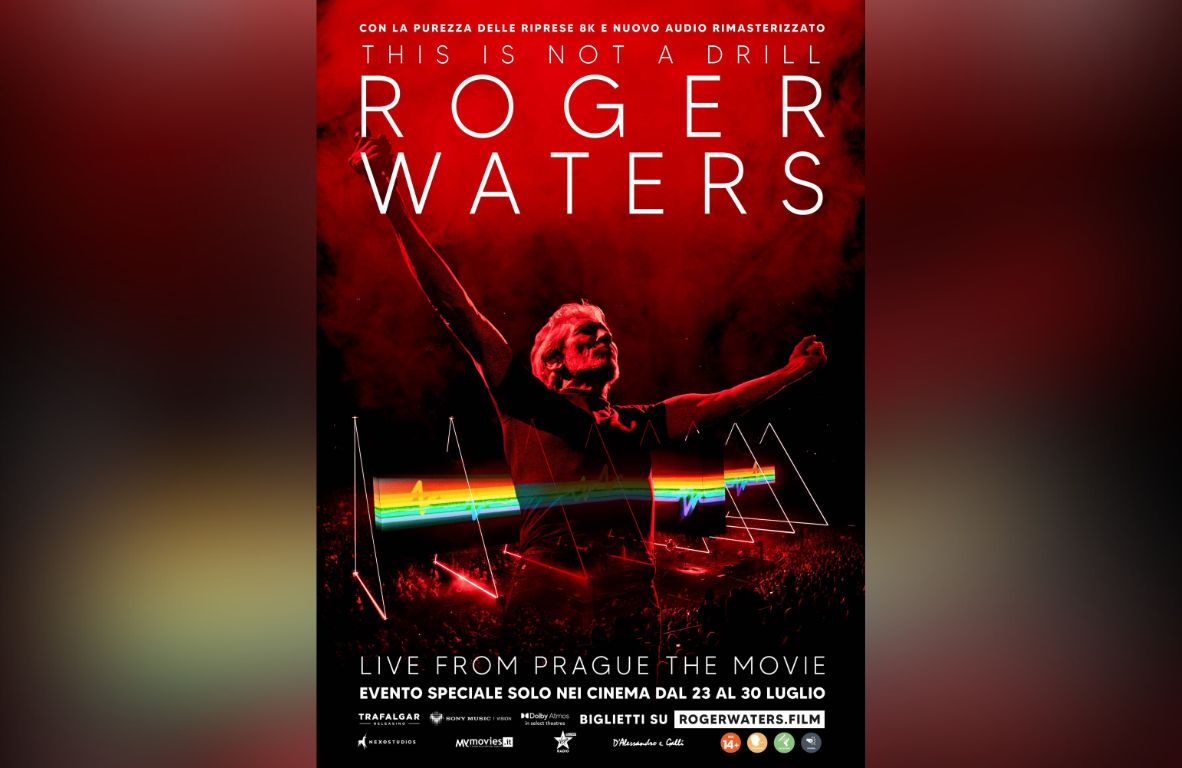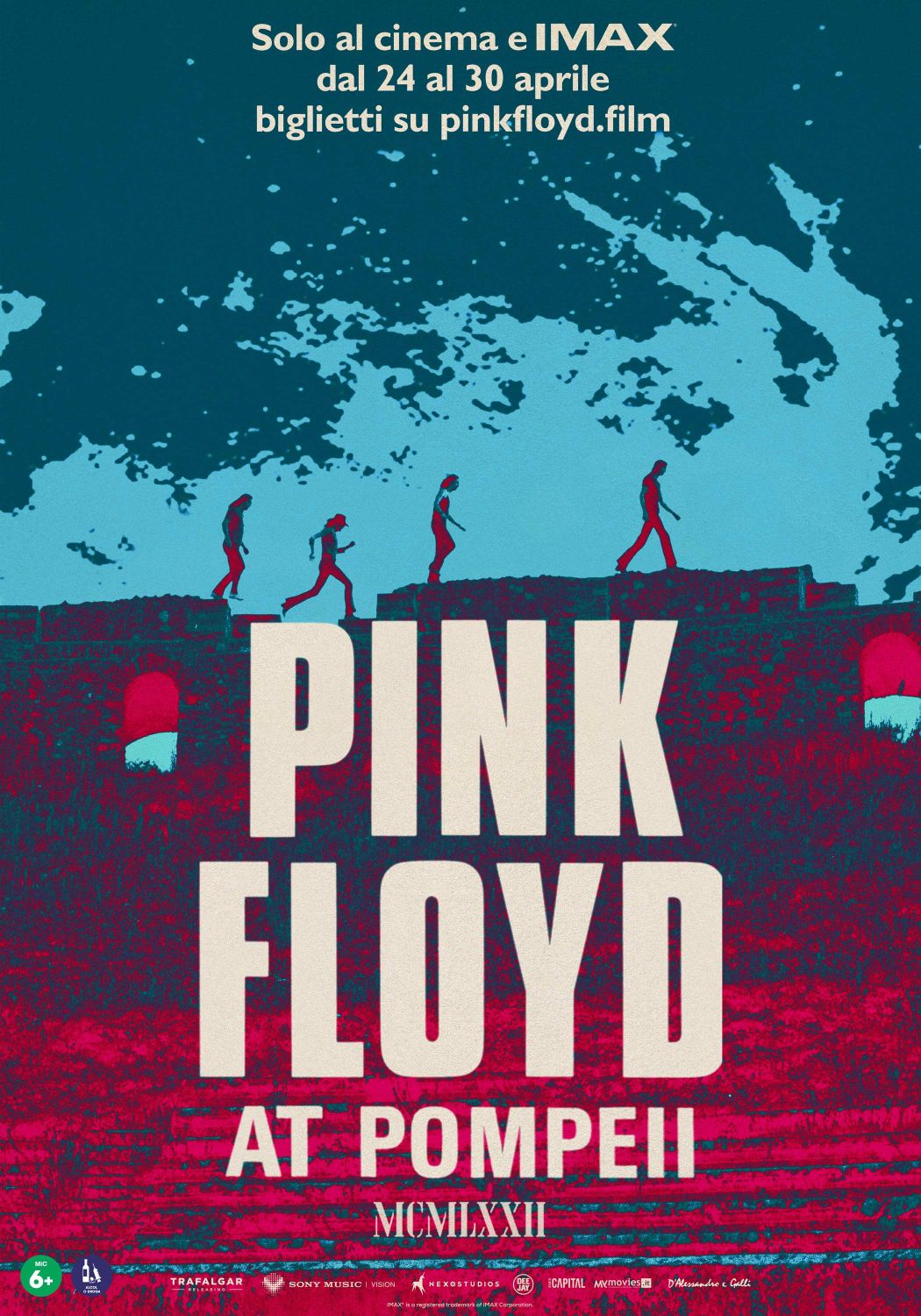L’assenza. È quello il concetto intorno al quale ruota uno dei dischi più famosi della storia del rock. «Vorremmo che fossi qui» è certamente il grido di dolore rivolto all’amico assente Syd Barrett, ma non solo. Roger Waters, ormai autore incontrastato dei testi dei Pink Floyd, prosegue infatti nel viaggio interiore che lo conduce verso una visione sempre più disincantata e spesso caustica della vita. Assenza dunque anche di valori e di forza di rialzare la testa, amare constatazioni che portano rapidamente all’altra grande tematica dell’album: l’avidità dell’industria musicale nella quale i Pink Floyd si ritrovano ormai immersi ben oltre le loro aspettative. L’album precedente, The Dark Side Of The Moon, era uscito due anni prima, nel marzo 1973. Un tale, abnorme successo da tramortire un elefante, figuriamoci quattro musicisti appena trentenni.
The Story Of Wish You Were Here è il documentario pubblicato recentemente dalla Eagle su dvd e Blu-Ray. «Avevo visto i Pink Floyd dal vivo negli anni ’60», ci dice telefonicamente da New York il regista John Edginton. «A quei tempi la band girava nei club spesso alternandosi ai Soft Machine. Cominciai a comprendere la loro grandezza verso la fine del decennio, ma poi smisi di ascoltare musica commerciale per buona parte degli anni ’70. Mi riavvicinai al rock con l’arrivo del punk e quindi, ironicamente, non ascoltai Wish You Were Here ai tempi della pubblicazione, ma molto più tardi. E credo che sia un album fantastico, uno dei migliori della band. Molti anni dopo, nel 2001, li incontrai tutti e quattro, incluso Richard Wright, per il film Pink Floyd & Syd Barrett Story. Da allora ho tenuto vagamente i contatti, perché abbiamo status diversi: io sono solo un regista, loro sono musicisti milionari. Fin quando mi è stato chiesto di lavorare a questo nuovo film».
Il documentario mette in fila moltissime interviste nuove. Viene da chiedersi quanto sia facile lavorare con superstar come i Floyd… «Sono stati tutti molto collaborativi, pur essendo profondamente diversi fra loro. Nick Mason è una persona estremamente gentile che conduce un tipo di vita differente – è un patito delle corse di automobili. Nell’intervista lo definisco “the man in the middle”, l’uomo nel mezzo, ovviamente, delle due grandi personalità della band. David Gilmour è il classico gentleman inglese: molto educato e piacevole, persino timido; non gli piace parlare di cose difficili, talvolta ho dovuto letteralmente tirargli fuori le parole con le pinze continuando a fargli domande. L’altra grande cosa di David è che è venuto ben preparato. Allo Houseboat Studio [la casa galleggiante sul Tamigi che Gilmour ha trasformato negli studi Astoria] ha suonato appositamente pezzi di Shine On You Crazy Diamond alla chitarra elettrica e Wish You Were Here all’acustica e alla 12 corde, cantandole anche. Quella di Roger Waters è una personalità molto diversa: passionale e totalmente immerso nei problemi del mondo, portatore di idee politiche forti e speciali, è uno che crede genuinamente in ogni progetto in cui è coinvolto. Anche lui, comunque, è stato fantastico, ha suonato e cantato una versione molto intensa di Wish You Were Here con la chitarra acustica, provando anche Have A Cigar».
Per lo scomparso Wright, Edginton ha attinto alle interviste del 2001. «Rick era un uomo molto modesto, l’unico della band che potevo chiamare a casa a qualunque ora, senza passare attraverso i manager. Quelle per il dvd Pink Floyd & Syd Barrett Story furono tutte interviste speciali, ma Rick in particolare si concesse molto generosamente, lui che di solito cercava solo di compiacere la band. Qualcuno ha detto che, in quell’intervista, Rick stava veramente parlando per la prima volta».
Non fu per niente un disco facile, Wish You Were Here. «Dopo l’enorme successo di Dark Side Of The Moon», racconta Gilmour nel dvd, «tutti noi dovemmo confrontarci con la domanda su cosa fossimo diventati: eravamo ancora artisti o soltanto uomini d’affari? Quando raggiungi quel tipo di successo e hai visto così tanti di quei soldi da poter soddisfare i più selvaggi sogni adolescenziali, perché dovresti continuare? Roger disse che dopo Dark Side il gruppo era finito, e per certi versi aveva ragione».
Waters: «Avremmo potuto facilmente scioglierci a quel punto. Se non lo facemmo, è solo perché avevamo paura di quel grande ombrello che racchiudeva questo nome, Pink Floyd, così straordinariamente potente e redditizio».
La tensione si allenta quando, all’inizio del 1974, mentre la band è rinchiusa nel quartiere King’s Cross di Londra a provare materiale nuovo, arriva una sequenza secca di quattro note di chitarra. Gilmour: «C’era qualcosa, in quelle quattro note, che evocava Syd, e in particolare la sua assenza». Edginton: «Su Shine On You Crazy Diamond Roger è stato perentorio, spiegando che non riguarda niente altro che Syd. Con i suoi 20 minuti caratterizza tutto l’album e l’emozione ti avvolge prima ancora che la canzone inizi. Si stavano spingendo ai limiti, combinando suoni elettrici a elementi che vanno dal blues al gospel al jazz».
Nel gennaio 1975 i Pink Floyd varcano la soglia degli Abbey Road Studios per registrare il nuovo disco, con idee ancora molto approssimative. Gilmour: «In alcuni momenti, qualcuno di noi era più preoccupato a pensare a cosa avrebbe fatto nel weekend che al disco. La concentrazione era molto diluita e sono sicuro che per una persona abituata a spingere, come Roger, dovesse essere molto frustrante». Waters: «Ovvio che fossi lì per lavorare. Se sono in una sala di incisione, voglio registrare, altrimenti preferirei stare da un’altra parte a fare qualcosa di diverso».
L’inerzia creativa trova uno sbocco quando Waters, in contrasto con Gilmour, propone di dividere Shine On You Crazy Diamond in due tronconi all’inizio e alla fine dell’album, mettendo altre canzoni nel mezzo. Edginton: «Roger spingeva per avere il controllo creativo, aveva ormai sviluppato questa attitudine da leader e considerava gli altri come una sorta di backing band. Ovviamente non era così e oggi possiamo capire quanto interesse ci mettesse David, in particolare. Quel tipo di relazione fra i due, però, serviva a produrre grande musica. Erano due opposti: Dave era il musicista, quello che portava gli elementi più strettamente musicali. In molte canzoni dei Pink Floyd la chiave arrivava con un suono di Dave, che spingeva Roger a tirar fuori delle idee. Come su Shine On – le quattro note di Dave diedero letteralmente l’impulso alla canzone – e anche Wish You Were Here. Waters: «Dissi che l’album doveva essere più coerente e a tema. C’era una canzone su Syd e volevo approfondire i miei sentimenti sull’assenza, perché sentivo che noi stessi non eravamo realmente lì. Eravamo assenti».
Quello dell’assenza si intreccia con l’altro tema dell’album: la disillusione nei confronti del music business. Esemplare Have A Cigar, ritratto impietoso di un’industria discografica ingorda che, curiosamente, né Waters né Gilmour riescono a cantare in maniera soddisfacente. Così, paradossalmente, l’unico brano da Wish You Were Here pubblicato su singolo è cantato da un ospite, Roy Harper. «Stavo lavorando nello studio 2, loro nel 3. Dave non riusciva a farla, Roger combatteva con la sua voce, allora dissi: se volete la faccio io, ma a un prezzo! È finita che è stata trasmessa milioni di volte, ho cantato su un singolo finito al numero uno e tutti pensavano che si trattasse di Roger, e questo mi dava un po’ fastidio. Ma la cosa peggiore è che ai miei concerti c’è sempre qualcuno che urla Have A Cigar!». Waters: «Non ho nulla contro Roy, ma penso che se avessi perseverato l’avrei fatta meglio io: sarebbe stata più vulnerabile e meno cinica, lui la canta come una parodia e questo non mi piace».
Le tematiche di Have A Cigar si sposano perfettamente a quelle di Welcome To The Machine. Waters: «A un certo punto diventi parte della macchina industriale delle compravendite. Non sei più un’individualità, ma solo un pupazzo che interpreta una parte. Essere una star non è divertente. Può spingerti fino a ritirarti dall’industria discografica. Tuttavia Welcome To The Machine non riguarda esclusivamente i miei rapporti con l’industria. Ha a che fare, in realtà, con tutte le nostre esperienze rispetto a quella macchina mostruosa e logorante che ci mastica e ci sputa». L’inizio di Welcome To The Machine presenta suoni futuristici creati al sintetizzatore da Waters. Racconta il fonico Brian Humphries: «La pulsazione iniziale è quello che Roger avrebbe normalmente fatto col basso. E che in seguito doppiò con un basso vero. Gli unici strumenti reali, all’inizio, sono le due chitarre acustiche di David. Per rendere il sound più aggressivo furono aggiunti timpani e piatti».
Come si è già accennato, anche per la title track l’input parte da Gilmour: «Scrissi il riff di apertura di Wish You Were Here e di nuovo, come era accaduto per le quattro note di Shine On, a Roger piacque molto e si mise al lavoro. Creammo insieme le strofe e gli accordi, poi lui scrisse parole brillanti». Waters: «Penso che molte delle canzoni che scrivo mandino lo stesso messaggio: puoi liberare te stesso al punto di poter sperimentare una vita reale o no? Perché, se non puoi, resterai squadrato fin quando morirai. So che può sembrare una merda, ma è quello di cui parlo, in realtà». Gilmour: «Di per sé è una canzone piuttosto semplice, ma grazie al peso emozionale che porta è una delle migliori. E anche se so che Shine On You Crazy Diamond è quella dedicata a Syd, non posso cantare Wish You Were Here senza pensare a lui».
Già, ancora Barrett. Anche in chiusura, con la seconda parte (segmenti 6-9) di Shine On You Crazy Diamond. Humphries: «Qui Rick era veramente nel suo elemento: organo Hammond, piano a coda e sintetizzatori. Non ricordo che sintetizzatore fosse [quello che produce l’effetto brass], ma è il segno distintivo di Rick. Penso che se avesse avuto a disposizione altri 20 minuti avremmo avuto un Richard Wright Concerto. Nell’ultima parte, che suona da solo, Rick offre il suo tributo personale a Syd Barrett».
Joe Boyd, il primo produttore dei Pink Floyd: «La prima volta che vidi i Floyd, quello che mi colpì furono le luci, non si vedevano cose del genere facilmente, a quei tempi. Ma Syd cominciava già a risplendere, non riuscivi a levargli gli occhi di dosso neanche quando macchie di color porpora e verde si espandevano nell’oscurità. Quando iniziai a lavorare con loro, fu subito chiaro che la parte creativa arrivava da Syd, anche se ovviamente non si è mai trattato di Syd e la sua band».
Richard Wright: «Avevamo una session al Radio 1 Show della BBC, mi pare fosse un venerdì. Syd non c’era. Lo cercammo invano per ore e alla fine credo che dovemmo rinunciare. Fu ritrovato circa tre giorni dopo, la domenica o il lunedì, e i manager ci dissero che doveva essergli successo qualcosa, perché era completamente cambiato». Boyd: «Lo guardai negli occhi, ed era come se qualcuno gli avesse spento la luce dentro. Appariva del tutto assente». Wright: «Viveva in una comunità di gente che prendeva gli acidi. Aveva ormai fatto danni con gli acidi, troppo acido ti frigge il cervello». Mason: «Non sapevamo bene come aiutare Syd, ma probabilmente, seppure non deliberatamente, avevamo a cuore di più i nostri interessi, quindi probabilmente cercammo di tenerlo dentro più di quanto avremmo dovuto. Non ci sarebbe mai stato Dark Side, senza Syd».
Il 5 giugno 1975, mentre i Pink Floyd stanno missando Wish You Were Here, Syd Barrett entra negli studi Abbey Road. Incredibilmente, nessuno lo riconosce. Edginton: «Era cambiato molto rispetto agli anni precedenti, e penso che sia possibile che, girando per lo studio, gli altri abbiano visto questo tizio senza riconoscerlo. Deve essere stato traumatico saperlo in seguito, quando hanno realizzato chi era… parlava in modo molto strano e tentare di imbastire una conversazione era impossibile». È dunque così facile infilarsi negli studi Abbey Road? «Credo che fosse un sabato» risponde Edginton «e c’erano un sacco di persone che entravano e uscivano dallo studio fra tecnici, musicisti e gente che era con le band».
Gilmour: «Stranamente nessuno si chiese chi fosse questo tizio che gironzolava intorno alla nostra apparecchiatura in studio. Entrò anche nella sala di controllo e rimase nei paraggi. Quanto ci volle prima che qualcuno si svegliasse?». Mason: «Penso che fu David a dirmi, a un certo punto: “Nick, non lo riconosci?”. Lo guardai e scrollai le spalle, prima che Dave mi mettesse di fronte all’evidenza. Abbiamo una sua foto fatta in studio quel giorno, e quel Syd era veramente molto diverso dal Syd del 1967 che ricordavamo».
Gilmour: «Quella persona sottile ed elegante, per quanto confusa e insudiciata, che avevo visto l’ultima volta aveva adesso più la forma di un pallone, senza sopracciglia e con pochi capelli… Fu un grande shock, ma soprattutto una grande perdita».
Come ogni album dei Pink Floyd, anche questo si avvale di un team creativo ad altissimi livelli per l’artwork. Il designer Storm Thorgerson, cofondatore della Hipgnosis: «Su Dark Side Of The Moon ogni cosa era andata al posto giusto. Cosa fare dopo? Come riuscire ad essere diversi? Non so disegnare, dunque erano da scartare immagini fantasy. Ma non mi piacciono neanche le foto di band: quattro musicisti ai loro strumenti potrebbero essere chiunque».
Gilmour: «Lasciammo tutto nelle mani di Storm, a cui dedicavamo solo un paio di minuti di attenzione tra un missaggio e l’altro. A un certo punto sposò anche lui il concept dell’assenza, il che ci sembrò un’ottima idea».
Il disco originale venne pertanto inserito in un involucro scuro, ricoperto da uno sticker con due mani meccaniche che si stringono, in un gesto evidentemente formale. Un’altra stretta di mano è quella di due uomini d’affari, uno dei quali sta bruciando. Thorgerson: «Nei giorni prima del computer non potemmo fare altro che dare per davvero fuoco a un uomo. Avvenne in uno studio lot di Hollywood. Per la foto interna, invece, il fotografo Aubrey “Po” Powell trovò una fantastica location per il tuffo chiamata Mono Lake. Powell: «Il tuffatore si mise in posizione yoga con un respiratore, e doveva trattenere il respiro per non fare bolle».
Wish You Were Here viene pubblicato il 12 settembre 1975. Ha venduto, ad oggi, quasi 20 milioni di copie, raggiungendo il primo posto in Inghilterra e Stati Uniti. Waters: «È pieno di dolore e rabbia, ma anche amore. Bisogna guardare oltre la rabbia e il dolore per vedere anche le possibilità dell’amore».