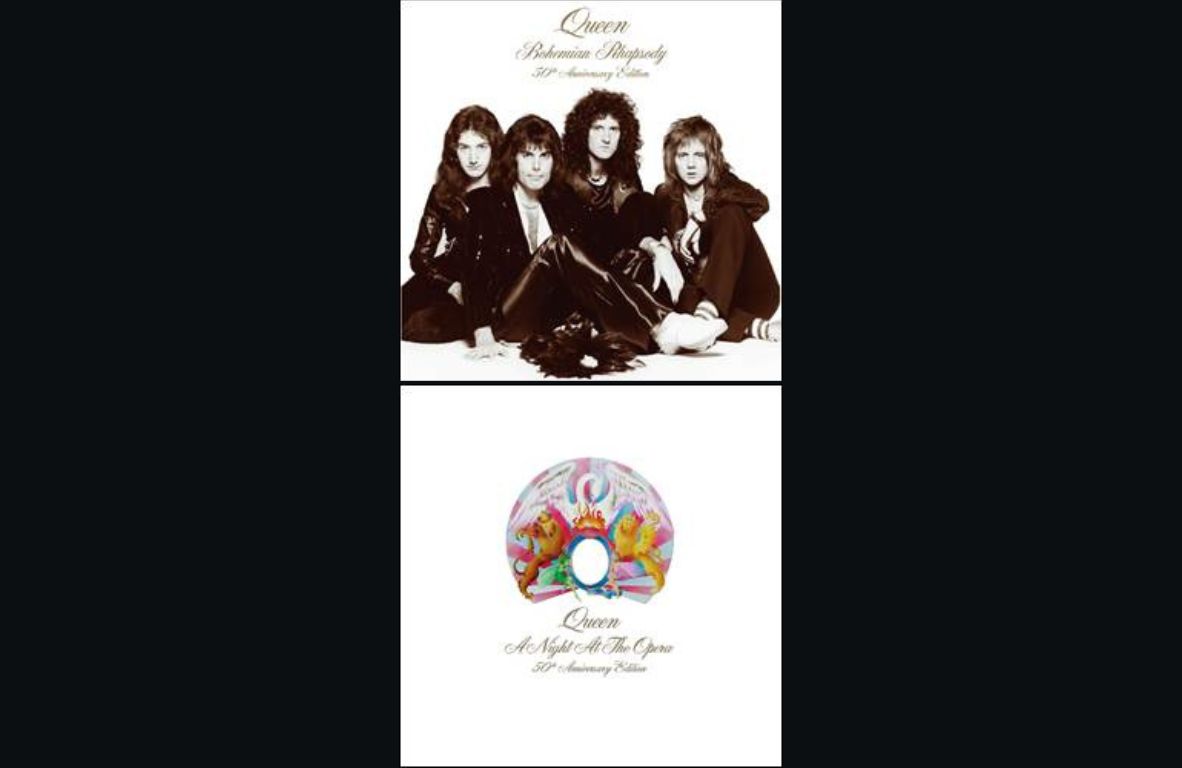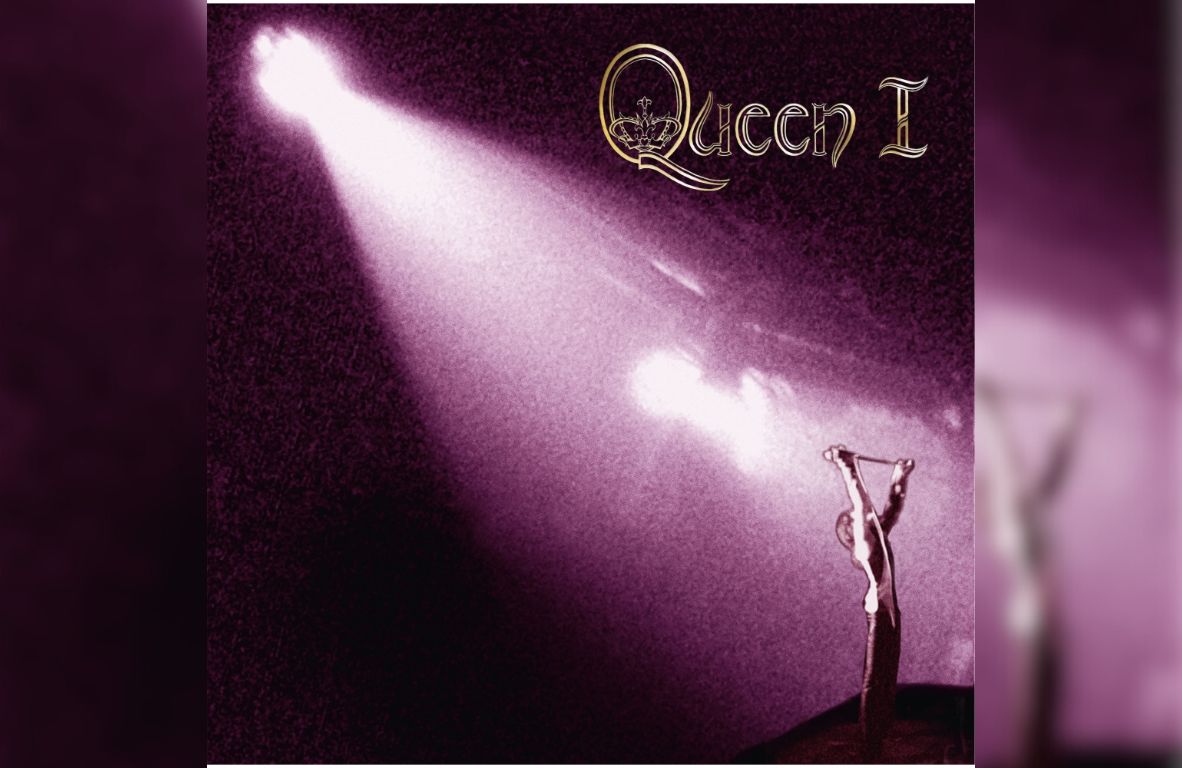Ne abbiamo sentito parlare così a lungo, che tutta la vicenda legata al biopic dei Queen, probabilmente il più atteso e chiacchierato dai tempi di The Doors di Oliver Stone, cominciava ad assumere i connotati della barzelletta.
Fortunatamente, dopo attori principali e registi che fuggivano e notizie sempre più fumose che lasciavano presagire l’abbandono del progetto, nel giro di pochi mesi, trovata finalmente la quadra, tutto è giunto a (felice?) conclusione. Com’è, dunque, il film che ripropone l’epopea della band più collezionata al mondo, concentrandosi sulla vita, i tormenti e la voglia di farcela del proprio leader? Come insegna proprio il film di Stone sulla band di Jim Morrison e compagni, è davvero complicato rapportarsi al racconto di un gruppo che ha segnato in modo indelebile l’immaginario collettivo mondiale, in particolar modo perché più il gruppo è popolare e più è alta la probabilità di plotoni d’esecuzione pronti al fuoco per ogni minimo errore, per ogni piccolo dettaglio, per ogni licenza poetica. Per continuare il paragone con The Doors, se là Stone aveva puntato su una narrazione visionaria, in cui il protagonista usciva più come qualcos’altro che come poeta, qui i lati selvaggi di Mercury vengono sicuramente edulcorati, come si conviene ad una mega produzione hollywoodiana. Edulcorati, ma non taciuti, s’intenda. Tanto che in alcuni paesi del mondo il film sta incontrando grossi problemi di censura. Ad ogni modo, non traspare la volontà di rendere santa la sua figura e questa è una cosa molto buona, ma forse non si è voluto (o potuto) spingere maggiormente su un lato della sua personalità che, evidentemente, è capace di creare ancora qualche prurito ai più. Il film è veloce, anche grazie a dialoghi volutamente molto corti, persino in scene madre in cui, forse, sarebbe stato doveroso lasciare un po’ più di spazio alle parole. Ma che Bohemian Rhapsody fosse un progetto basato in larga parte sull’aspetto visivo e spettacolare lo si era capito da tempo: d’altra parte, come avrebbe potuto essere altrimenti nel caso di un gruppo che, soprattutto nella seconda parte della propria carriera, puntò molte delle proprie fiches proprio sugli spettacoli dal vivo. Proprio per questo, altro punto totalmente a favore della produzione, l’aspetto più curato della pellicola restano le ambientazioni dei live dei Queen, riprodotte nei minimi particolari e al limite della vera e propria maniacalità (questa sì una cosa pensata soprattutto per i die hard fan più intransigenti). Parlando sempre di esibizioni dal vivo, il largamente anticipato finale del film, ambientato al Live Aid di Bob Geldof, resterà a lungo nei ricordi di pubblico e critica: si può essere fan o meno della Regina, ma è davvero difficile restare impassibili durante l’esecuzione di quella We Are The Champions che precede di poco i titoli di coda. Inevitabilmente, non tutto funziona a meraviglia. I dialoghi, ad esempio, lasciano spesso spaesati e la sensazione è che il doppiaggio italiano penalizzi ulteriormente la resa di alcune battute. In questo senso, la versione in lingua originale aumenta (e non di poco) la qualità dell’opera. Inoltre, la necessità di riepilogare quindici anni di tale intensità, occupandosi tanto della carriera del gruppo che dell’avventurosa vita privata di Mercury, ha dato vita ad alcuni episodi quantomeno controversi. Su tutti, l’esecuzione di brani dal vivo che sarebbero stati composti molti anni dopo e la scoperta, con tanto di annuncio ai compagni, del sopraggiungere della malattia che l’avrebbe condannato. Facezie per il grande pubblico, licenze imperdonabili per i fan.
A conti fatti, tuttavia, la pellicola riesce nell’intento prefissatosi: riuscire a mettere in luce le lotte interiori di un uomo che era molto di più di quello che Mick Jagger definì il più grande frontman della storia della musica.
Fortunatamente, dopo attori principali e registi che fuggivano e notizie sempre più fumose che lasciavano presagire l’abbandono del progetto, nel giro di pochi mesi, trovata finalmente la quadra, tutto è giunto a (felice?) conclusione. Com’è, dunque, il film che ripropone l’epopea della band più collezionata al mondo, concentrandosi sulla vita, i tormenti e la voglia di farcela del proprio leader? Come insegna proprio il film di Stone sulla band di Jim Morrison e compagni, è davvero complicato rapportarsi al racconto di un gruppo che ha segnato in modo indelebile l’immaginario collettivo mondiale, in particolar modo perché più il gruppo è popolare e più è alta la probabilità di plotoni d’esecuzione pronti al fuoco per ogni minimo errore, per ogni piccolo dettaglio, per ogni licenza poetica. Per continuare il paragone con The Doors, se là Stone aveva puntato su una narrazione visionaria, in cui il protagonista usciva più come qualcos’altro che come poeta, qui i lati selvaggi di Mercury vengono sicuramente edulcorati, come si conviene ad una mega produzione hollywoodiana. Edulcorati, ma non taciuti, s’intenda. Tanto che in alcuni paesi del mondo il film sta incontrando grossi problemi di censura. Ad ogni modo, non traspare la volontà di rendere santa la sua figura e questa è una cosa molto buona, ma forse non si è voluto (o potuto) spingere maggiormente su un lato della sua personalità che, evidentemente, è capace di creare ancora qualche prurito ai più. Il film è veloce, anche grazie a dialoghi volutamente molto corti, persino in scene madre in cui, forse, sarebbe stato doveroso lasciare un po’ più di spazio alle parole. Ma che Bohemian Rhapsody fosse un progetto basato in larga parte sull’aspetto visivo e spettacolare lo si era capito da tempo: d’altra parte, come avrebbe potuto essere altrimenti nel caso di un gruppo che, soprattutto nella seconda parte della propria carriera, puntò molte delle proprie fiches proprio sugli spettacoli dal vivo. Proprio per questo, altro punto totalmente a favore della produzione, l’aspetto più curato della pellicola restano le ambientazioni dei live dei Queen, riprodotte nei minimi particolari e al limite della vera e propria maniacalità (questa sì una cosa pensata soprattutto per i die hard fan più intransigenti). Parlando sempre di esibizioni dal vivo, il largamente anticipato finale del film, ambientato al Live Aid di Bob Geldof, resterà a lungo nei ricordi di pubblico e critica: si può essere fan o meno della Regina, ma è davvero difficile restare impassibili durante l’esecuzione di quella We Are The Champions che precede di poco i titoli di coda. Inevitabilmente, non tutto funziona a meraviglia. I dialoghi, ad esempio, lasciano spesso spaesati e la sensazione è che il doppiaggio italiano penalizzi ulteriormente la resa di alcune battute. In questo senso, la versione in lingua originale aumenta (e non di poco) la qualità dell’opera. Inoltre, la necessità di riepilogare quindici anni di tale intensità, occupandosi tanto della carriera del gruppo che dell’avventurosa vita privata di Mercury, ha dato vita ad alcuni episodi quantomeno controversi. Su tutti, l’esecuzione di brani dal vivo che sarebbero stati composti molti anni dopo e la scoperta, con tanto di annuncio ai compagni, del sopraggiungere della malattia che l’avrebbe condannato. Facezie per il grande pubblico, licenze imperdonabili per i fan.
A conti fatti, tuttavia, la pellicola riesce nell’intento prefissatosi: riuscire a mettere in luce le lotte interiori di un uomo che era molto di più di quello che Mick Jagger definì il più grande frontman della storia della musica.