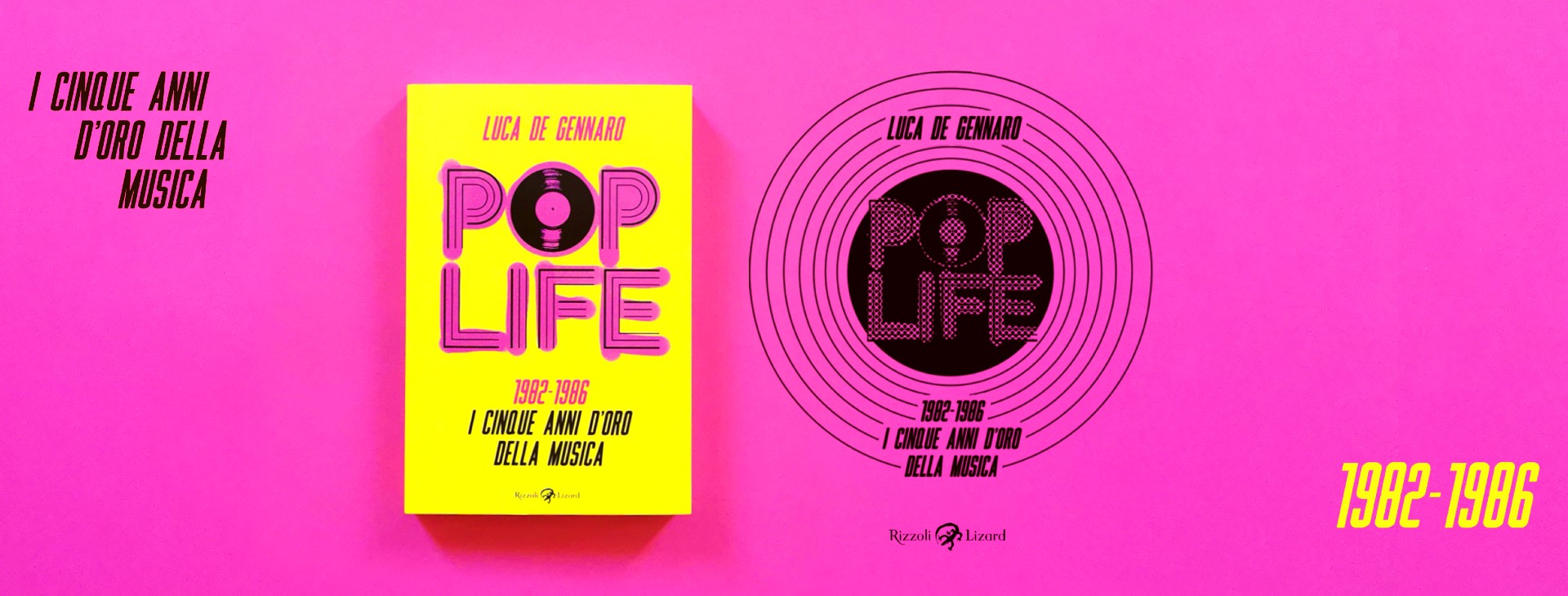Dissidio, lotta contro la sottomissione, rivoluzione come stato mentale, cantare come contributo civile per la comunità. Le citazioni in esergo di Amiri Baraka, Gil Scott-Heron e Aretha Franklin sono più che sufficienti per inquadrare il panorama approfondito da Carlo Babando in Blackness. Storie e musiche dell’universo afroamericano (Odoya). Un lavoro magistrale che contestualizza l’epoca Black Lives Matter – e andando indietro l’epopea Stax e Motown, la Blaxploitation, il nu-soul, fino alla musica subsahariana – e fornisce ragguagli storico-musicali per comprendere un universo, più che un semplice panorama artistico e culturale. Cerchiamo con lui le storie dietro i dischi. Storie di stupore.
Storie e musiche dell’universo afroamericano è un sottotitolo che apre scenari notevoli in termini di vastità e ampiezza. Intanto le musiche: quanto sono caratterizzanti nell’identità afroamericana?
Per il popolo afroamericano la musica è stato non solo un mezzo di espressione, ma anche un modo per costruire e rielaborare la propria storia, per curare certe ferite e – al tempo stesso – mostrarne il sangue versato. Sarebbe limitativo, tuttavia, inquadrare la questione solo in tal senso: un artista, qualsiasi colore sia la sua pelle, dovrebbe poter scegliere in che modo fare sentire la propria voce. E se un artista afroamericano non avesse alcuna intenzione di raccontare la propria identità attraverso la musica? E se non potesse farlo? E se, al contrario, ad un certo punto della propria carriera gli “convenisse” affrontare quei temi? Meglio complicare sempre il quadro, altrimenti si rischia di sprofondare nella retorica.
Ulteriore specificazione: universo afroamericano. Un’etnia, un ghetto universale, uno stato mentale di rivoluzione – per citare Gil Scott-Heron – o cosa?
Per universo afroamericano, ora più che mai, si intende una galassia liquida all’interno della quale è possibile intravedere tanto il Wakanda del film Black Panther che l’Africa immaginata da Beyoncé nel suo Black Is King; sia le rime di Kendrick Lamar quando citano Kunta Kinte che i volti di Barack Obama e Malcolm X tatuati sulla pelle dei giocatori NBA; il retro soul che si rifugia dichiaratamente in un passato color seppia e l’afrofuturismo di Kamasi Washington, con cui è riemersa anche la fascinazione per un Egitto esoterico e fuori dal tempo. Un frullato con troppi ingredienti, ma che rimane la base di partenza ideale per affrontare in maniera critica il concetto di blackness nel nuovo millennio. A patto di conoscere anche il passato, ovviamente: esplorarne le connessioni è quello che ho cercato di fare nel mio libro.
Il fenomeno Blaxploitation oppure la filmografia di Spike Lee, entrambi ampiamente storicizzati, ci hanno mostrato una fusione tra cinema e musica identitaria. In tempi di frammentazione del sapere, l’universo afroamericano rivela ancora contatti creativi fra le arti?
I contatti ci sono e ci saranno sempre, il problema è cercare di svincolarsi da alcune traiettorie che risultano banali e figlie di una visione fastidiosamente capitalistica dell’identità afroamericana. Non a caso ho scelto di organizzare il libro in una prima parte in cui mi occupo di storia, una seconda in cui al centro metto la musica e un’ultima nella quale parlo di cinema e di attivismo politico insieme a Marco Manetti dei Manetti Bros e Giuseppe “u.net” Pipitone. In tutte e tre le sezioni parto dal passato per riallacciarmi al presente, lasciando al lettore la possibilità di unire i puntini e farsi le sue idee (che possono non essere le mie). C’è tanto da dire, mi sono limitato ad accendere alcune lampadine lungo un corridoio potenzialmente infinito.
Un bel po’ di tempo fa, nel suo periodo soul/funk, Enzo Avitabile in Alta Tensione cantava: «Liberiamo il ghetto che tenimm’ ‘a rint’». La metafora del ghetto interiore come spinta verso la rivalsa. Come si è evoluta la musica dei ghetti negli ultimi anni?
Il ghetto, a seconda di come lo vedi, ormai esiste anche dentro i grattacieli di cristallo. La legge della strada – quella in cui vince il più forte – può convincerti a voler abitare, idealmente, in entrambi i posti senza perdere credibilità: sappiamo già che non è così facile. Diciamo che alcuni ghetti possono essere raccontati anche attraverso nuove metafore, ma bisogna prendersi il tempo di farlo in maniera ponderata e senza l’imperativo assoluto dell’hype e degli ascolti in streaming. La domanda, allora, potrebbe diventare: in quanti sono davvero disposti ad assorbire certi spunti oggi? Dando per scontato che messaggio e messaggeri sono quelli giusti, lo è anche la platea dei grossi palchi e dei grossi numeri?
Fatta salva qualche formazione “illuminata”, dalla Band Of Gypsies ai Living Colour, passando per i Bad Brains, il binomio black e rock ha dato esiti minori rispetto al contributo jazz, blues e soul. Oggi il rock nero come sta e soprattutto da che parte sta andando?
Quando penso al passato e a territori di confine tra rock e black music mi vengono sempre in mente i Black Merda, oggi colpevolmente quasi dimenticati. Nella scena attuale, restando a nomi che mettono al centro l’identità afroamericana, i Black Pumas sono quelli che ultimamente hanno raccolto maggiori consensi di pubblico e critica. In realtà il gruppo gira attorno ad un cantante nero e ad un chitarrista bianco, ma nel loro esordio l’equilibrio vira decisamente da una parte. Già uno come Curtis Harding, invece, complica le cose mettendo sul piatto influenze più eterogenee: i suoi dischi sono difficilissimi da incasellare, ma meritano molta attenzione. Poi ci sono artisti come Michael Kiwanuka, che utilizzano alcune intuizioni “rock” – con tutte le virgolette del caso – all’interno di una tavolozza stratificata e davvero imprevedibile. In realtà, forzando leggermente i confini, potremmo continuare per ore.
Per le musiche afroamericane di oggi vale ancora lo storico monito di Amiri Baraka in merito all’estetica della sottomissione?
Baraka è stato un intellettuale sempre allergico all’apologia, capace di parlare alla comunità afroamericana con una durezza sconcertante. Ecco, nell’idea che la sottomissione si combatte con la lotta, bisogna proprio tornare alle sue parole: sforzarsi di capire quando e come si sta lottando per non cadere nei soliti mulinelli del mercato, della fama e del denaro. Alzare il pugno verso il cielo è importantissimo, però bisogna farlo con coscienza. E questo vale per chi sta dietro il microfono, per chi si mette una cuffia sulle orecchie, per chi vuole superare la dicotomia eurocentrismo/afrocentrismo, per chi ha già capito che “master” e “slave” hanno ormai altre facce e altri vestiti, e via dicendo.
In chiusura un consiglio d’ascolto. Suggerisci ai lettori di Jam qualche nuovo album proveniente dall’universo afroamericano che possa stupirli…
Si può partire dall’Africa subsahariana del Medioevo per parlare di doo wop, r&b e soul? Nelle mie pagine ci ho provato, mettendo in mezzo anche tanto altro. Si può scrivere una “storia della blackness” partendo dallo stesso angolo di storia e prendendo in considerazione ogni linguaggio musicale partorito dal popolo afroamericano? Un’utopia, basta pensare a quante pagine ci vorrebbero solo per il blues e il jazz. Ecco quindi che il mio consiglio è quello di cercare lo stupore in un percorso tutto vostro, in un’idea di black music che potrebbe non esaurirsi necessariamente tra i solchi di What’s Going On e nella voce di Marvin Gaye, ma magari risiedere anche nel blue eyed soul sghembo del finlandese Bobby Oroza e del suo This Love. Se volete sorprendervi, cercate sempre le storie dietro i dischi: è quello che provo a fare ogni giorno.
Storie e musiche dell’universo afroamericano è un sottotitolo che apre scenari notevoli in termini di vastità e ampiezza. Intanto le musiche: quanto sono caratterizzanti nell’identità afroamericana?
Per il popolo afroamericano la musica è stato non solo un mezzo di espressione, ma anche un modo per costruire e rielaborare la propria storia, per curare certe ferite e – al tempo stesso – mostrarne il sangue versato. Sarebbe limitativo, tuttavia, inquadrare la questione solo in tal senso: un artista, qualsiasi colore sia la sua pelle, dovrebbe poter scegliere in che modo fare sentire la propria voce. E se un artista afroamericano non avesse alcuna intenzione di raccontare la propria identità attraverso la musica? E se non potesse farlo? E se, al contrario, ad un certo punto della propria carriera gli “convenisse” affrontare quei temi? Meglio complicare sempre il quadro, altrimenti si rischia di sprofondare nella retorica.
Ulteriore specificazione: universo afroamericano. Un’etnia, un ghetto universale, uno stato mentale di rivoluzione – per citare Gil Scott-Heron – o cosa?
Per universo afroamericano, ora più che mai, si intende una galassia liquida all’interno della quale è possibile intravedere tanto il Wakanda del film Black Panther che l’Africa immaginata da Beyoncé nel suo Black Is King; sia le rime di Kendrick Lamar quando citano Kunta Kinte che i volti di Barack Obama e Malcolm X tatuati sulla pelle dei giocatori NBA; il retro soul che si rifugia dichiaratamente in un passato color seppia e l’afrofuturismo di Kamasi Washington, con cui è riemersa anche la fascinazione per un Egitto esoterico e fuori dal tempo. Un frullato con troppi ingredienti, ma che rimane la base di partenza ideale per affrontare in maniera critica il concetto di blackness nel nuovo millennio. A patto di conoscere anche il passato, ovviamente: esplorarne le connessioni è quello che ho cercato di fare nel mio libro.
Il fenomeno Blaxploitation oppure la filmografia di Spike Lee, entrambi ampiamente storicizzati, ci hanno mostrato una fusione tra cinema e musica identitaria. In tempi di frammentazione del sapere, l’universo afroamericano rivela ancora contatti creativi fra le arti?
I contatti ci sono e ci saranno sempre, il problema è cercare di svincolarsi da alcune traiettorie che risultano banali e figlie di una visione fastidiosamente capitalistica dell’identità afroamericana. Non a caso ho scelto di organizzare il libro in una prima parte in cui mi occupo di storia, una seconda in cui al centro metto la musica e un’ultima nella quale parlo di cinema e di attivismo politico insieme a Marco Manetti dei Manetti Bros e Giuseppe “u.net” Pipitone. In tutte e tre le sezioni parto dal passato per riallacciarmi al presente, lasciando al lettore la possibilità di unire i puntini e farsi le sue idee (che possono non essere le mie). C’è tanto da dire, mi sono limitato ad accendere alcune lampadine lungo un corridoio potenzialmente infinito.
Un bel po’ di tempo fa, nel suo periodo soul/funk, Enzo Avitabile in Alta Tensione cantava: «Liberiamo il ghetto che tenimm’ ‘a rint’». La metafora del ghetto interiore come spinta verso la rivalsa. Come si è evoluta la musica dei ghetti negli ultimi anni?
Il ghetto, a seconda di come lo vedi, ormai esiste anche dentro i grattacieli di cristallo. La legge della strada – quella in cui vince il più forte – può convincerti a voler abitare, idealmente, in entrambi i posti senza perdere credibilità: sappiamo già che non è così facile. Diciamo che alcuni ghetti possono essere raccontati anche attraverso nuove metafore, ma bisogna prendersi il tempo di farlo in maniera ponderata e senza l’imperativo assoluto dell’hype e degli ascolti in streaming. La domanda, allora, potrebbe diventare: in quanti sono davvero disposti ad assorbire certi spunti oggi? Dando per scontato che messaggio e messaggeri sono quelli giusti, lo è anche la platea dei grossi palchi e dei grossi numeri?
Fatta salva qualche formazione “illuminata”, dalla Band Of Gypsies ai Living Colour, passando per i Bad Brains, il binomio black e rock ha dato esiti minori rispetto al contributo jazz, blues e soul. Oggi il rock nero come sta e soprattutto da che parte sta andando?
Quando penso al passato e a territori di confine tra rock e black music mi vengono sempre in mente i Black Merda, oggi colpevolmente quasi dimenticati. Nella scena attuale, restando a nomi che mettono al centro l’identità afroamericana, i Black Pumas sono quelli che ultimamente hanno raccolto maggiori consensi di pubblico e critica. In realtà il gruppo gira attorno ad un cantante nero e ad un chitarrista bianco, ma nel loro esordio l’equilibrio vira decisamente da una parte. Già uno come Curtis Harding, invece, complica le cose mettendo sul piatto influenze più eterogenee: i suoi dischi sono difficilissimi da incasellare, ma meritano molta attenzione. Poi ci sono artisti come Michael Kiwanuka, che utilizzano alcune intuizioni “rock” – con tutte le virgolette del caso – all’interno di una tavolozza stratificata e davvero imprevedibile. In realtà, forzando leggermente i confini, potremmo continuare per ore.
Per le musiche afroamericane di oggi vale ancora lo storico monito di Amiri Baraka in merito all’estetica della sottomissione?
Baraka è stato un intellettuale sempre allergico all’apologia, capace di parlare alla comunità afroamericana con una durezza sconcertante. Ecco, nell’idea che la sottomissione si combatte con la lotta, bisogna proprio tornare alle sue parole: sforzarsi di capire quando e come si sta lottando per non cadere nei soliti mulinelli del mercato, della fama e del denaro. Alzare il pugno verso il cielo è importantissimo, però bisogna farlo con coscienza. E questo vale per chi sta dietro il microfono, per chi si mette una cuffia sulle orecchie, per chi vuole superare la dicotomia eurocentrismo/afrocentrismo, per chi ha già capito che “master” e “slave” hanno ormai altre facce e altri vestiti, e via dicendo.
In chiusura un consiglio d’ascolto. Suggerisci ai lettori di Jam qualche nuovo album proveniente dall’universo afroamericano che possa stupirli…
Si può partire dall’Africa subsahariana del Medioevo per parlare di doo wop, r&b e soul? Nelle mie pagine ci ho provato, mettendo in mezzo anche tanto altro. Si può scrivere una “storia della blackness” partendo dallo stesso angolo di storia e prendendo in considerazione ogni linguaggio musicale partorito dal popolo afroamericano? Un’utopia, basta pensare a quante pagine ci vorrebbero solo per il blues e il jazz. Ecco quindi che il mio consiglio è quello di cercare lo stupore in un percorso tutto vostro, in un’idea di black music che potrebbe non esaurirsi necessariamente tra i solchi di What’s Going On e nella voce di Marvin Gaye, ma magari risiedere anche nel blue eyed soul sghembo del finlandese Bobby Oroza e del suo This Love. Se volete sorprendervi, cercate sempre le storie dietro i dischi: è quello che provo a fare ogni giorno.