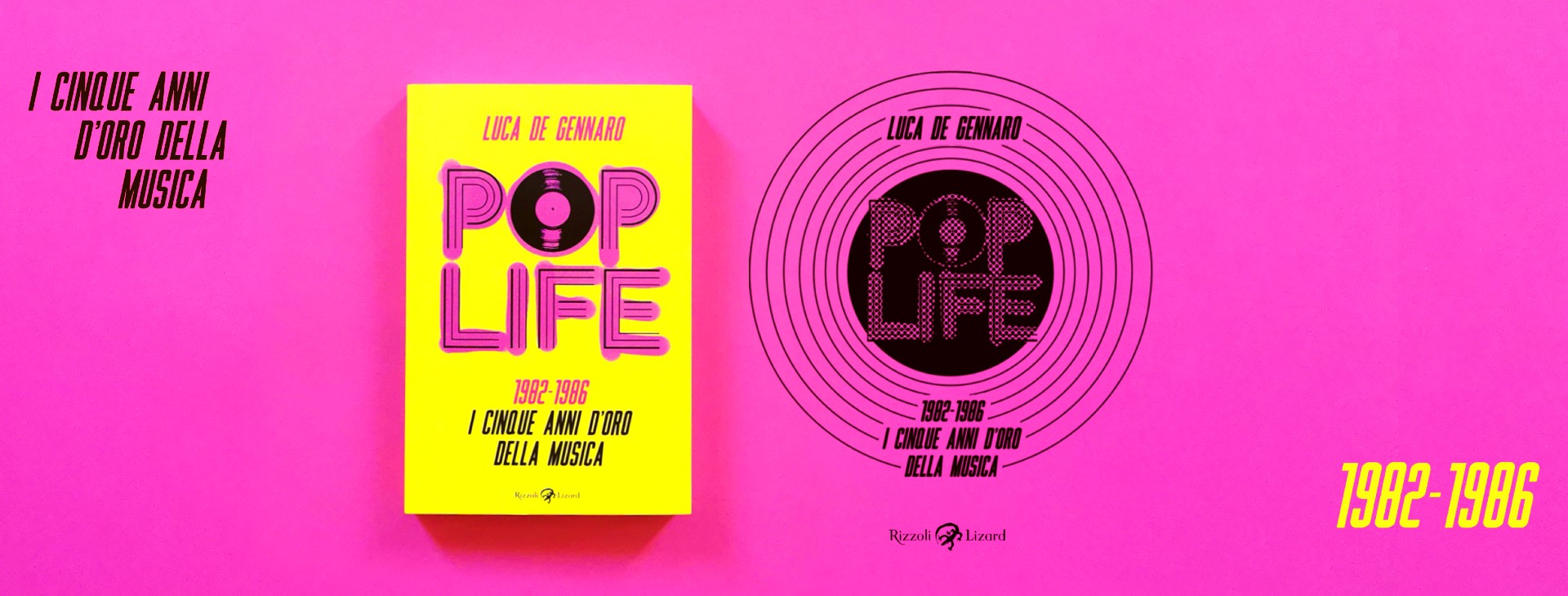Joyello Triolo è un uomo pop. Nel senso più nobile del termine. Un attento studioso e divulgatore dei fenomeni più interessanti del pop, a partire dalle cover. Ascoltare, assimilare, interpretare, rileggere o reinventare è una pratica costante nella storia della cultura popolare del secondo Novecento, a partire da Hound Dog fino alla serata di cover sanremesi. È proprio di cover che si parla nel suo nuovo libro, e di come spesso la copia sia più famosa dell’originale…
Più che un falso d’autore, la cover è una pratica rilevante per comprendere la storia del pop, tu racconti l’evolversi del fenomeno individuando 100 esempi (85 stranieri e 15 italiani). Quale criterio hai adottato per la selezione?
Ho usato l’unico possibile, vale a dire il mio gusto personale, al quale ho aggiunto un po’ di “condivisione fenomenale”. Intendo dire che quando mi sono messo a scrivere ho cominciato a lavorare sulla selezione dei pezzi e, informandomi, sono stato molte volte sorpreso delle scoperte fatte (una su tutte Song to the Sirens di Tim Buckley che ha una registrazione originale antecedente a quella del suo autore fatta da Pat Boone!). Unendo queste due componenti: gusto personale+effetto stupore, sono uscite le cento canzoni trattate nel libro. Ma non escludo un “Volume 2”!
Da A Groovy Kind Of Love di Phil Collins a Hush dei Deep Purple, dalla inevitabile Hallelujah di Jeff Buckley a The Best di Tina Turner. Quattro casi celeberrimi di epoche e generi diversi. Quali sono il periodo e la corrente in cui si è fatto maggior uso di cover?
Sicuramente gli anni ’60 ma… va fatto un distinguo: in quegli anni era pratica comune che una canzone nel repertorio di un editore o discografico venisse affidata a diversi interpreti. All’estero più che altro ma anche in Italia, se pensi alle famose edizioni di Sanremo in cui uno stesso pezzo era affidato a due interpreti differenti. Per quel periodo, infatti, è difficile parlare di “cover” perché non veniva data particolare rilevanza al personaggio. Voglio dire: se Marvin Gaye sembrava adatto a interpretare I Heard it to The Grapevine gliela assegnavano sebbene in giro ci fosse già il disco di Gladys Knight con lo stesso pezzo. Si puntava sulla sensibilità diversa del pubblico, di chi la registrava e, nel caso specifico, Gaye fece un lavoro eccellente. In Italia Ma che freddo fa venne affidata contemporaneamente a Nada e ai Rokes, con l’idea di “prendere” il pubblico dei giovanissimi e quello dei complessi. La spuntò certamente Nada, che era perfetta per quel brano, seppure i Rokes ne avessero fatto un arrangiamento molto bello.
In tempi recenti, al contrario e con le dovute eccezioni, quella della cover è una sorta di ripiego creativo che aiuta un cantante o una band a mantenere la visibilità anche quando l’attenzione del pubblico sta assottigliandosi. Se Tiziano Ferro interpreta un pezzo di Mina o di Battiato, finisci per ascoltarlo anche se non lo segui e avresti finito per “lisciare” un suo disco di inediti. Diventa, se vuoi, una forma di necessità professionale più che artistica.
Tra gli anni ’80 e i ’90 invece c’è stato il periodo che preferisco, vale a dire di riscoperta e rivalutazione, sebbene sia necessario considerare la mia età che mi colloca in quegli anni nella versione “giovane appassionato ventenne”. Il repertorio mondiale era talmente intriso di modernità che veniva spesso la voglia di applicarla a canzoni grandiose, bisognose di una rilettura che fosse diretta al pubblico più giovane. In Italia lo fece Ivan Cattaneo con Una Zebra a Pois, all’estero i Soft Cell con Tainted Love.
Abbiamo citato Hallelujah di Leonard Cohen, nota prevalentemente per la versione di Buckley, ma possiamo menzionare anche My Way di Claude François, resa immortale dal tris Sinatra/Presley/Vicious. Le cover più famose delle originali sono ognuna una storia a sé oppure c’è un filo conduttore che lega le sorti di questi pezzi?
Non ci vedo un filo comune. Ognuna ha una storia a sé, talvolta inspiegabile. Nel caso di Hallelujah vale il discorso di prima: il pezzo di Cohen era diretto a un pubblico ristretto e adulto, Buckley la incluse in un disco per giovanissimi, che non poterono far altro che adorarla e che, non lo escludo, li ha spinti a incuriosirsi sul repertorio di Cohen. My Way sarebbe sicuramente rimasta tra i confini francesi se non ci fosse stata una vedette del calibro di Sinatra (e Paul Anka che fece da tramite).
In altre occasioni (tipo la già citata Tainted Love) si tratta di veri e propri minor-hit, canzoni di culto note solo a un ristretto numero di persone, rivalutate da band in grado di restituir loro il valore che forse meritavano anche prima, attraverso un linguaggio contemporaneo e personale.
La cultura rock si è retta su valori come la autenticità e l’eversione, tanto che spesso la cover rock è guardata con sospetto, a differenza ad esempio dello standard jazz o del classico blues, che sono accolti con maggiore naturalezza. Come ti spieghi questa differente percezione?
Io credo che in questo ambito (il pop-rock) ci sia una sorta di prevenzione a causa del fatto che si tratta di musica popolare e quindi non espressamente diretta a un’elite. Anche il jazz nasce come musica da ballo o da diporto, ma il periodo storico in cui germogliò lo immerge e in un ambiente in cui era “normale” concedere a quell’espressione il giusto valore artistico. Diventato “genere” con gli anni, è piuttosto normale che il concetto di “standard” non assuma le stesse caratteristiche di quello di “cover” e non escludo che possa succedere anche con certo rock, tra qualche anno.
Essere prevenuti sul concetto di cover è qualcosa che va più che altro associato al fenomeno della musica dal vivo che in certi periodi ha potuto sopravvivere solo grazie a gruppi che non avevano velleità autoriali e si divertivano a suonare. Il pubblico di questi eventi è generalmente quello dell’ascoltatore occasionale, che non ha un reale interesse per la musica, ma preferisce (e a volte pretende) che gli venga offerta solo quella che già conosce e che non richieda l’attenzione necessaria.
Non ha nulla a che vedere con l’arte, è un passatempo, come il karaoke o il jukebox.
Nella tua vicenda personale di cultore di musiche, quali cover hanno avuto il ruolo più rilevante per farti scoprire percorsi inattesi?
Moltissime come puoi immaginare, in particolare quelle legate alla mia infanzia che io identifico come il periodo di maggior ricezione, quello in cui si scopre se la passione per la musica è un semplice passaggio generazionale oppure qualcosa di più profondo e del quale non ti libererai più. In questo ambito ci metto senza dubbio il primo disco che ho comprato coi miei soldi, vale a dire il primo album dei Vanilla Fudge. Se guardi la scaletta ci trovi She’s Not There, Bang Bang, You Keep me Hanging On, Eleanor Rigby eccetera, che a quel tempo (avevo dieci anni) non avevo identificato come cover. I pezzi originali di Beatles, Supremes, Sonny & Cher e Zombies non li conoscevo e per anni ho dato per scontato che fossero canzoni dei Vanilla Fudge che, peraltro, è una band che, molti anni prima che diventasse un trend, aveva costruito una carriera proprio sul concetto di riscrittura degli arrangiamenti.
Lo stesso vale per Joe Cocker: a casa mia i miei fratelli portavano dentro un sacco di dischi e il mio imprinting con classici come The Letter, Cry me a River o anche With a Little Help From my Friends rimane quello delle versioni di Joe Cocker.
Dei miei vent’anni abbiamo già parlato, siamo negli anni ’80 e la cover era diventata una prova di ricercatezza. Tainted Love e Song to The Sirens sono esempi formidabili ma c’erano anche Don’t Leave me This Way dei Communards, Love of The Common People di Paul Young, One Step Beyond dei Madness e I Love Rock’n’Roll di Joan Jett che erano cover di successi che appartenevano talmente poco alla mia generazione da renderli assolutamente nostri proprio grazie a quelle riedizioni “moderne”.
Cover tricolore: inevitabile fermarsi a nostri anni ’60, con Equipe 84, Dik Dik, Camaleonti e Corvi che hanno attinto fortemente dal Mersey Beat. Poca ispirazione, esterofilia accanita o pionierismo culturale?
Suppongo nessuna di queste cose.
Era piuttosto un modo per fare di necessità virtù. Bisogna contestualizzare un periodo in cui, per quanto assurdo possa sembrare, trovare nei negozi dischi stranieri non era per nulla facile. Una scarsa lungimiranza di certi discografici, poi, fece il resto ma fece buon gioco ai complessi di cui parli. Erano tutti ragazzi giovani ai quali non mancava certo l’informazione sulla musica giovanile inglese e americana e così, un po’ approfittando del fatto che quei dischi erano difficili da comprare, li rifacevano mettendoci anche parecchio del loro, fosse anche solo per i testi scritti in italiano, spessissimo senza tener conto del senso delle liriche originali.
È stato un capitolo a parte della nostra canzone, sicuramente dignitosissimo e irripetibile e talmente diffuso che nel libro ho preferito saltarlo a piè pari per non dover raggiungere il migliaio di pagine. Ho incluso solo uno di quei brani in rappresentanza di tutti ed è la cover di I Ain’t a Miracle Worker dei Brogues che in Italia fecero in italiano i Corvi col titolo Un ragazzo di strada. L’ho scelta perché è perfetta per descrivere il fenomeno che puntava a cercare brani pop rock (al tempo si diceva “beat”) che fossero poco conosciuti per farne dei successi da portare al Cantagiro. La canzone dei Brogues (band di breve vita che si sarebbe poi evoluta nei Quicksilver Messenger Service) era poco conosciuta anche in patria dove il gruppo l’aveva incisa per la facciata B di un singolo dalle vendite scarse. Pensa che è diventata un po’ più famosa solo una ventina di anni più tardi quando Lenny Kaye la inserì nella storica Nuggets assieme a decine di altre perle nascoste del pop rock anni ’60. La versione dei Corvi, invece, da noi fu un successo pazzesco, ancora oggi materia di cover da parte di molte altre band come i Rats, i Calibro 35 (con Manuel Agnelli alla voce), ma anche gli Skiantos e perfino i Pooh!
Peraltro faccio ammenda e segnalo che nel libro non ho riportato un dato che ho scoperto solo dopo la stampa, ossia che Un ragazzo di Strada era stata incisa, prima che dai Corvi, anche da un’altra band italiana, tali Bounty Killers di San Donà di Piave, che però non ebbe la giusta promozione e passò inosservata. Con le cover non si finisce mai di stupirsi!
Non manca un capitolo extra sui cover album, pensiamo a Pin Ups di Bowie oppure a Duemila60 Italian Graffiati di Ivan Cattaneo, che non a caso ha firmato la prefazione. Lo spirito del disco interamente dedicato a un altrui album o repertorio è diverso da quello della singola cover?
Sì. O meglio è diverso nell’ambito di quegli album di cover che non sono una mera raccolta di canzoni già famose ma che hanno dietro un progetto vero e proprio. Nella parte del libro in cui parlo di questi dischi, ho considerato solo ed unicamente quelli che avevano queste caratteristiche. Gli album di cover, messi assieme per ragioni contrattuali o per mancanza di materiale, non li considero dei progetti e mediamente non mi interessano (sebbene sia possibilissimo che all’interno contengano delle cover rispettabilissime, ben inteso).
Infatti i due casi che citi sono emblematici perché appartengono esattamente a quella categoria, peraltro rappresentando il medesimo progetto in due visioni distinte, di qua e di là della Manica.
Bowie per Pin Ups scelse le canzoni della sua gioventù e le mise assieme cercando di renderle personali e così fece Cattaneo col primo suo album di cover (ne fece poi altri due ma non c’entravano più nulla col progetto iniziale. Semplicemente aveva avuto un grandissimo successo e la casa discografica gli impose di battere quel chiodo).
Nei primi anni del nuovo secolo il disco di cover era praticamente all’ordine del giorno, ma sono stati davvero pochi quelli che hanno saputo gestirlo come un progetto personale. Era più una questione legata alla crisi dei supporti fonografici. I dischi vendevano sempre meno e l’industria ha cercato di prendere quel pubblico occasionale di cui parlavamo prima di acquistare il CD di Patti Smith, magari senza conoscerla, solo perché canta Gimme Shelter dei Rolling Stones, oppure quello di Giorgia perché hanno sentito alla radio la sua versione di I Feel Love. Se ci pensi, in questo senso, le cover hanno allungato anche un po’ la vita ai dischi. Una cosa che mi fa pensare di non sbagliare molto quando penso che tutto sommato siano un patrimonio formidabile della cultura popolare.
Più che un falso d’autore, la cover è una pratica rilevante per comprendere la storia del pop, tu racconti l’evolversi del fenomeno individuando 100 esempi (85 stranieri e 15 italiani). Quale criterio hai adottato per la selezione?
Ho usato l’unico possibile, vale a dire il mio gusto personale, al quale ho aggiunto un po’ di “condivisione fenomenale”. Intendo dire che quando mi sono messo a scrivere ho cominciato a lavorare sulla selezione dei pezzi e, informandomi, sono stato molte volte sorpreso delle scoperte fatte (una su tutte Song to the Sirens di Tim Buckley che ha una registrazione originale antecedente a quella del suo autore fatta da Pat Boone!). Unendo queste due componenti: gusto personale+effetto stupore, sono uscite le cento canzoni trattate nel libro. Ma non escludo un “Volume 2”!
Da A Groovy Kind Of Love di Phil Collins a Hush dei Deep Purple, dalla inevitabile Hallelujah di Jeff Buckley a The Best di Tina Turner. Quattro casi celeberrimi di epoche e generi diversi. Quali sono il periodo e la corrente in cui si è fatto maggior uso di cover?
Sicuramente gli anni ’60 ma… va fatto un distinguo: in quegli anni era pratica comune che una canzone nel repertorio di un editore o discografico venisse affidata a diversi interpreti. All’estero più che altro ma anche in Italia, se pensi alle famose edizioni di Sanremo in cui uno stesso pezzo era affidato a due interpreti differenti. Per quel periodo, infatti, è difficile parlare di “cover” perché non veniva data particolare rilevanza al personaggio. Voglio dire: se Marvin Gaye sembrava adatto a interpretare I Heard it to The Grapevine gliela assegnavano sebbene in giro ci fosse già il disco di Gladys Knight con lo stesso pezzo. Si puntava sulla sensibilità diversa del pubblico, di chi la registrava e, nel caso specifico, Gaye fece un lavoro eccellente. In Italia Ma che freddo fa venne affidata contemporaneamente a Nada e ai Rokes, con l’idea di “prendere” il pubblico dei giovanissimi e quello dei complessi. La spuntò certamente Nada, che era perfetta per quel brano, seppure i Rokes ne avessero fatto un arrangiamento molto bello.
In tempi recenti, al contrario e con le dovute eccezioni, quella della cover è una sorta di ripiego creativo che aiuta un cantante o una band a mantenere la visibilità anche quando l’attenzione del pubblico sta assottigliandosi. Se Tiziano Ferro interpreta un pezzo di Mina o di Battiato, finisci per ascoltarlo anche se non lo segui e avresti finito per “lisciare” un suo disco di inediti. Diventa, se vuoi, una forma di necessità professionale più che artistica.
Tra gli anni ’80 e i ’90 invece c’è stato il periodo che preferisco, vale a dire di riscoperta e rivalutazione, sebbene sia necessario considerare la mia età che mi colloca in quegli anni nella versione “giovane appassionato ventenne”. Il repertorio mondiale era talmente intriso di modernità che veniva spesso la voglia di applicarla a canzoni grandiose, bisognose di una rilettura che fosse diretta al pubblico più giovane. In Italia lo fece Ivan Cattaneo con Una Zebra a Pois, all’estero i Soft Cell con Tainted Love.
Abbiamo citato Hallelujah di Leonard Cohen, nota prevalentemente per la versione di Buckley, ma possiamo menzionare anche My Way di Claude François, resa immortale dal tris Sinatra/Presley/Vicious. Le cover più famose delle originali sono ognuna una storia a sé oppure c’è un filo conduttore che lega le sorti di questi pezzi?
Non ci vedo un filo comune. Ognuna ha una storia a sé, talvolta inspiegabile. Nel caso di Hallelujah vale il discorso di prima: il pezzo di Cohen era diretto a un pubblico ristretto e adulto, Buckley la incluse in un disco per giovanissimi, che non poterono far altro che adorarla e che, non lo escludo, li ha spinti a incuriosirsi sul repertorio di Cohen. My Way sarebbe sicuramente rimasta tra i confini francesi se non ci fosse stata una vedette del calibro di Sinatra (e Paul Anka che fece da tramite).
In altre occasioni (tipo la già citata Tainted Love) si tratta di veri e propri minor-hit, canzoni di culto note solo a un ristretto numero di persone, rivalutate da band in grado di restituir loro il valore che forse meritavano anche prima, attraverso un linguaggio contemporaneo e personale.
La cultura rock si è retta su valori come la autenticità e l’eversione, tanto che spesso la cover rock è guardata con sospetto, a differenza ad esempio dello standard jazz o del classico blues, che sono accolti con maggiore naturalezza. Come ti spieghi questa differente percezione?
Io credo che in questo ambito (il pop-rock) ci sia una sorta di prevenzione a causa del fatto che si tratta di musica popolare e quindi non espressamente diretta a un’elite. Anche il jazz nasce come musica da ballo o da diporto, ma il periodo storico in cui germogliò lo immerge e in un ambiente in cui era “normale” concedere a quell’espressione il giusto valore artistico. Diventato “genere” con gli anni, è piuttosto normale che il concetto di “standard” non assuma le stesse caratteristiche di quello di “cover” e non escludo che possa succedere anche con certo rock, tra qualche anno.
Essere prevenuti sul concetto di cover è qualcosa che va più che altro associato al fenomeno della musica dal vivo che in certi periodi ha potuto sopravvivere solo grazie a gruppi che non avevano velleità autoriali e si divertivano a suonare. Il pubblico di questi eventi è generalmente quello dell’ascoltatore occasionale, che non ha un reale interesse per la musica, ma preferisce (e a volte pretende) che gli venga offerta solo quella che già conosce e che non richieda l’attenzione necessaria.
Non ha nulla a che vedere con l’arte, è un passatempo, come il karaoke o il jukebox.
Nella tua vicenda personale di cultore di musiche, quali cover hanno avuto il ruolo più rilevante per farti scoprire percorsi inattesi?
Moltissime come puoi immaginare, in particolare quelle legate alla mia infanzia che io identifico come il periodo di maggior ricezione, quello in cui si scopre se la passione per la musica è un semplice passaggio generazionale oppure qualcosa di più profondo e del quale non ti libererai più. In questo ambito ci metto senza dubbio il primo disco che ho comprato coi miei soldi, vale a dire il primo album dei Vanilla Fudge. Se guardi la scaletta ci trovi She’s Not There, Bang Bang, You Keep me Hanging On, Eleanor Rigby eccetera, che a quel tempo (avevo dieci anni) non avevo identificato come cover. I pezzi originali di Beatles, Supremes, Sonny & Cher e Zombies non li conoscevo e per anni ho dato per scontato che fossero canzoni dei Vanilla Fudge che, peraltro, è una band che, molti anni prima che diventasse un trend, aveva costruito una carriera proprio sul concetto di riscrittura degli arrangiamenti.
Lo stesso vale per Joe Cocker: a casa mia i miei fratelli portavano dentro un sacco di dischi e il mio imprinting con classici come The Letter, Cry me a River o anche With a Little Help From my Friends rimane quello delle versioni di Joe Cocker.
Dei miei vent’anni abbiamo già parlato, siamo negli anni ’80 e la cover era diventata una prova di ricercatezza. Tainted Love e Song to The Sirens sono esempi formidabili ma c’erano anche Don’t Leave me This Way dei Communards, Love of The Common People di Paul Young, One Step Beyond dei Madness e I Love Rock’n’Roll di Joan Jett che erano cover di successi che appartenevano talmente poco alla mia generazione da renderli assolutamente nostri proprio grazie a quelle riedizioni “moderne”.
Cover tricolore: inevitabile fermarsi a nostri anni ’60, con Equipe 84, Dik Dik, Camaleonti e Corvi che hanno attinto fortemente dal Mersey Beat. Poca ispirazione, esterofilia accanita o pionierismo culturale?
Suppongo nessuna di queste cose.
Era piuttosto un modo per fare di necessità virtù. Bisogna contestualizzare un periodo in cui, per quanto assurdo possa sembrare, trovare nei negozi dischi stranieri non era per nulla facile. Una scarsa lungimiranza di certi discografici, poi, fece il resto ma fece buon gioco ai complessi di cui parli. Erano tutti ragazzi giovani ai quali non mancava certo l’informazione sulla musica giovanile inglese e americana e così, un po’ approfittando del fatto che quei dischi erano difficili da comprare, li rifacevano mettendoci anche parecchio del loro, fosse anche solo per i testi scritti in italiano, spessissimo senza tener conto del senso delle liriche originali.
È stato un capitolo a parte della nostra canzone, sicuramente dignitosissimo e irripetibile e talmente diffuso che nel libro ho preferito saltarlo a piè pari per non dover raggiungere il migliaio di pagine. Ho incluso solo uno di quei brani in rappresentanza di tutti ed è la cover di I Ain’t a Miracle Worker dei Brogues che in Italia fecero in italiano i Corvi col titolo Un ragazzo di strada. L’ho scelta perché è perfetta per descrivere il fenomeno che puntava a cercare brani pop rock (al tempo si diceva “beat”) che fossero poco conosciuti per farne dei successi da portare al Cantagiro. La canzone dei Brogues (band di breve vita che si sarebbe poi evoluta nei Quicksilver Messenger Service) era poco conosciuta anche in patria dove il gruppo l’aveva incisa per la facciata B di un singolo dalle vendite scarse. Pensa che è diventata un po’ più famosa solo una ventina di anni più tardi quando Lenny Kaye la inserì nella storica Nuggets assieme a decine di altre perle nascoste del pop rock anni ’60. La versione dei Corvi, invece, da noi fu un successo pazzesco, ancora oggi materia di cover da parte di molte altre band come i Rats, i Calibro 35 (con Manuel Agnelli alla voce), ma anche gli Skiantos e perfino i Pooh!
Peraltro faccio ammenda e segnalo che nel libro non ho riportato un dato che ho scoperto solo dopo la stampa, ossia che Un ragazzo di Strada era stata incisa, prima che dai Corvi, anche da un’altra band italiana, tali Bounty Killers di San Donà di Piave, che però non ebbe la giusta promozione e passò inosservata. Con le cover non si finisce mai di stupirsi!
Non manca un capitolo extra sui cover album, pensiamo a Pin Ups di Bowie oppure a Duemila60 Italian Graffiati di Ivan Cattaneo, che non a caso ha firmato la prefazione. Lo spirito del disco interamente dedicato a un altrui album o repertorio è diverso da quello della singola cover?
Sì. O meglio è diverso nell’ambito di quegli album di cover che non sono una mera raccolta di canzoni già famose ma che hanno dietro un progetto vero e proprio. Nella parte del libro in cui parlo di questi dischi, ho considerato solo ed unicamente quelli che avevano queste caratteristiche. Gli album di cover, messi assieme per ragioni contrattuali o per mancanza di materiale, non li considero dei progetti e mediamente non mi interessano (sebbene sia possibilissimo che all’interno contengano delle cover rispettabilissime, ben inteso).
Infatti i due casi che citi sono emblematici perché appartengono esattamente a quella categoria, peraltro rappresentando il medesimo progetto in due visioni distinte, di qua e di là della Manica.
Bowie per Pin Ups scelse le canzoni della sua gioventù e le mise assieme cercando di renderle personali e così fece Cattaneo col primo suo album di cover (ne fece poi altri due ma non c’entravano più nulla col progetto iniziale. Semplicemente aveva avuto un grandissimo successo e la casa discografica gli impose di battere quel chiodo).
Nei primi anni del nuovo secolo il disco di cover era praticamente all’ordine del giorno, ma sono stati davvero pochi quelli che hanno saputo gestirlo come un progetto personale. Era più una questione legata alla crisi dei supporti fonografici. I dischi vendevano sempre meno e l’industria ha cercato di prendere quel pubblico occasionale di cui parlavamo prima di acquistare il CD di Patti Smith, magari senza conoscerla, solo perché canta Gimme Shelter dei Rolling Stones, oppure quello di Giorgia perché hanno sentito alla radio la sua versione di I Feel Love. Se ci pensi, in questo senso, le cover hanno allungato anche un po’ la vita ai dischi. Una cosa che mi fa pensare di non sbagliare molto quando penso che tutto sommato siano un patrimonio formidabile della cultura popolare.