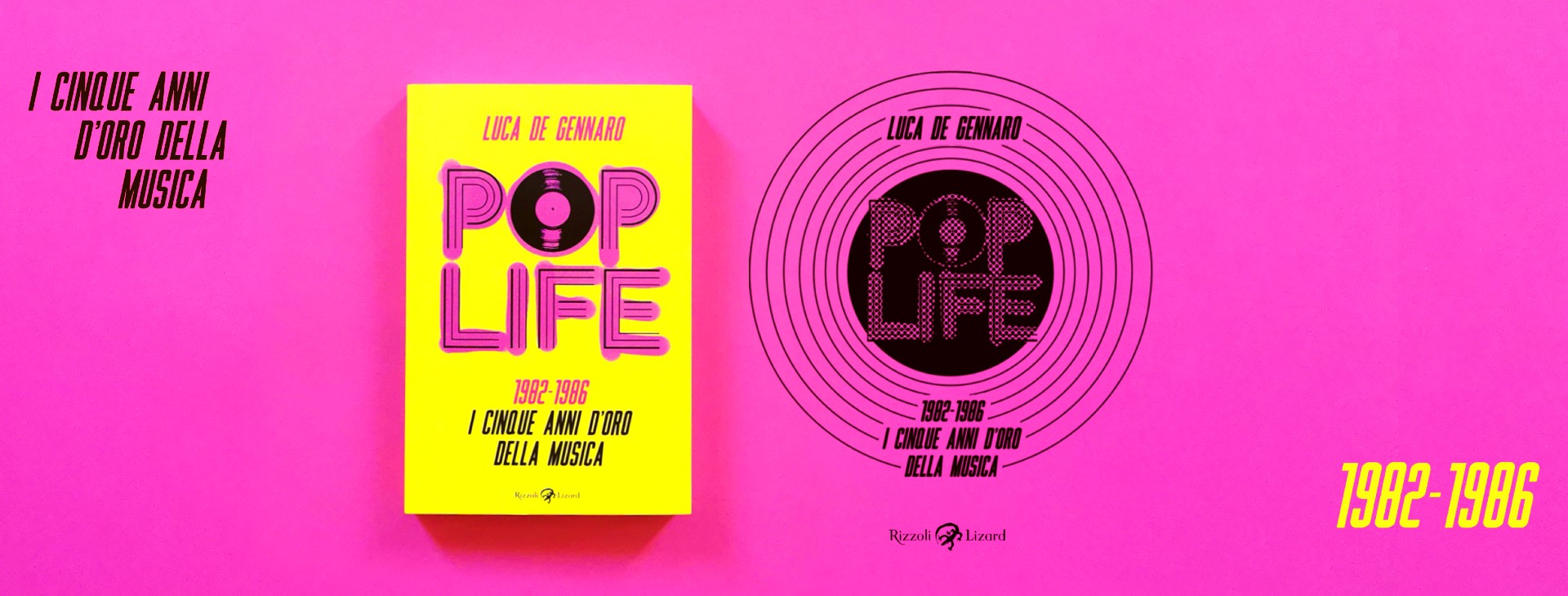Non mi piacciono i Pooh. Probabilmente questa posizione sarà anche condivisa da una fetta di lettori di Jam, e sarebbe un grande errore. Perché nel bene e nel male, nella leggerezza ma anche nella ricerca di un senso autentico, i Pooh sono stati un pezzo di storia della musica leggera italiana, con una coerenza e una professionalità innegabili. Grazie a Il grande libro dei Pooh (Mondadori Electa), è maturata una notevole curiosità verso la loro esperienza, con la voglia di capire e di evitare il facile sfottò. Andrea Pedrinelli ne ha raccontato la storia, garantita dal marchio di “ufficialità”, tra canzoni e immagini: lo ha fatto egregiamente, tanto da convincere uno scettico radicale come il sottoscritto.
La bibliografia sui Pooh, a partire dal 1985, è abbondante, e questo tuo libro è “grande” ma soprattutto “ufficiale”. Cosa aggiunge alla letteratura in materia?
Diverse cose. Intanto, ovviamente, racconta tutta la storia sino alla fine, l’ultimo libro sui Pooh risaliva al 2009; inoltre e purtroppo è definitivo, perché la storia è finita. Rispetto ai libri precedenti, poi, c’è dietro un lungo lavoro di raccolta dati –di ogni forma – che svolgo in pratica da quando ero loro fan, dall’84/85 dunque: pensa che solo di rassegna stampa ho in casa undici faldoni pieni di articoli, recensioni, dossier dal ’66 al 2016; e poi le centinaia di apparizioni televisive registrate, gli appunti presi ai concerti, i miei tanti incontri con loro, tantissimi materiali di merchandising o per la stampa che fotografati non s’erano mai visti in un libro…
Inoltre Stefano D’Orazio mi ha dato materiali prima riservati ai loro uffici, dai “progetti” che i Pooh imbastivano su ogni opera discografica alle sue agende; e ho intervistato oltre trenta persone, ex-Pooh e una marea di collaboratori, tutti finalmente in grado di parlare della storia del gruppo senza filtri o equilibri da rispettare, proprio perché la storia è finita. E che il libro sia la verità finale sui Pooh lo hanno confermato loro: sposandolo sino a donargli logo, prefazioni, materiali d’archivio, la qualifica appunto di “ufficiale”.
La storia dei Pooh attraversa formazioni, fasi, ere. Qual è il filo conduttore di questa avventura durata mezzo secolo?
Direi saper sposare un grande talento con un’immensa professionalità. La capacità di creare musica nuova, musica originale, musica che arriva alla gente, con un lavoro durissimo e senza requie condotto giorno per giorno dietro le quinte.
I Pooh li ho conosciuti quasi tutti tranne Bob Gillott e Gilberto Faggioli, sono belle persone prima ancora che artisti di livello: credibilità e serietà unite alla qualità della proposta musicale hanno non solo fatto la differenza, ma rappresentato un unicum spesso invidiato – nel libro lo racconto – dai colleghi delle altre band. Credo che la loro storia sarebbe da insegnare ai giovani aspiranti artisti: il talento non basta. Se non sapete mettervi in gioco in toto e lavorare duro, se non sapete rinunciare alle pure apparenze e magari anche sacrificarvi in vari modi, il frutto del vostro talento non arriverà o non potrà durare.
Musicalmente parlando, la cifra-filo conduttore dei Pooh è invece il pop-rock sinfonico con la scrittura “colta” di Facchinetti che vola nelle suite e non si limita alla forma-canzone tradizionale, e la penna di Negrini che è una delle più importanti e coraggiose di sempre. Per me, la massima penna italiana.
Parlare di “pop” nel caso dei Pooh è corretto ma anche fuorviante visto che hanno mutato pelle, linguaggi e obiettivi nell’arco di cinquant’anni. Quale pensi sia la loro dimensione più rappresentativa?
I Pooh “veri” stanno in pezzi come Parsifal, Il tempo una donna la città, Per te qualcosa ancora, Io e te per altri giorni, Padre del fuoco padre del tuono padre del nulla, ma anche – sono canzoni più lievi ma non troppo – Rotolando respirando, Inca, Grandi speranze, Dove comincia il sole, le stesse Giorni infiniti o Buona fortuna. Il top dei Pooh è lì dentro, e in strumentali come Fantastic Fly, La gabbia, Concerto per un’oasi. Ma subito dopo c’è quello che mi piace chiamare, stante la qualità di Valerio Negrini paroliere, “pop d’autore”: musica certo leggera, ma con testi mica tanto leggeri, e anche arrangiamenti, polifonie, sound davvero notevoli nelle varie epoche. Qui potrei citarti Classe ’58, Tu dov’eri, Se c’è un posto nel tuo cuore, In diretta nel vento, Una donna normale, Ricostruire un amore, Ascolta, Lettera da Berlino Est, Mai dire mai, Passaporto per le stelle, Quasi città… E nota che non ho citato ancora nessuna hit! Hit che nel caso dei Pooh sono state almeno una quarantina, da Piccola Katy del ’66 a Tanta voglia di lei, Uomini soli, Chi fermerà la musica, Io sono vivo, La donna del mio amico, Noi due nel mondo e nell’anima, quella Pensiero che parlava di un carcerato… nel ’71.
Nell’immaginario collettivo i Pooh sono i quattro Roby, Dodi, Red e Stefano, ma è corretto considerarli un sestetto con Riccardo Fogli e Valerio Negrini. Quanto sono stati importanti questi due nella loro storia?
Riccardo è stato importante ma non quanto gli altri: e lui stesso, con molto pudore, lo ricorda spesso. Però ha segnato con una voce strepitosa i primi successi: Piccola Katy, Pensiero, Nascerò con te. E nel 2016 il suo ritorno in gruppo ha dato forza al successo dell’ultimo tour: stando agli addetti ai lavori, organizzatori eccetera, è anzi stato la chiave del successo del gran finale. Per molti fan e anche per me questa non è una lettura corretta al cento per cento, ma per chi organizzava il tour la presenza di Fogli era la vera “novità”. Che poi sul palco ha comunque impreziosito le polifonie in maniera straordinaria.
Valerio invece è decisivo, forse più di ogni altro. Intanto è il padre dei Pooh. Li ha voluti lui, sin dal ’62 li voleva creare come gruppo capace di lasciare un segno con le parole quanto con la musica, e così è stato. Poi per fortuna di tutti, credo, Negrini è uscito dalle “regole” – che peraltro hanno garantito la stabilità del gruppo – per vivere libero, da Poeta come è stato giustamente definito. E la sua Poesia ha permesso ai Pooh di colpire con originalità il pubblico, di restare negli anni, di rimanere agganciati alla realtà della gente, di essere i primi a cantare tematiche sociali importanti come omosessualità o razzismo. La sua Poesia ha poi permesso alla band di restare in piedi dopo l’addio di Stefano nel 2009, superato grazie a un disco (Dove comincia il sole) di testi inarrivabili; la sua scomparsa, ormai a posteriori si può esserne certi, ha definito che non si poteva che chiudere bottega. In un modo o nell’altro. Avrebbero avuto senso i Pooh senza i testi di Valerio? No, proprio no.
Molto spesso, a fronte di scelte musicali magari più deboli o poco ispirate, i suoi testi sono stati un vero punto di forza. Quali tematiche ha privilegiato?
Valerio era un personaggio strano. Difficile e sensibilissimo. Era molto attento alla tecnica, al suono delle parole, alle metriche, a non ripetersi, ma soprattutto ha saputo tenere le produzioni della band saldamente ancorate alla realtà quotidiana di chi ne comprava i dischi. Sul piano dello scrivere d’amore, ci sono dei tocchi di rispetto della donna che sono unici nelle liriche di Negrini; ma certo la sua straordinarietà è stato aver sempre presente i valori dell’uomo. Per poi farli cantare ai Pooh (ma anche a Eugenio Finardi a inizio anni Ottanta, in modo molto più “politico”, o a Milva nel ’93 provocando) alternando riflessione, denuncia, poesia e presa di coscienza ante litteram di tante storture.
Il suo capolavoro diceva fosse Ascolta, e non è sbagliato, perché è una tavola – umanissima – dei valori del vivere. Come Il giorno prima o Passaporto per le stelle. Però certo a me diede tanto con Senza frontiere, che nell’88 (!) portò nel mio mondo di adolescente la coscienza del rischio del razzismo per gli extracomunitari, come pure il fatto che in Sudafrica c’era l’apartheid e Mandela era in carcere. E poi Pierre con la sua sensibilità per i cosiddetti “diversi”, il cantare in modo violentissimo ma poetico la guerra (vista dagli occhi di un bambino col papà al fronte del Kosovo, in Padre a vent’anni) o lo stupro (Il silenzio della colomba), la prostituzione o gli zingari, Tien An Men o le battaglie femministe. Padre del fuoco padre del tuono padre del nulla, del ’76, credo sia un capolavoro assoluto di sintesi di quanto il genere umano ha fatto nel bene e nel male nella storia del mondo, tra invenzioni e smania d’onnipotenza. Davvero, penso Valerio andrebbe studiato nelle scuole: curioso di tutto, ha saputo parlare di tutto. E peccato che i Pooh troppo spesso certe canzoni dal vivo non le facessero: come fai a convincere i critici che non canti banalità se in un disco di temi sociali come Poohlover il singolo è l’unica canzone d’amore, Linda? Anche questa critica, con le risposte a essa dei Pooh, fa parte d’un libro che vuole analizzare davvero la loro magnifica storia.
Inevitabile parlare dei quattro. Il segreto della loro stabilità è stato l’alchimia tra ruoli e compiti diversi. Se volessimo usare pochi aggettivi per inquadrare Red, Dodi, Roby e Stefano, quali sceglieresti?
Per tutti talentuoso e umile, capace cioè di sacrificarsi, quando serviva, per il bene del progetto.
Red è una persona dolce, creativa, elegante per cultura, e il suo musical/opera pop Casanova lo sta dimostrando.
Dodi un musicista pazzesco ma anche pudico, che si mette al servizio della Musica dall’arrangiamento all’assolo, e un uomo perbene.
Roby è un gigante della composizione ma soprattutto un’anima pura, un artista vero, una persona d’una bontà straordinaria.
E Stefano era, purtroppo al passato, un’intelligenza rara: aveva visione, lucidità, arguzia, ironia e autoironia, nonché una sensibilità che nascondeva spesso dietro la coltre del sarcasmo, per non farsi ferire.
In un pugno di dischi di metà anni ’70, direi da Parsifal a Boomerang, i Pooh sembrava facessero davvero sul serio, con sonorità dal respiro internazionale. È forse quello il meglio della loro storia?
Probabilmente sì, comprendendo però anche Viva nel mucchio. La scelta di un pop più lieve, praticata dopo gli anni con l’orchestra e il produttore Lucariello, ha via via distolto la band dalle suite e dagli strumentali; poi l’involuzione della musica “per il mercato” ne ha semplificato certi arrangiamenti geniali e molto complessi (Dodi in questo era strepitoso, a dir poco, basta ascoltare appunto Boomerang); e alla fine il tempo che passava li ha spinti a dividersi sin troppo –per restare insieme sempre in parità fra loro – brani da incidere, parti vocali, presenze sul proscenio dei live. Sino ad una sorta di “gioco dei quattro cantoni”, come l’ha definito un critico. Certo i Pooh al top – vedi Ascolta – hanno colpito anche “dopo”, ma in quegli anni ‘70 hanno toccato vette inarrivabili anche nel cosiddetto, più semplice, pop.
Anche i Pooh hanno conosciuto esperienze soliste, in tempi e con esiti diversi. I loro album in proprio aggiungono qualcosa di rilevante alla discografia del gruppo?
Stando a Dodi, che ne parlò già all’epoca, hanno permesso a idee diverse da quelle della routine d’infiltrarsi nei loro meccanismi compositivi e sonori. Certo però hanno fatto e ora fanno cose molto diverse, perché Red è più interprete e guarda al teatro anche in modo sanamente istrionico, pur se sempre con classe; Dodi agisce molto da music maker all’americana (e guarda all’America); e Roby… è i Pooh in versione singola. La cifra musicale dei Pooh si ritrova, nei dischi solisti di Facchinetti; e suoi capolavori come Fai col cuore o Insieme, il disco con Riccardo Fogli, sono all’altezza dei migliori album della band.
Per gli altri non si può dire questo, invece, perché fuori dal gruppo usano proprio linguaggi diversi da quelli dei Pooh. Credo abbiano fatto comunque dignitosissime carriere solistiche, che quand’erano ancora “i Pooh” hanno permesso loro anche di togliersi qualche sfizio – vedi il capolavoro strumentale D’assolo di Battaglia, o le collaborazioni di Red con Conte e Vecchioni – senza finire col litigare dentro la “macchina della musica”. D’Orazio invece non aveva velleità musicali, ma si è creato un bel repertorio di testi, dai musical ai romanzi, sfogando così la propria personalità oltre il gruppo, e anche proponendo stili nuovi di scrittura.
Pooh dal vivo. Ambiziosi, competitivi, imponenti. Stando anche alla mole di immagini inserite nel libro, si potrebbe raccontare una “controstoria” del gruppo live…
Sicuramente. Sono stati i primi in molte cose. Dagli effetti speciali che Baglioni, De Gregori o Zero andavano a spiare, all’osarsi in teatro o in acustica. Una cosa molto bella dei Pooh, che non ho riscontrato in artisti che pure ammiro come per esempio Vasco, è stato poi il saper mutare continuamente arrangiamenti e modo di proposta dei classici. Ora in medley ora piano e voce, ora riletti coi fiati ora in acustica, difficilmente nei loro concerti sentivi sempre le stesse cose: magari molte canzoni si ripetevano anche troppo, a scapito di qualche perla nascosta, ma comunque te le suonavano sempre in modo diverso. E ogni volta si inventavano qualcosa che stupiva, che lasciava il segno, soprattutto – parlo da fan, anni 80/90 – che ti faceva tornare a casa contento di aver speso il prezzo del biglietto. Non capitava mica, con altri…
Spesso sono stati accostati ai Beatles, in chiave italiana. Il paragone regge?
In un ambito culturale e compositivo ovviamente diverso, credo di sì. Quattro talenti, la fortuna di trovarsi, saper creare musica riconoscibile, nuova, sedimentando nella gente il “marchio” Pooh – anche sonoro e vocale – come sicurezza assoluta, e i loro volti come amici di famiglia. Poi i Beatles hanno rivoluzionato il mondo in pochi anni, certo; i Pooh in compenso non sono mai scesi da standard più che dignitosi rimanendo sulla breccia con canzoni valide e nuove per cinquant’anni.
E sicuramente, se uno si limita a prendere i dischi del loro boom, da Opera prima a Parsifal, la coppia Facchinetti-Negrini per la musica italiana con reminiscenze colte, e per la nostra “canzonetta”, ha avuto un peso pari a quello nel mondo di Lennon-McCartney. Finardi mi ha detto cose incredibili, su di loro, paragonandoli anche a Mozart e Da Ponte. E so che un giorno, mentre masterizzavano una loro antologia a Londra, proprio un certo Paul McCartney si è fiondato in sala a chiedere “Ma chi è? Ma chi scrive queste meraviglie?”. Quincy Jones l’ha campionato, Facchinetti… Non saranno stati proprio i Beatles, insomma, ma dobbiamo esserne orgogliosi, in Italia.
50 anni di attività, milioni di copie vendute, canzoni sedimentate nella memoria collettiva. Qual è il lascito profondo dei Pooh nella cultura popolare italiana?
Credo sia il concetto d’una musica italiana che sa curare le ferite ma anche andare di sciabola, perbene ma non banale, per tutti ma non buttata via, basata sulla qualità dentro e fuori i dischi o il palco. Però come eredità stretta mi basterebbe che questo Paese ne tutelasse le opere discografiche, sai? Ci dimentichiamo dei grandi prima ancora che scompaiano, vedi Bindi o Endrigo, e invece dovremmo rispettare di più la nostra storia musicale, fatta di tanti linguaggi: non ci devono piacere tutti per forza, ma se sapessimo tramandarli… Ci sono, ci sono stati! Penso ai Pooh come a Mango, a Jannacci, a Mimì, non solo a coloro che per fortuna vengono sempre studiati: Battisti, De André. Teniamoli vivi, i giganti. Tutti. I Pooh al cosiddetto “popolo dei Pooh” hanno poi dato tanto anche oltre la musica, e io posso personalmente dire che mi hanno salvato spesso; ma ti ripeto, mi basterebbe che se ne conservasse il repertorio. La grande qualità musicale pensata, lavorata, incisa in mezzo secolo.
La bibliografia sui Pooh, a partire dal 1985, è abbondante, e questo tuo libro è “grande” ma soprattutto “ufficiale”. Cosa aggiunge alla letteratura in materia?
Diverse cose. Intanto, ovviamente, racconta tutta la storia sino alla fine, l’ultimo libro sui Pooh risaliva al 2009; inoltre e purtroppo è definitivo, perché la storia è finita. Rispetto ai libri precedenti, poi, c’è dietro un lungo lavoro di raccolta dati –di ogni forma – che svolgo in pratica da quando ero loro fan, dall’84/85 dunque: pensa che solo di rassegna stampa ho in casa undici faldoni pieni di articoli, recensioni, dossier dal ’66 al 2016; e poi le centinaia di apparizioni televisive registrate, gli appunti presi ai concerti, i miei tanti incontri con loro, tantissimi materiali di merchandising o per la stampa che fotografati non s’erano mai visti in un libro…
Inoltre Stefano D’Orazio mi ha dato materiali prima riservati ai loro uffici, dai “progetti” che i Pooh imbastivano su ogni opera discografica alle sue agende; e ho intervistato oltre trenta persone, ex-Pooh e una marea di collaboratori, tutti finalmente in grado di parlare della storia del gruppo senza filtri o equilibri da rispettare, proprio perché la storia è finita. E che il libro sia la verità finale sui Pooh lo hanno confermato loro: sposandolo sino a donargli logo, prefazioni, materiali d’archivio, la qualifica appunto di “ufficiale”.
La storia dei Pooh attraversa formazioni, fasi, ere. Qual è il filo conduttore di questa avventura durata mezzo secolo?
Direi saper sposare un grande talento con un’immensa professionalità. La capacità di creare musica nuova, musica originale, musica che arriva alla gente, con un lavoro durissimo e senza requie condotto giorno per giorno dietro le quinte.
I Pooh li ho conosciuti quasi tutti tranne Bob Gillott e Gilberto Faggioli, sono belle persone prima ancora che artisti di livello: credibilità e serietà unite alla qualità della proposta musicale hanno non solo fatto la differenza, ma rappresentato un unicum spesso invidiato – nel libro lo racconto – dai colleghi delle altre band. Credo che la loro storia sarebbe da insegnare ai giovani aspiranti artisti: il talento non basta. Se non sapete mettervi in gioco in toto e lavorare duro, se non sapete rinunciare alle pure apparenze e magari anche sacrificarvi in vari modi, il frutto del vostro talento non arriverà o non potrà durare.
Musicalmente parlando, la cifra-filo conduttore dei Pooh è invece il pop-rock sinfonico con la scrittura “colta” di Facchinetti che vola nelle suite e non si limita alla forma-canzone tradizionale, e la penna di Negrini che è una delle più importanti e coraggiose di sempre. Per me, la massima penna italiana.
Parlare di “pop” nel caso dei Pooh è corretto ma anche fuorviante visto che hanno mutato pelle, linguaggi e obiettivi nell’arco di cinquant’anni. Quale pensi sia la loro dimensione più rappresentativa?
I Pooh “veri” stanno in pezzi come Parsifal, Il tempo una donna la città, Per te qualcosa ancora, Io e te per altri giorni, Padre del fuoco padre del tuono padre del nulla, ma anche – sono canzoni più lievi ma non troppo – Rotolando respirando, Inca, Grandi speranze, Dove comincia il sole, le stesse Giorni infiniti o Buona fortuna. Il top dei Pooh è lì dentro, e in strumentali come Fantastic Fly, La gabbia, Concerto per un’oasi. Ma subito dopo c’è quello che mi piace chiamare, stante la qualità di Valerio Negrini paroliere, “pop d’autore”: musica certo leggera, ma con testi mica tanto leggeri, e anche arrangiamenti, polifonie, sound davvero notevoli nelle varie epoche. Qui potrei citarti Classe ’58, Tu dov’eri, Se c’è un posto nel tuo cuore, In diretta nel vento, Una donna normale, Ricostruire un amore, Ascolta, Lettera da Berlino Est, Mai dire mai, Passaporto per le stelle, Quasi città… E nota che non ho citato ancora nessuna hit! Hit che nel caso dei Pooh sono state almeno una quarantina, da Piccola Katy del ’66 a Tanta voglia di lei, Uomini soli, Chi fermerà la musica, Io sono vivo, La donna del mio amico, Noi due nel mondo e nell’anima, quella Pensiero che parlava di un carcerato… nel ’71.
Nell’immaginario collettivo i Pooh sono i quattro Roby, Dodi, Red e Stefano, ma è corretto considerarli un sestetto con Riccardo Fogli e Valerio Negrini. Quanto sono stati importanti questi due nella loro storia?
Riccardo è stato importante ma non quanto gli altri: e lui stesso, con molto pudore, lo ricorda spesso. Però ha segnato con una voce strepitosa i primi successi: Piccola Katy, Pensiero, Nascerò con te. E nel 2016 il suo ritorno in gruppo ha dato forza al successo dell’ultimo tour: stando agli addetti ai lavori, organizzatori eccetera, è anzi stato la chiave del successo del gran finale. Per molti fan e anche per me questa non è una lettura corretta al cento per cento, ma per chi organizzava il tour la presenza di Fogli era la vera “novità”. Che poi sul palco ha comunque impreziosito le polifonie in maniera straordinaria.
Valerio invece è decisivo, forse più di ogni altro. Intanto è il padre dei Pooh. Li ha voluti lui, sin dal ’62 li voleva creare come gruppo capace di lasciare un segno con le parole quanto con la musica, e così è stato. Poi per fortuna di tutti, credo, Negrini è uscito dalle “regole” – che peraltro hanno garantito la stabilità del gruppo – per vivere libero, da Poeta come è stato giustamente definito. E la sua Poesia ha permesso ai Pooh di colpire con originalità il pubblico, di restare negli anni, di rimanere agganciati alla realtà della gente, di essere i primi a cantare tematiche sociali importanti come omosessualità o razzismo. La sua Poesia ha poi permesso alla band di restare in piedi dopo l’addio di Stefano nel 2009, superato grazie a un disco (Dove comincia il sole) di testi inarrivabili; la sua scomparsa, ormai a posteriori si può esserne certi, ha definito che non si poteva che chiudere bottega. In un modo o nell’altro. Avrebbero avuto senso i Pooh senza i testi di Valerio? No, proprio no.
Molto spesso, a fronte di scelte musicali magari più deboli o poco ispirate, i suoi testi sono stati un vero punto di forza. Quali tematiche ha privilegiato?
Valerio era un personaggio strano. Difficile e sensibilissimo. Era molto attento alla tecnica, al suono delle parole, alle metriche, a non ripetersi, ma soprattutto ha saputo tenere le produzioni della band saldamente ancorate alla realtà quotidiana di chi ne comprava i dischi. Sul piano dello scrivere d’amore, ci sono dei tocchi di rispetto della donna che sono unici nelle liriche di Negrini; ma certo la sua straordinarietà è stato aver sempre presente i valori dell’uomo. Per poi farli cantare ai Pooh (ma anche a Eugenio Finardi a inizio anni Ottanta, in modo molto più “politico”, o a Milva nel ’93 provocando) alternando riflessione, denuncia, poesia e presa di coscienza ante litteram di tante storture.
Il suo capolavoro diceva fosse Ascolta, e non è sbagliato, perché è una tavola – umanissima – dei valori del vivere. Come Il giorno prima o Passaporto per le stelle. Però certo a me diede tanto con Senza frontiere, che nell’88 (!) portò nel mio mondo di adolescente la coscienza del rischio del razzismo per gli extracomunitari, come pure il fatto che in Sudafrica c’era l’apartheid e Mandela era in carcere. E poi Pierre con la sua sensibilità per i cosiddetti “diversi”, il cantare in modo violentissimo ma poetico la guerra (vista dagli occhi di un bambino col papà al fronte del Kosovo, in Padre a vent’anni) o lo stupro (Il silenzio della colomba), la prostituzione o gli zingari, Tien An Men o le battaglie femministe. Padre del fuoco padre del tuono padre del nulla, del ’76, credo sia un capolavoro assoluto di sintesi di quanto il genere umano ha fatto nel bene e nel male nella storia del mondo, tra invenzioni e smania d’onnipotenza. Davvero, penso Valerio andrebbe studiato nelle scuole: curioso di tutto, ha saputo parlare di tutto. E peccato che i Pooh troppo spesso certe canzoni dal vivo non le facessero: come fai a convincere i critici che non canti banalità se in un disco di temi sociali come Poohlover il singolo è l’unica canzone d’amore, Linda? Anche questa critica, con le risposte a essa dei Pooh, fa parte d’un libro che vuole analizzare davvero la loro magnifica storia.
Inevitabile parlare dei quattro. Il segreto della loro stabilità è stato l’alchimia tra ruoli e compiti diversi. Se volessimo usare pochi aggettivi per inquadrare Red, Dodi, Roby e Stefano, quali sceglieresti?
Per tutti talentuoso e umile, capace cioè di sacrificarsi, quando serviva, per il bene del progetto.
Red è una persona dolce, creativa, elegante per cultura, e il suo musical/opera pop Casanova lo sta dimostrando.
Dodi un musicista pazzesco ma anche pudico, che si mette al servizio della Musica dall’arrangiamento all’assolo, e un uomo perbene.
Roby è un gigante della composizione ma soprattutto un’anima pura, un artista vero, una persona d’una bontà straordinaria.
E Stefano era, purtroppo al passato, un’intelligenza rara: aveva visione, lucidità, arguzia, ironia e autoironia, nonché una sensibilità che nascondeva spesso dietro la coltre del sarcasmo, per non farsi ferire.
In un pugno di dischi di metà anni ’70, direi da Parsifal a Boomerang, i Pooh sembrava facessero davvero sul serio, con sonorità dal respiro internazionale. È forse quello il meglio della loro storia?
Probabilmente sì, comprendendo però anche Viva nel mucchio. La scelta di un pop più lieve, praticata dopo gli anni con l’orchestra e il produttore Lucariello, ha via via distolto la band dalle suite e dagli strumentali; poi l’involuzione della musica “per il mercato” ne ha semplificato certi arrangiamenti geniali e molto complessi (Dodi in questo era strepitoso, a dir poco, basta ascoltare appunto Boomerang); e alla fine il tempo che passava li ha spinti a dividersi sin troppo –per restare insieme sempre in parità fra loro – brani da incidere, parti vocali, presenze sul proscenio dei live. Sino ad una sorta di “gioco dei quattro cantoni”, come l’ha definito un critico. Certo i Pooh al top – vedi Ascolta – hanno colpito anche “dopo”, ma in quegli anni ‘70 hanno toccato vette inarrivabili anche nel cosiddetto, più semplice, pop.
Anche i Pooh hanno conosciuto esperienze soliste, in tempi e con esiti diversi. I loro album in proprio aggiungono qualcosa di rilevante alla discografia del gruppo?
Stando a Dodi, che ne parlò già all’epoca, hanno permesso a idee diverse da quelle della routine d’infiltrarsi nei loro meccanismi compositivi e sonori. Certo però hanno fatto e ora fanno cose molto diverse, perché Red è più interprete e guarda al teatro anche in modo sanamente istrionico, pur se sempre con classe; Dodi agisce molto da music maker all’americana (e guarda all’America); e Roby… è i Pooh in versione singola. La cifra musicale dei Pooh si ritrova, nei dischi solisti di Facchinetti; e suoi capolavori come Fai col cuore o Insieme, il disco con Riccardo Fogli, sono all’altezza dei migliori album della band.
Per gli altri non si può dire questo, invece, perché fuori dal gruppo usano proprio linguaggi diversi da quelli dei Pooh. Credo abbiano fatto comunque dignitosissime carriere solistiche, che quand’erano ancora “i Pooh” hanno permesso loro anche di togliersi qualche sfizio – vedi il capolavoro strumentale D’assolo di Battaglia, o le collaborazioni di Red con Conte e Vecchioni – senza finire col litigare dentro la “macchina della musica”. D’Orazio invece non aveva velleità musicali, ma si è creato un bel repertorio di testi, dai musical ai romanzi, sfogando così la propria personalità oltre il gruppo, e anche proponendo stili nuovi di scrittura.
Pooh dal vivo. Ambiziosi, competitivi, imponenti. Stando anche alla mole di immagini inserite nel libro, si potrebbe raccontare una “controstoria” del gruppo live…
Sicuramente. Sono stati i primi in molte cose. Dagli effetti speciali che Baglioni, De Gregori o Zero andavano a spiare, all’osarsi in teatro o in acustica. Una cosa molto bella dei Pooh, che non ho riscontrato in artisti che pure ammiro come per esempio Vasco, è stato poi il saper mutare continuamente arrangiamenti e modo di proposta dei classici. Ora in medley ora piano e voce, ora riletti coi fiati ora in acustica, difficilmente nei loro concerti sentivi sempre le stesse cose: magari molte canzoni si ripetevano anche troppo, a scapito di qualche perla nascosta, ma comunque te le suonavano sempre in modo diverso. E ogni volta si inventavano qualcosa che stupiva, che lasciava il segno, soprattutto – parlo da fan, anni 80/90 – che ti faceva tornare a casa contento di aver speso il prezzo del biglietto. Non capitava mica, con altri…
Spesso sono stati accostati ai Beatles, in chiave italiana. Il paragone regge?
In un ambito culturale e compositivo ovviamente diverso, credo di sì. Quattro talenti, la fortuna di trovarsi, saper creare musica riconoscibile, nuova, sedimentando nella gente il “marchio” Pooh – anche sonoro e vocale – come sicurezza assoluta, e i loro volti come amici di famiglia. Poi i Beatles hanno rivoluzionato il mondo in pochi anni, certo; i Pooh in compenso non sono mai scesi da standard più che dignitosi rimanendo sulla breccia con canzoni valide e nuove per cinquant’anni.
E sicuramente, se uno si limita a prendere i dischi del loro boom, da Opera prima a Parsifal, la coppia Facchinetti-Negrini per la musica italiana con reminiscenze colte, e per la nostra “canzonetta”, ha avuto un peso pari a quello nel mondo di Lennon-McCartney. Finardi mi ha detto cose incredibili, su di loro, paragonandoli anche a Mozart e Da Ponte. E so che un giorno, mentre masterizzavano una loro antologia a Londra, proprio un certo Paul McCartney si è fiondato in sala a chiedere “Ma chi è? Ma chi scrive queste meraviglie?”. Quincy Jones l’ha campionato, Facchinetti… Non saranno stati proprio i Beatles, insomma, ma dobbiamo esserne orgogliosi, in Italia.
50 anni di attività, milioni di copie vendute, canzoni sedimentate nella memoria collettiva. Qual è il lascito profondo dei Pooh nella cultura popolare italiana?
Credo sia il concetto d’una musica italiana che sa curare le ferite ma anche andare di sciabola, perbene ma non banale, per tutti ma non buttata via, basata sulla qualità dentro e fuori i dischi o il palco. Però come eredità stretta mi basterebbe che questo Paese ne tutelasse le opere discografiche, sai? Ci dimentichiamo dei grandi prima ancora che scompaiano, vedi Bindi o Endrigo, e invece dovremmo rispettare di più la nostra storia musicale, fatta di tanti linguaggi: non ci devono piacere tutti per forza, ma se sapessimo tramandarli… Ci sono, ci sono stati! Penso ai Pooh come a Mango, a Jannacci, a Mimì, non solo a coloro che per fortuna vengono sempre studiati: Battisti, De André. Teniamoli vivi, i giganti. Tutti. I Pooh al cosiddetto “popolo dei Pooh” hanno poi dato tanto anche oltre la musica, e io posso personalmente dire che mi hanno salvato spesso; ma ti ripeto, mi basterebbe che se ne conservasse il repertorio. La grande qualità musicale pensata, lavorata, incisa in mezzo secolo.