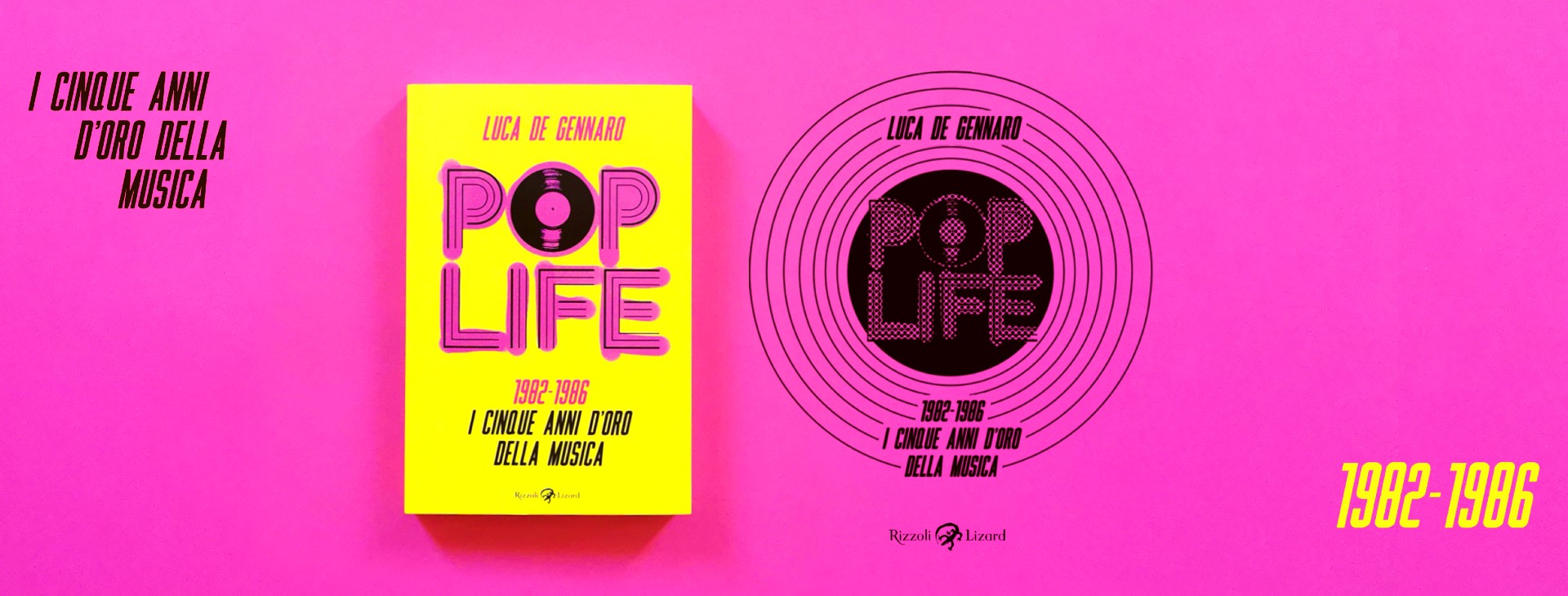Luca Pollini è uno dei saggisti italiani più prolifici. A volte è difficile stargli dietro, ma ciò che sorprende maggiormente è la trasversalità del suo sguardo. Negli ultimi due anni è passato da Gianni Sassi a Mario Lavezzi, da Re Nudo a Woodstock, senza menzionare testi di argomento extra musicale. Il suo ultimo libro, pubblicato da Tempesta Editore e aperto dalla prefazione di Carlo Massarini, è un atto d’amore verso il rock. Inevitabile stanarlo per i lettori di Jam.
Nella tua bio affermi: Credo nel rock.
Basta questo per capire molte cose di te, peraltro ben affrontate in La mia storia suona il rock. È la storia della tua vita?
Non si tratta di un’autobiografia vera e propria, ma di un percorso soggettivo storico-sociologico, ovviamente. Racconto quello che è accaduto e quella che è stata la colonna sonora della mia storia, che è fatta non solo di rock e buona musica italiana, ma anche da tormentoni estivi alla discomusic, dalla canzone politica alla techno, perché nelle mie orecchie è entrato di tutto.
Un gesto ricorrente nella lettura dei tuoi testi, oserei dire irresistibile, è quello di sfilare un vinile e metterlo su. Un gesto simbolico, carico di valori: parlarne, o come fai tu raccontarlo, è sinonimo di nostalgia o pensi che sia una pratica ancora significativa?
Per quelli della mia generazione la musica era tutto, gli LP erano oggetti da studiare con molta attenzione, perché da lì, dai quei solchi, passava la nostra formazione. È proprio dalla metà degli anni Settanta che in Italia un certo tipo di musica assume il carattere di simbolo d’identità e da semplice forma di intrattenimento si trasforma in strumento di protesta, lotta e denuncia sociale. E in quegli anni si assiste a un vero e proprio boom dell’industria discografica. Oggi si parla di un “ritorno al vinile”, ma la vedo più come un vezzo vintage e non come una pratica significativa. È totalmente cambiato il modo di ascoltare e fruire la musica, e non sono sicuro che sia cambiato in meglio, perché nella maggioranza dei casi oggi si tratta di un ascolto distratto.
Anche in questo libro sei attento alle connessioni – a mio avviso del tutto inestricabili – tra rock e politica. Il rock come colonna sonora dei cambiamenti sociali, dall’avvento dei baby boomer al riflusso passando per il Vietnam. È stato davvero un elemento importante per il Novecento?
Ho sempre pensato che il rapporto tra musica e storia sia molto stretto, una relazione non solo personale, ma anche collettiva. Con lo scorrere dei decenni il rock – in tutte le sue forme e varianti – si è trasformato sia in un linguaggio attraverso il quale le generazioni comunicano sia in una sorta di strumento di protesta, lotta e denuncia sociale. Prima negli Stati Uniti, poi in Europa, i giovani scendono in piazza per ribellarsi a un sistema che gli andava stretto e lo hanno fatto urlando e, soprattutto, suonando e cantando, trasformando così la musica in grande collante della contestazione. Si è passati dal rock alla disco, dal punk alla techno ai rave, con canzoni e suoni che tra le loro tracce hanno inneggiato a proteste, emancipazioni, conquiste, che hanno diffuso ideologie, pensieri, idee di rivolta e di ribellione. Spesso musica e canzoni si sono trasformate in un salvagente a cui aggrapparsi.
La prefazione di Carlo Massarini ci incatena – piacevolmente, ça va sans dire – a un tempo in cui fare radio e più in generale divulgazione musicale era impegnativo, gratificante, oserei dire pedagogico. Quando è cambiato questo modo di informare?
A mio avviso, il modo di informare è cambiato alla fine degli anni Novanta, quando il web è iniziato a crescere; ma la vera rivoluzione mi verrebbe da dire che si è avuta nel 2004, l’anno in cui è stato lanciato Facebook. Da allora si prediligono informazioni spot, non c’è spazio per l’approfondimento che una volta era motivo di distinzione tra un certo tipo di informazione e un altro. Oggi è tutto troppo omologato, la stessa critica musicale non “critica” più. E questo accade anche perché – va detto – per lanciare un album o una tournée invitano “alcuni giornalisti” (non tutti) a Londra o Parigi con volo e hotel gentilmente prenotato e pagato dall’organizzazione o dalla casa discografica, con invito e posto in prima fila, così che a nessuno poi gli scappi una seppur minima critica a quell’album o quel concerto. È vero, il web ha allargato le fonti di informazione, ha ampliato anche il bacino radiofonico – le webradio non hanno confini, si possono ascoltare in tutto il mondo – ma purtroppo si sono anche moltiplicati i giornalisti/critici musicali improvvisati.
Rimpiangi il Parco Lambro, gli Area e i tempi in cui il potere aveva paura dei giovani, tempi in cui effettivamente il potere mostrava il suo volto più austero e cinico. Il rock non ha distrutto quel volto ma credo abbia contribuito a smussarne alcuni elementi, come diceva Keith Richards a proposito della fine dell’URSS. Cosa ne pensi?
È vero, il “potere” in qualche modo ha sempre avuto paura del rock, in quanto cultura “progressista”. Basti ricordare come Woodstock sia riuscito a dimostrare al mondo che una rivoluzione morbida poteva essere praticata, che l’esistenza di una folla non regolamentata da controllori – polizia o forze dell’ordine – non portava naturalmente verso il caos perché comunità libera (sul prato a Bethel erano mezzo milione) si è tranquillamente autoregolamentata. Stessa cosa che è accaduta al Parco Lambro, quando nonostante il Comune non avesse concesso l’allacciamento all’acquedotto e all’energia elettrica, e fossero giunte oltre centomila persone (gli organizzatori se ne aspettavano meno della metà) non è successo nulla di grave, nessuna tragedia, nessun incidente. Poi in Italia tutto collassa: droga, terrorismo, violenza. Anche in Europa quella che poteva essere una rivoluzione “gentile” è fermata con gli stessi mezzi: spranghe, pistole, bombe, droga. Forse perché parole come pace-amore-libertà-uguaglianza hanno fanno paura. Va sottolineato che nella seconda metà degli anni Sessanta c’è stato un susseguirsi di novità, musicali e artistiche, simboli di un’epoca nuova che, senza l’uso della politica, è stata una vera rivoluzione. Una rivoluzione in musica, forte, decisa, che ha portato a cambiamenti radicali, uno fra tutti: i giovani sono stati riconosciuti come categoria sociale.
Cosa ascolta ultimamente Luca Pollini e come ascolta la musica?
Roba poco recente, d’annata, come la “quadrilogia” di Peter Gabriel; qualcosa di James Taylor; lo psichedelico If i could only remember my name, primo lavoro solista di David Crosby. Per quanto riguarda la musica italiana Area, Lucio Battisti versione “prog”, quello di Anima latina; sto riscoprendo uno dei primi album di Antonello Venditti, L’orso bruno. Poi, ovviamente, anche qualcosa di nuovo: Tash Sultana; Snarky Puppy; gli ultimi album di Nada, che trovo abbia dei testi splendidi, profondi; e giovani come Motta.
Come l’ascolto? Ancora col CD, in studio, quando lavoro; sul telefono quando sono in auto o cammino. Raramente – lo so, mi sto contraddicendo – sul vinile.
Spesso si sostiene che sia necessario avvicinare i giovani al rock. Secondo te perché il mondo dei teenager contemporanei trova più seducente la trap o, in altri casi, la caricatura rock in stile Måneskin?
Il rock è una musica popolare, che esprime in una serie di azioni comunicative, politiche e culturali. Con l’andare del tempo è cambiato, si è evoluto in stili, tendenze, sottogeneri sempre legati al mondo giovanile. Oggi ha poco appeal sulle nuove generazioni. Perché oggi non dico che il rock sia morto, ma certo non sta tanto bene. È incapace di reagire “al nuovo”, alle ondate di pop, hip hop, rap che lo travolgono. La domanda che dobbiamo porci è questa: riesce il rock a raccontare quello che siamo, a mettere in scena ansie, conflitti e desideri del nostro tempo? Mentre il pop sforna nuovi idoli senza sosta, il rock fatica ad aggiornarsi, sia nella sostanza che nell’estetica, nutrendosi del ricordo di quello che è stato, incapace di offrire nuovi eroi alle nuove generazioni attratte dal fascino sovversivo, ma che devono volgere la loro passione a ritroso, nella storia passata dei padri e dei nonni. Sono convinto che rimarrà ben poco di quello che oggi viene prodotto in campo musicale. Non è colpa di nessuno: come negli anni Sessanta e Settanta la spinta ideologica e sociale ha enormemente contribuito alla creazione di grandi capolavori, l’odierna mancanza di ideali scaturisce purtroppo l’effetto contrario. Il momento storico predilige infatti l’approccio “usa e getta”, sia dal punto di vista della produzione, sia per quanto riguarda l’utilizzo del lavoro completato.
Ci sono ovviamente buoni gruppi di giovani pieni di talento che usano un linguaggio classico ma che durano lo spazio di 2/3 album perché ancorati ancora al cliché di quattro accordi sparati da chitarre distorte, batteria con cassa e rullante in evidenza, un cantante che strilla. Tipo i Maneskin, appunto.
E ai giovani bisogna raccontare che una volta il rock era la musica più varia e fantasiosa della Terra.
Nella tua bio affermi: Credo nel rock.
Basta questo per capire molte cose di te, peraltro ben affrontate in La mia storia suona il rock. È la storia della tua vita?
Non si tratta di un’autobiografia vera e propria, ma di un percorso soggettivo storico-sociologico, ovviamente. Racconto quello che è accaduto e quella che è stata la colonna sonora della mia storia, che è fatta non solo di rock e buona musica italiana, ma anche da tormentoni estivi alla discomusic, dalla canzone politica alla techno, perché nelle mie orecchie è entrato di tutto.
Un gesto ricorrente nella lettura dei tuoi testi, oserei dire irresistibile, è quello di sfilare un vinile e metterlo su. Un gesto simbolico, carico di valori: parlarne, o come fai tu raccontarlo, è sinonimo di nostalgia o pensi che sia una pratica ancora significativa?
Per quelli della mia generazione la musica era tutto, gli LP erano oggetti da studiare con molta attenzione, perché da lì, dai quei solchi, passava la nostra formazione. È proprio dalla metà degli anni Settanta che in Italia un certo tipo di musica assume il carattere di simbolo d’identità e da semplice forma di intrattenimento si trasforma in strumento di protesta, lotta e denuncia sociale. E in quegli anni si assiste a un vero e proprio boom dell’industria discografica. Oggi si parla di un “ritorno al vinile”, ma la vedo più come un vezzo vintage e non come una pratica significativa. È totalmente cambiato il modo di ascoltare e fruire la musica, e non sono sicuro che sia cambiato in meglio, perché nella maggioranza dei casi oggi si tratta di un ascolto distratto.
Anche in questo libro sei attento alle connessioni – a mio avviso del tutto inestricabili – tra rock e politica. Il rock come colonna sonora dei cambiamenti sociali, dall’avvento dei baby boomer al riflusso passando per il Vietnam. È stato davvero un elemento importante per il Novecento?
Ho sempre pensato che il rapporto tra musica e storia sia molto stretto, una relazione non solo personale, ma anche collettiva. Con lo scorrere dei decenni il rock – in tutte le sue forme e varianti – si è trasformato sia in un linguaggio attraverso il quale le generazioni comunicano sia in una sorta di strumento di protesta, lotta e denuncia sociale. Prima negli Stati Uniti, poi in Europa, i giovani scendono in piazza per ribellarsi a un sistema che gli andava stretto e lo hanno fatto urlando e, soprattutto, suonando e cantando, trasformando così la musica in grande collante della contestazione. Si è passati dal rock alla disco, dal punk alla techno ai rave, con canzoni e suoni che tra le loro tracce hanno inneggiato a proteste, emancipazioni, conquiste, che hanno diffuso ideologie, pensieri, idee di rivolta e di ribellione. Spesso musica e canzoni si sono trasformate in un salvagente a cui aggrapparsi.
La prefazione di Carlo Massarini ci incatena – piacevolmente, ça va sans dire – a un tempo in cui fare radio e più in generale divulgazione musicale era impegnativo, gratificante, oserei dire pedagogico. Quando è cambiato questo modo di informare?
A mio avviso, il modo di informare è cambiato alla fine degli anni Novanta, quando il web è iniziato a crescere; ma la vera rivoluzione mi verrebbe da dire che si è avuta nel 2004, l’anno in cui è stato lanciato Facebook. Da allora si prediligono informazioni spot, non c’è spazio per l’approfondimento che una volta era motivo di distinzione tra un certo tipo di informazione e un altro. Oggi è tutto troppo omologato, la stessa critica musicale non “critica” più. E questo accade anche perché – va detto – per lanciare un album o una tournée invitano “alcuni giornalisti” (non tutti) a Londra o Parigi con volo e hotel gentilmente prenotato e pagato dall’organizzazione o dalla casa discografica, con invito e posto in prima fila, così che a nessuno poi gli scappi una seppur minima critica a quell’album o quel concerto. È vero, il web ha allargato le fonti di informazione, ha ampliato anche il bacino radiofonico – le webradio non hanno confini, si possono ascoltare in tutto il mondo – ma purtroppo si sono anche moltiplicati i giornalisti/critici musicali improvvisati.
Rimpiangi il Parco Lambro, gli Area e i tempi in cui il potere aveva paura dei giovani, tempi in cui effettivamente il potere mostrava il suo volto più austero e cinico. Il rock non ha distrutto quel volto ma credo abbia contribuito a smussarne alcuni elementi, come diceva Keith Richards a proposito della fine dell’URSS. Cosa ne pensi?
È vero, il “potere” in qualche modo ha sempre avuto paura del rock, in quanto cultura “progressista”. Basti ricordare come Woodstock sia riuscito a dimostrare al mondo che una rivoluzione morbida poteva essere praticata, che l’esistenza di una folla non regolamentata da controllori – polizia o forze dell’ordine – non portava naturalmente verso il caos perché comunità libera (sul prato a Bethel erano mezzo milione) si è tranquillamente autoregolamentata. Stessa cosa che è accaduta al Parco Lambro, quando nonostante il Comune non avesse concesso l’allacciamento all’acquedotto e all’energia elettrica, e fossero giunte oltre centomila persone (gli organizzatori se ne aspettavano meno della metà) non è successo nulla di grave, nessuna tragedia, nessun incidente. Poi in Italia tutto collassa: droga, terrorismo, violenza. Anche in Europa quella che poteva essere una rivoluzione “gentile” è fermata con gli stessi mezzi: spranghe, pistole, bombe, droga. Forse perché parole come pace-amore-libertà-uguaglianza hanno fanno paura. Va sottolineato che nella seconda metà degli anni Sessanta c’è stato un susseguirsi di novità, musicali e artistiche, simboli di un’epoca nuova che, senza l’uso della politica, è stata una vera rivoluzione. Una rivoluzione in musica, forte, decisa, che ha portato a cambiamenti radicali, uno fra tutti: i giovani sono stati riconosciuti come categoria sociale.
Cosa ascolta ultimamente Luca Pollini e come ascolta la musica?
Roba poco recente, d’annata, come la “quadrilogia” di Peter Gabriel; qualcosa di James Taylor; lo psichedelico If i could only remember my name, primo lavoro solista di David Crosby. Per quanto riguarda la musica italiana Area, Lucio Battisti versione “prog”, quello di Anima latina; sto riscoprendo uno dei primi album di Antonello Venditti, L’orso bruno. Poi, ovviamente, anche qualcosa di nuovo: Tash Sultana; Snarky Puppy; gli ultimi album di Nada, che trovo abbia dei testi splendidi, profondi; e giovani come Motta.
Come l’ascolto? Ancora col CD, in studio, quando lavoro; sul telefono quando sono in auto o cammino. Raramente – lo so, mi sto contraddicendo – sul vinile.
Spesso si sostiene che sia necessario avvicinare i giovani al rock. Secondo te perché il mondo dei teenager contemporanei trova più seducente la trap o, in altri casi, la caricatura rock in stile Måneskin?
Il rock è una musica popolare, che esprime in una serie di azioni comunicative, politiche e culturali. Con l’andare del tempo è cambiato, si è evoluto in stili, tendenze, sottogeneri sempre legati al mondo giovanile. Oggi ha poco appeal sulle nuove generazioni. Perché oggi non dico che il rock sia morto, ma certo non sta tanto bene. È incapace di reagire “al nuovo”, alle ondate di pop, hip hop, rap che lo travolgono. La domanda che dobbiamo porci è questa: riesce il rock a raccontare quello che siamo, a mettere in scena ansie, conflitti e desideri del nostro tempo? Mentre il pop sforna nuovi idoli senza sosta, il rock fatica ad aggiornarsi, sia nella sostanza che nell’estetica, nutrendosi del ricordo di quello che è stato, incapace di offrire nuovi eroi alle nuove generazioni attratte dal fascino sovversivo, ma che devono volgere la loro passione a ritroso, nella storia passata dei padri e dei nonni. Sono convinto che rimarrà ben poco di quello che oggi viene prodotto in campo musicale. Non è colpa di nessuno: come negli anni Sessanta e Settanta la spinta ideologica e sociale ha enormemente contribuito alla creazione di grandi capolavori, l’odierna mancanza di ideali scaturisce purtroppo l’effetto contrario. Il momento storico predilige infatti l’approccio “usa e getta”, sia dal punto di vista della produzione, sia per quanto riguarda l’utilizzo del lavoro completato.
Ci sono ovviamente buoni gruppi di giovani pieni di talento che usano un linguaggio classico ma che durano lo spazio di 2/3 album perché ancorati ancora al cliché di quattro accordi sparati da chitarre distorte, batteria con cassa e rullante in evidenza, un cantante che strilla. Tipo i Maneskin, appunto.
E ai giovani bisogna raccontare che una volta il rock era la musica più varia e fantasiosa della Terra.