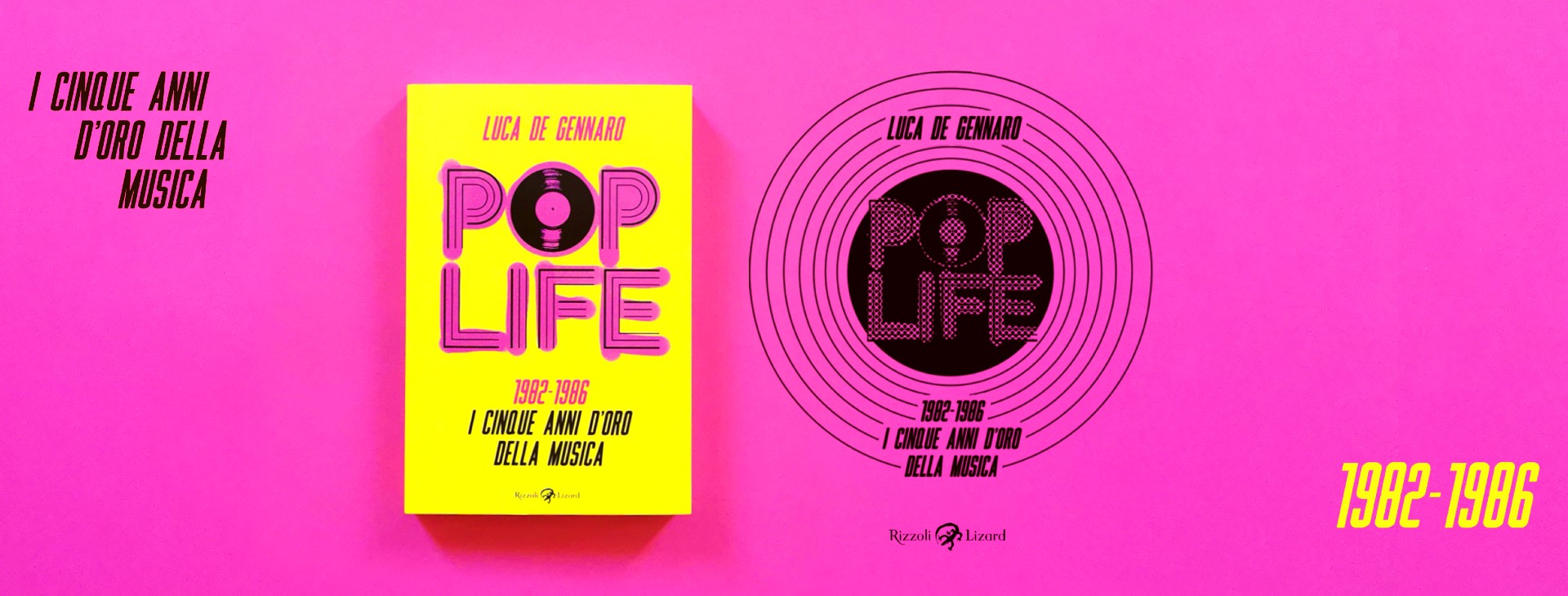Jam è una testata rock. Persino storica, vista la sua longevità. Ma se questo dovesse significare bearsi di uno steccato, di un muro, di un limite di non comunicabilità, allora verrebbe meno la nostra funzione, il nostro servizio all’insegna della condivisione. Non è un caso che qui trovino spazio interviste sulla canzone d’autore, sul jazz e sulla classica contemporanea – magari con la dicitura “modern classical” che suona anglofona e più accattivante. Non è un caso allora che sia giunta questa conversazione con Giacomo Fronzi: critico musicale, pianista, conduttore radiofonico, ricercatore universitario. È proprio con lui, fresco autore per Carocci di Percorsi musicali del Novecento, che proviamo ad addentrarci in uno scambio di opinioni che rifugge dalla classificazione in generi.
È recentemente scomparso Franco Battiato, un musicista la cui vicenda riflette in pieno il superamento dei generi di cui parlavo in apertura. Non se ne parla nel tuo libro, e pour cause, ma non credo sia da escludere in futuro, una volta storicizzato, l’inserimento della sua figura nei percorsi del Novecento storico. Che ne pensi?
In effetti, estendendo ulteriormente lo sguardo, è piuttosto ampio lo spettro di coloro che potrebbero (o dovrebbero) trovare il proprio spazio sotto la lente d’ingrandimento di storici della musica e di filosofi. Battiato – dal quale dovremo necessariamente prima “prendere le distanze”, storicizzandolo, come bene hai detto – resta una figura liminare, che nella sua carriera e nella sua produzione è stata sempre alla ricerca di una dimensione plurima, multiforme, non riconducibile alla sola musica. L’attenzione all’elettronica, al teatro, alla musica classica, alla letteratura, solo per citare qualche mondo “altro”, sarà prima o poi da valutare in modo approfondito rispetto agli esiti artistico-musicali ai quali è pervenuta.
Il tuo libro affronta – peraltro in modo piano ma denso di stratificazioni e rimandi – l’esperienza di Stockhausen, Berio, Xenakis e altri protagonisti del Novecento. Personalità forti e carismatiche, per questo diversissime l’una dall’altra. Ma qual è il filo conduttore che le accomuna?
Forse il filo conduttore che li accomuna è il fatto di aver abitato lo stesso tempo, quello del Novecento musicale. Dopodiché, ciascuno di loro ci ha messo del suo, lasciando una traccia originale e molto profonda nel loro presente e, soprattutto, nella storia del pensiero musicale del secondo Novecento. Una delle maggiori difficoltà che si incontra nell’approcciarsi allo studio dei linguaggi musicali del XX e del XXI secolo risiede proprio nell’estrema diversificazione delle forme espressive, degli stili, degli obiettivi, dei riferimenti culturali e di quelli extramusicali. Tuttavia, in quella che sembra una “Babele” caotica e incomprensibile, mettendoci un po’ di curiosità e di pazienza, si possono scoprire connessioni, storie, personaggi e poetiche dall’incredibile e inaspettato fascino.
Se volessimo utilizzare il punto di vista familiare ai lettori di Jam, quello della popular music, potremmo individuare alcune figure che l’ascoltatore rock ha assorbito grazie alla “mediazione culturale” dei gruppi. Pensiamo a Berio, arrivato alle orecchie di chi è cresciuto coi Grateful Dead grazie a Phil Lesh, che ne fu allievo. Qual è stato il suo contributo in questi percorsi musicali novecenteschi?
Il contributo di Berio è stato di prima grandezza. Non si è trattato soltanto di collocare il nostro Paese, grazie alle ricerche che si svolgevano all’interno del mitico Studio di Fonologia di Milano, all’interno di una cornice internazionale. Pur essendo questo un merito storico che gli va riconosciuto, se possibile la portata dell’attività di Berio va ancora più in là. L’adesione all’idea di musica come “esperienza globale”, in grado di restituire centralità a questo essenziale ambito espressivo, così come il dialogo costante tra pratiche musicali e artistiche diverse, il continuo muoversi nel tempo e nello spazio o l’apertura alla musica cosiddetta “extracolta” rappresentano un punto di non ritorno per la cultura occidentale. Lo strepitoso ciclo “C’è musica e musica” – oltre che l’intera produzione musicale (che va dalla musica strumentale a quella elettroacustica, passando per il teatro musicale) – ci dice molto sull’orizzonte concettuale, speculativo e “ideologico” sul quale Berio si è sempre mosso. La musica, per lui, è qualcosa che interviene nella situazione contemporanea, nella storia e nella società. Questo significa anche intenderla come qualcosa dai contorni mai definiti in via ultimativa, quindi sempre suscettibile di estensione. Una tale progressiva e costante dilatazione risulta da un’attività di ricerca ad ampio spettro, in virtù della quale l’intero mondo musicale (compositori, interpreti, musicisti, ascoltatori, operatori, critici) si apre al mondo esterno a sé, alle sue dinamiche e ai suoi strumenti. Allo stesso modo, tutto ciò che abitualmente consideriamo extra-musicale o non musicale, secondo Berio, può essere considerato musica. Egli è profondamente convinto che «ogni tipo di comportamento umano può diventare “musica”, può essere valutato e riscoperto alla luce di una drammaturgia musicale». Credo che anche queste poche annotazioni possano già dare l’idea della grandezza e dell’influenza di questa figura.
Altri nomi ineludibili in tal senso sono Stockhausen (vedi il suo ruolo nella poetica di Kraftwerk, Tangerine Dream e “corrieri cosmici” tedeschi), John Cage (Area su tutti) e Charles Ives (via Frank Zappa).
I riferimenti che stai facendo ci danno l’opportunità di provare a vincere uno dei tanti pregiudizi che avvolgono la musica contemporanea e la sua ricezione: una sorta di (in)felice isolamento. Non possiamo certo escludere che alcuni compositori o alcune compositrici abbiano volontariamente preso le distanze dal mondo, chiudendosi in una turris eburnea dalla quale e nella quale elaborare il proprio pensiero musicale, dandogli forma. Tuttavia, va sottolineato il proficuo e costante dialogo tra le due grandi tradizioni della musica “colta” e di quella “extracolta” (utilizzo queste etichette solo per intenderci…). Già l’elemento “elettroacustico” aveva rappresentato un terreno di parziale coabitazione per i protagonisti di questi due mondi, ma certe esperienze sperimentali – come quelle che hai menzionato – hanno fatto breccia, direi trasversalmente, in settori musicali anche molto diversi. In più, alla forte carica attrattiva che alcuni compositori hanno esercitato su artisti e musicisti provenienti da altre esperienze si aggiunge l’incredibile fusione tra linguaggi (musicali) diversi che ha caratterizzato la ricerca musicale degli ultimi cinquant’anni. Le barriere sono davvero crollate, offrendo possibilità di interscambio, di mutua influenza e di proficua ingerenza che hanno reso il panorama ancora più interessante.
A proposito di Zappa, nel lungo tragitto del libro è l’unico nome di area “popular” da te citato: tale categoria però gli andava piuttosto stretta, vero?
Mi trovi d’accordo su entrambe le affermazioni: è l’unico nome di area “popular”, sebbene si tratti di un’etichetta piuttosto riduttiva per un personaggio come Frank Zappa. Proprio questo lo ha reso per me interessante all’interno di un itinerario che, perlustrando diversi territori, intende offrire un quadro, per quanto introduttivo, di alcune delle figure più influenti del Novecento musicale. Rispetto alla pluralità degli interessi di Zappa e al suo geniale eclettismo – che gli ha consentito di scompaginare il linguaggio rock e, allo stesso tempo, di introdurre nella scrittura di musica per orchestra elementi davvero interessanti – le parole di Pierre Boulez sono estremamente significative: «si è distinto nel rock perché ha rifiutato di lasciarsi incasellare dal rock e ha evitato la logica commerciale. Provocatorio, politico a modo suo, odiava il mercato, con cui la musica rock si era compromessa. Mi ha fatto piacere lavorare con lui sul materiale musicale, sulla forma, sulla mobilità del linguaggio. Non vedo nessun erede».
Ancora vivente e operante ma “già nella storia”, Steve Reich viene menzionato tra i prìncipi della minimal music eppure, come tu sottolinei, ciò ne limita la portata e il valore rivoluzionari.
È proprio così. In quello che, in modo ormai inflazionato, viene chiamato “immaginario collettivo”, Steve Reich viene considerato una delle figure di riferimento della “minimal music”. Non si tratta tanto di smentire questo giudizio, quanto di sottolinearne l’estrema parzialità. È innegabile che Reich, fin dal suo celebre It’s gonna rain (1965), si sia collocato nel solco del minimalismo americano, contribuendo a definirne i caratteri e gli obiettivi: essenzialità delle strutture, sviluppo di nuove dimensioni temporali, sollecitazione di inedite modalità percettive, ripetitività, gradualità, solo per ricordare gli aspetti principali. Ma questo è stato solo l’inizio. Reich, nei decenni successivi, ha battuto altre vie, “annusando” – come avrebbe detto Stravinskij –, esplorando, scoprendo. A questo proposito, la valutazione espressa da Enzo Restagno a metà degli anni Novanta risulta ancora decisamente attuale: «L’opera di Steve Reich ha mostrato […] di sapersi continuamente rimettere in discussione facendo propri nuovi spazi culturali e spirituali, e dell’antica radice minimalista ha conservato soltanto il fondamentale presupposto della chiarezza e della trasparenza del pensiero che dialoga con se stesso lungo il cammino della creazione».
E dunque, per tornare al nostro discorso iniziale, l’etichetta di “compositore minimalista” appare effettivamente troppo riduttiva, se non fuorviante, sebbene da quelle radici egli provenga. Il “minimalismo” non gli è certo estraneo, ma solo se inteso come chiarezza di pensiero, ordine strutturale e tensione comunicativa. Reich ha scritto il suo nome nella storia della musica del XX e XXI secolo, riuscendo nella difficile impresa, per un compositore contemporaneo, di essere riconosciuto come tale e, allo stesso tempo, di riscuotere successo al di fuori dei troppo spesso stretti e angusti confini della musica classica. Ne sono testimonianza i tanti premi e riconoscimenti finora ricevuti, come i due “Grammy Award” (uno con Different Trains nel 1990 e l’altro con Music for Eighteen Musicians nel 1999), il “William Schuman Award” della Columbia University nel 2000, il “Praemium Imperiale in Music” di Tokyo, il “Polar Music Prize” dell’Accademia reale di Svezia nel 2006 e il “Pulitzer Prize – Music” per il Doppio sestetto nel 2009.
Arvo Pärt: lo spirituale nel contemporaneo. Una posizione complessa e affascinante la sua, in un’epoca di secolarizzazione estrema e materialismo. A quale aspetto del sacro ha dato voce?
Secondo Gianni Vattimo, la secolarizzazione coincide con una sorta di purificazione e di chiarificazione della fede. È un modo, questo, per guardare al processo di secolarizzazione da una prospettiva diversa: non il superamento della fede, ma una sua chiarificazione, per l’appunto. Qualcosa di simile è accaduto anche nella musica. Il processo di secolarizzazione della (e nella) musica ha forse reso quella sacra più chiara, più pura. Nel contesto della musica del XX e XXI secolo, compositori come Pärt o come Sofia Gubaidulina testimoniano due importanti verità: 1) anche nella musica contemporanea c’è posto per il sacro; 2) nonostante la cavalcante e debordante razionalizzazione del mondo e della vita, la tendenza verso il sacro è inestirpabile.
Per quanto riguarda Pärt, in effetti nella sua produzione la presenza del sacro – rivissuta in chiave contemporanea e combinata con una straordinaria personalizzazione di una tradizione che affonda le sue radici nella musica antica occidentale – assume connotati originalissimi, quasi fuori dal tempo. Ed è proprio in questa sorta di astrazione sovratemporale, in quella che Joseph Auner e altri musicologi – suscitando l’irritazione del compositore in questione – hanno definito «minimalismo sacro», che l’arte di Pärt trova le ragioni della sua eccezionalità e della sua popolarità.
Dopo la “crisi” creativa che lo colpisce tra gli anni Sessanta e Settanta e che lo conduce verso una transizione dai forti connotati filosofici, finanche psicologici, oltre che musicali, Arvo Pärt inizia a diventare Arvo Pärt: un compositore che penetra la musica in tutta la sua profondità, nella sua complessità semantica, nelle sue articolazioni storiche, nei suoi contenuti spirituali. Ed è anche in questa fase e in questo contesto che nasce lo stile tintinnabuli che potremmo considerare il “marchio di fabbrica” della sua musica.
Fratres (1977), Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Joannem (1982), Stabat Mater (1985), il Te Deum (1985), il Miserere (1989-92), la Berliner Messe (1990-2002), Lamentate (2002): in questi e in molti altri lavori emerge in tutta la sua centralità la funzione che svolge la dimensione del “sacro” nella produzione e nella vita del compositore estone. Per poterla cogliere, sarebbe sufficiente – oltre che ascoltare la sua musica – leggere cosa ha scritto Pärt in merito ai testi sacri. In essi troviamo quegli aspetti dell’uomo e dell’umano che sono in fondo rimasti inalterati nel tempo e che attengono proprio alla sua dimensione essenziale, pertanto sostanzialmente immodificabile. I testi sacri, oltre al fatto di essere poetici, «sono legati a verità universali, […] all’intima verità, alla purezza, al bello, a quel nucleo ideale al quale ogni essere umano è legato! Questo nucleo possiede una potenza e un calore straordinari, è come un sistema solare dove ogni cosa è correlata con tutto il resto». Anche in questo caso, le parole di Pärt, oltre che la sua musica, rendono chiarissimo l’orizzonte entro il quale si muove, un orizzonte trasparente e irraggiungibile.
Chiudiamo con un giochino odioso ma inevitabile dinanzi a libri come il tuo. Pensiamo a chi non viene menzionato, ad esempio Morricone. Poco degno di incamminarsi nei percorsi musicali del Novecento?
Vuoi evidentemente mettermi in difficoltà! Al di là delle battute, Ennio Morricone è parte viva della cultura musicale contemporanea. È stato un compositore che, pur essendosi mosso prevalentemente nell’ambito della musica per il cinema, ha effettivamente elaborato un linguaggio e uno stile personalissimi. Quando si ascolta una colonna sonora del Maestro romano, si riconosce subito la sua mano: “Ecco, questo è Morricone!”. Già il fatto di aver creato uno stile riconoscibile rende la sua musica molto più che degna di essere analizzata, studiata, indagata. Quel che abbiamo detto di Battiato, vale anche per Morricone: forse serve solo ancora un po’ di tempo.
È recentemente scomparso Franco Battiato, un musicista la cui vicenda riflette in pieno il superamento dei generi di cui parlavo in apertura. Non se ne parla nel tuo libro, e pour cause, ma non credo sia da escludere in futuro, una volta storicizzato, l’inserimento della sua figura nei percorsi del Novecento storico. Che ne pensi?
In effetti, estendendo ulteriormente lo sguardo, è piuttosto ampio lo spettro di coloro che potrebbero (o dovrebbero) trovare il proprio spazio sotto la lente d’ingrandimento di storici della musica e di filosofi. Battiato – dal quale dovremo necessariamente prima “prendere le distanze”, storicizzandolo, come bene hai detto – resta una figura liminare, che nella sua carriera e nella sua produzione è stata sempre alla ricerca di una dimensione plurima, multiforme, non riconducibile alla sola musica. L’attenzione all’elettronica, al teatro, alla musica classica, alla letteratura, solo per citare qualche mondo “altro”, sarà prima o poi da valutare in modo approfondito rispetto agli esiti artistico-musicali ai quali è pervenuta.
Il tuo libro affronta – peraltro in modo piano ma denso di stratificazioni e rimandi – l’esperienza di Stockhausen, Berio, Xenakis e altri protagonisti del Novecento. Personalità forti e carismatiche, per questo diversissime l’una dall’altra. Ma qual è il filo conduttore che le accomuna?
Forse il filo conduttore che li accomuna è il fatto di aver abitato lo stesso tempo, quello del Novecento musicale. Dopodiché, ciascuno di loro ci ha messo del suo, lasciando una traccia originale e molto profonda nel loro presente e, soprattutto, nella storia del pensiero musicale del secondo Novecento. Una delle maggiori difficoltà che si incontra nell’approcciarsi allo studio dei linguaggi musicali del XX e del XXI secolo risiede proprio nell’estrema diversificazione delle forme espressive, degli stili, degli obiettivi, dei riferimenti culturali e di quelli extramusicali. Tuttavia, in quella che sembra una “Babele” caotica e incomprensibile, mettendoci un po’ di curiosità e di pazienza, si possono scoprire connessioni, storie, personaggi e poetiche dall’incredibile e inaspettato fascino.
Se volessimo utilizzare il punto di vista familiare ai lettori di Jam, quello della popular music, potremmo individuare alcune figure che l’ascoltatore rock ha assorbito grazie alla “mediazione culturale” dei gruppi. Pensiamo a Berio, arrivato alle orecchie di chi è cresciuto coi Grateful Dead grazie a Phil Lesh, che ne fu allievo. Qual è stato il suo contributo in questi percorsi musicali novecenteschi?
Il contributo di Berio è stato di prima grandezza. Non si è trattato soltanto di collocare il nostro Paese, grazie alle ricerche che si svolgevano all’interno del mitico Studio di Fonologia di Milano, all’interno di una cornice internazionale. Pur essendo questo un merito storico che gli va riconosciuto, se possibile la portata dell’attività di Berio va ancora più in là. L’adesione all’idea di musica come “esperienza globale”, in grado di restituire centralità a questo essenziale ambito espressivo, così come il dialogo costante tra pratiche musicali e artistiche diverse, il continuo muoversi nel tempo e nello spazio o l’apertura alla musica cosiddetta “extracolta” rappresentano un punto di non ritorno per la cultura occidentale. Lo strepitoso ciclo “C’è musica e musica” – oltre che l’intera produzione musicale (che va dalla musica strumentale a quella elettroacustica, passando per il teatro musicale) – ci dice molto sull’orizzonte concettuale, speculativo e “ideologico” sul quale Berio si è sempre mosso. La musica, per lui, è qualcosa che interviene nella situazione contemporanea, nella storia e nella società. Questo significa anche intenderla come qualcosa dai contorni mai definiti in via ultimativa, quindi sempre suscettibile di estensione. Una tale progressiva e costante dilatazione risulta da un’attività di ricerca ad ampio spettro, in virtù della quale l’intero mondo musicale (compositori, interpreti, musicisti, ascoltatori, operatori, critici) si apre al mondo esterno a sé, alle sue dinamiche e ai suoi strumenti. Allo stesso modo, tutto ciò che abitualmente consideriamo extra-musicale o non musicale, secondo Berio, può essere considerato musica. Egli è profondamente convinto che «ogni tipo di comportamento umano può diventare “musica”, può essere valutato e riscoperto alla luce di una drammaturgia musicale». Credo che anche queste poche annotazioni possano già dare l’idea della grandezza e dell’influenza di questa figura.
Altri nomi ineludibili in tal senso sono Stockhausen (vedi il suo ruolo nella poetica di Kraftwerk, Tangerine Dream e “corrieri cosmici” tedeschi), John Cage (Area su tutti) e Charles Ives (via Frank Zappa).
I riferimenti che stai facendo ci danno l’opportunità di provare a vincere uno dei tanti pregiudizi che avvolgono la musica contemporanea e la sua ricezione: una sorta di (in)felice isolamento. Non possiamo certo escludere che alcuni compositori o alcune compositrici abbiano volontariamente preso le distanze dal mondo, chiudendosi in una turris eburnea dalla quale e nella quale elaborare il proprio pensiero musicale, dandogli forma. Tuttavia, va sottolineato il proficuo e costante dialogo tra le due grandi tradizioni della musica “colta” e di quella “extracolta” (utilizzo queste etichette solo per intenderci…). Già l’elemento “elettroacustico” aveva rappresentato un terreno di parziale coabitazione per i protagonisti di questi due mondi, ma certe esperienze sperimentali – come quelle che hai menzionato – hanno fatto breccia, direi trasversalmente, in settori musicali anche molto diversi. In più, alla forte carica attrattiva che alcuni compositori hanno esercitato su artisti e musicisti provenienti da altre esperienze si aggiunge l’incredibile fusione tra linguaggi (musicali) diversi che ha caratterizzato la ricerca musicale degli ultimi cinquant’anni. Le barriere sono davvero crollate, offrendo possibilità di interscambio, di mutua influenza e di proficua ingerenza che hanno reso il panorama ancora più interessante.
A proposito di Zappa, nel lungo tragitto del libro è l’unico nome di area “popular” da te citato: tale categoria però gli andava piuttosto stretta, vero?
Mi trovi d’accordo su entrambe le affermazioni: è l’unico nome di area “popular”, sebbene si tratti di un’etichetta piuttosto riduttiva per un personaggio come Frank Zappa. Proprio questo lo ha reso per me interessante all’interno di un itinerario che, perlustrando diversi territori, intende offrire un quadro, per quanto introduttivo, di alcune delle figure più influenti del Novecento musicale. Rispetto alla pluralità degli interessi di Zappa e al suo geniale eclettismo – che gli ha consentito di scompaginare il linguaggio rock e, allo stesso tempo, di introdurre nella scrittura di musica per orchestra elementi davvero interessanti – le parole di Pierre Boulez sono estremamente significative: «si è distinto nel rock perché ha rifiutato di lasciarsi incasellare dal rock e ha evitato la logica commerciale. Provocatorio, politico a modo suo, odiava il mercato, con cui la musica rock si era compromessa. Mi ha fatto piacere lavorare con lui sul materiale musicale, sulla forma, sulla mobilità del linguaggio. Non vedo nessun erede».
Ancora vivente e operante ma “già nella storia”, Steve Reich viene menzionato tra i prìncipi della minimal music eppure, come tu sottolinei, ciò ne limita la portata e il valore rivoluzionari.
È proprio così. In quello che, in modo ormai inflazionato, viene chiamato “immaginario collettivo”, Steve Reich viene considerato una delle figure di riferimento della “minimal music”. Non si tratta tanto di smentire questo giudizio, quanto di sottolinearne l’estrema parzialità. È innegabile che Reich, fin dal suo celebre It’s gonna rain (1965), si sia collocato nel solco del minimalismo americano, contribuendo a definirne i caratteri e gli obiettivi: essenzialità delle strutture, sviluppo di nuove dimensioni temporali, sollecitazione di inedite modalità percettive, ripetitività, gradualità, solo per ricordare gli aspetti principali. Ma questo è stato solo l’inizio. Reich, nei decenni successivi, ha battuto altre vie, “annusando” – come avrebbe detto Stravinskij –, esplorando, scoprendo. A questo proposito, la valutazione espressa da Enzo Restagno a metà degli anni Novanta risulta ancora decisamente attuale: «L’opera di Steve Reich ha mostrato […] di sapersi continuamente rimettere in discussione facendo propri nuovi spazi culturali e spirituali, e dell’antica radice minimalista ha conservato soltanto il fondamentale presupposto della chiarezza e della trasparenza del pensiero che dialoga con se stesso lungo il cammino della creazione».
E dunque, per tornare al nostro discorso iniziale, l’etichetta di “compositore minimalista” appare effettivamente troppo riduttiva, se non fuorviante, sebbene da quelle radici egli provenga. Il “minimalismo” non gli è certo estraneo, ma solo se inteso come chiarezza di pensiero, ordine strutturale e tensione comunicativa. Reich ha scritto il suo nome nella storia della musica del XX e XXI secolo, riuscendo nella difficile impresa, per un compositore contemporaneo, di essere riconosciuto come tale e, allo stesso tempo, di riscuotere successo al di fuori dei troppo spesso stretti e angusti confini della musica classica. Ne sono testimonianza i tanti premi e riconoscimenti finora ricevuti, come i due “Grammy Award” (uno con Different Trains nel 1990 e l’altro con Music for Eighteen Musicians nel 1999), il “William Schuman Award” della Columbia University nel 2000, il “Praemium Imperiale in Music” di Tokyo, il “Polar Music Prize” dell’Accademia reale di Svezia nel 2006 e il “Pulitzer Prize – Music” per il Doppio sestetto nel 2009.
Arvo Pärt: lo spirituale nel contemporaneo. Una posizione complessa e affascinante la sua, in un’epoca di secolarizzazione estrema e materialismo. A quale aspetto del sacro ha dato voce?
Secondo Gianni Vattimo, la secolarizzazione coincide con una sorta di purificazione e di chiarificazione della fede. È un modo, questo, per guardare al processo di secolarizzazione da una prospettiva diversa: non il superamento della fede, ma una sua chiarificazione, per l’appunto. Qualcosa di simile è accaduto anche nella musica. Il processo di secolarizzazione della (e nella) musica ha forse reso quella sacra più chiara, più pura. Nel contesto della musica del XX e XXI secolo, compositori come Pärt o come Sofia Gubaidulina testimoniano due importanti verità: 1) anche nella musica contemporanea c’è posto per il sacro; 2) nonostante la cavalcante e debordante razionalizzazione del mondo e della vita, la tendenza verso il sacro è inestirpabile.
Per quanto riguarda Pärt, in effetti nella sua produzione la presenza del sacro – rivissuta in chiave contemporanea e combinata con una straordinaria personalizzazione di una tradizione che affonda le sue radici nella musica antica occidentale – assume connotati originalissimi, quasi fuori dal tempo. Ed è proprio in questa sorta di astrazione sovratemporale, in quella che Joseph Auner e altri musicologi – suscitando l’irritazione del compositore in questione – hanno definito «minimalismo sacro», che l’arte di Pärt trova le ragioni della sua eccezionalità e della sua popolarità.
Dopo la “crisi” creativa che lo colpisce tra gli anni Sessanta e Settanta e che lo conduce verso una transizione dai forti connotati filosofici, finanche psicologici, oltre che musicali, Arvo Pärt inizia a diventare Arvo Pärt: un compositore che penetra la musica in tutta la sua profondità, nella sua complessità semantica, nelle sue articolazioni storiche, nei suoi contenuti spirituali. Ed è anche in questa fase e in questo contesto che nasce lo stile tintinnabuli che potremmo considerare il “marchio di fabbrica” della sua musica.
Fratres (1977), Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Joannem (1982), Stabat Mater (1985), il Te Deum (1985), il Miserere (1989-92), la Berliner Messe (1990-2002), Lamentate (2002): in questi e in molti altri lavori emerge in tutta la sua centralità la funzione che svolge la dimensione del “sacro” nella produzione e nella vita del compositore estone. Per poterla cogliere, sarebbe sufficiente – oltre che ascoltare la sua musica – leggere cosa ha scritto Pärt in merito ai testi sacri. In essi troviamo quegli aspetti dell’uomo e dell’umano che sono in fondo rimasti inalterati nel tempo e che attengono proprio alla sua dimensione essenziale, pertanto sostanzialmente immodificabile. I testi sacri, oltre al fatto di essere poetici, «sono legati a verità universali, […] all’intima verità, alla purezza, al bello, a quel nucleo ideale al quale ogni essere umano è legato! Questo nucleo possiede una potenza e un calore straordinari, è come un sistema solare dove ogni cosa è correlata con tutto il resto». Anche in questo caso, le parole di Pärt, oltre che la sua musica, rendono chiarissimo l’orizzonte entro il quale si muove, un orizzonte trasparente e irraggiungibile.
Chiudiamo con un giochino odioso ma inevitabile dinanzi a libri come il tuo. Pensiamo a chi non viene menzionato, ad esempio Morricone. Poco degno di incamminarsi nei percorsi musicali del Novecento?
Vuoi evidentemente mettermi in difficoltà! Al di là delle battute, Ennio Morricone è parte viva della cultura musicale contemporanea. È stato un compositore che, pur essendosi mosso prevalentemente nell’ambito della musica per il cinema, ha effettivamente elaborato un linguaggio e uno stile personalissimi. Quando si ascolta una colonna sonora del Maestro romano, si riconosce subito la sua mano: “Ecco, questo è Morricone!”. Già il fatto di aver creato uno stile riconoscibile rende la sua musica molto più che degna di essere analizzata, studiata, indagata. Quel che abbiamo detto di Battiato, vale anche per Morricone: forse serve solo ancora un po’ di tempo.