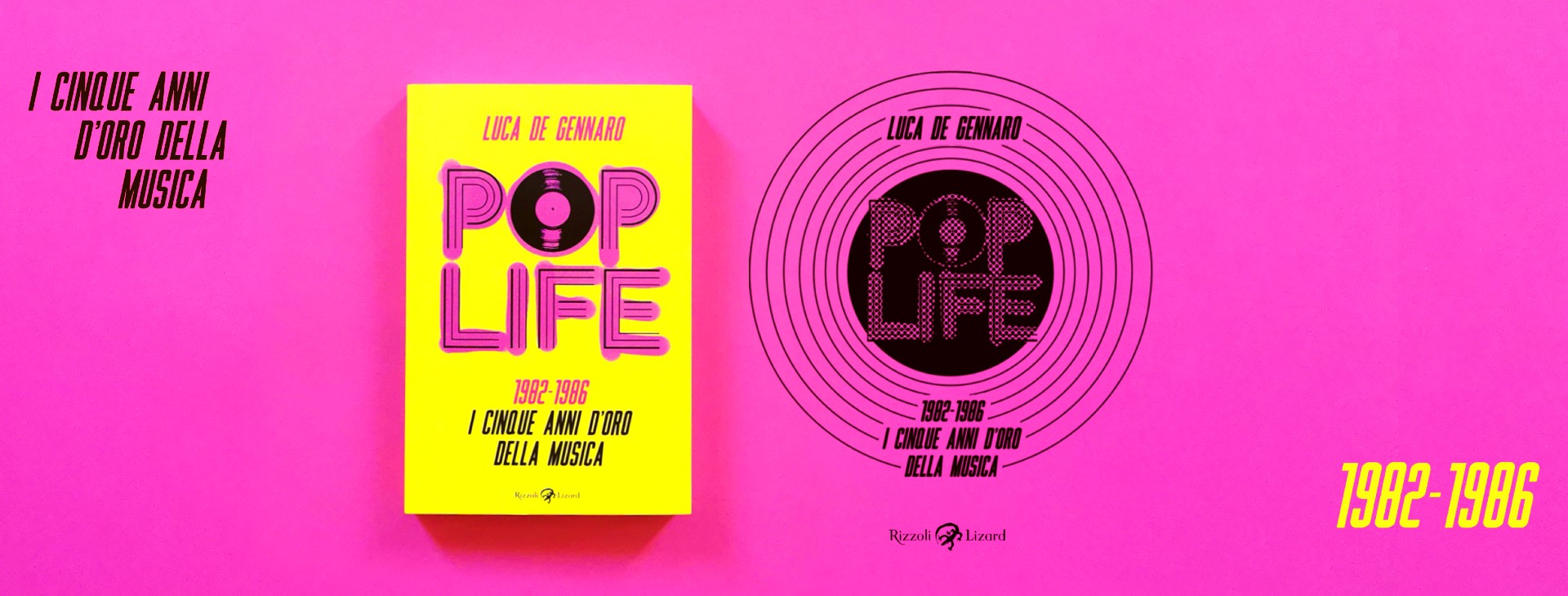Lo conosciamo come Unfolk, autore di una discografia indipendente dal respiro internazionale, con collaborazioni prestigiose, da Tim Bowness alla Burning Shed. Alessandro Monti tuttavia è anche una curiosa eminenza grigia, un uomo di musica a tutto tondo che ha raccolto i suoi pensieri e le sue meditazioni offrendo al lettore dei percorsi d’ascolto. Dal rock alla musica contemporanea, Riproduzione casuale. Sistemi d’ascolto non lineari (Arcana) è un testo accessibile che getta nuova luce su classici del passato e lavori meno noti.
Dalla musica alla scrittura. Da Unfolk a Riproduzione casuale. Come mai sei passato dagli strumenti alla penna?
Avrei voluto davvero scrivere a penna, ma poi per ovvi motivi ho scelto il computer, anche a causa della mia pessima calligrafia!
Scherzi a parte, tutto è nato da una lunga malattia: ho avuto molto tempo a disposizione e durante la convalescenza si è aggiunta pure la pandemia! Ho cercato di trovare la giusta terapia in un momento di rinascita psicofisica e ha funzionato in tutti i sensi: al mattino ascoltavo e scrivevo, mentre al pomeriggio registravo alcuni esperimenti di musica virtuale che non avrei mai pensato di pubblicare, e invece sono usciti sia il libro Riproduzione Casuale che il disco monti (MP & Records). Credo che dal libro si deduca un grande entusiasmo per la musica che mi ha accompagnato per tutta la vita, ma anche l’amara consapevolezza del periodo attuale.
Il percorso d’ascolto che vuoi offrire al lettore parte da lontano, dai primi ascolti di gioventù, successivamente sedimentati, storicizzati, infine rivisti in chiave critica. Vorrei soffermarmi con te su alcune figure capitali: la prima è quella di Brian Jones, che definisci “padre dei polistrumentisti rock”.
Sì, hai colto perfettamente il sistema con cui ho operato. Nell’introduzione scrivo che, oltre alle musiche che si ascoltavano in famiglia, la prima emozione musicale forte che ricordo era stata l’ascolto di Let’s Spend The Night Together dei Rolling Stones in qualche programma radio dell’epoca. Da lì è iniziato tutto per me, e negli anni ho cercato di approfondire il contributo immenso alla musica di Brian Jones; il problema più grande è che all’epoca nessuno scriveva sulle copertine dei dischi gli strumenti usati. Brian è stato il primo a spaziare in tutte le possibili direzioni: corde, tastiere, fiati e percussioni; se George Harrison aveva avuto l’illuminazione di suonare il sitar in un contesto pop, lui aveva sviluppato ulteriormente il concetto diventando a tutti gli effetti il primo polistrumentista, scelta che avrebbe caratterizzato in modo totale la musica seguente, grazie anche alla tecnologia maneggevole dei registratori multipista che permetteva ai musicisti di sovraincidere a casa le proprie idee e costruire in solitudine vere e proprie opere d’arte come Tubular Bells. Brian aveva la caratteristica di imparare ogni strumento in modo ultraveloce, cosa che all’epoca non era affatto scontata.
Nel libro ho cercato di delineare i suoi contributi come un gioco in cui ognuno deve capire dove inserire quei suoni! Poi l’intuizione finale dell’album registrato in Marocco, pubblicato solo dopo la sua morte, ha aperto un vero e proprio mondo musicale sconosciuto, la world music appunto.
Certamente George e Brian sono stati i veri e propri geni di quegli anni, assieme a Syd Barrett hanno creato tutto, almeno qui in Europa. Per gli States è una situazione che parte da presupposti diversi e infatti quello che è successo ad esempio con i Velvet Underground, Mothers Of Invention, United States Of America è l’altra faccia della medaglia: nel libro analizzo in modo dettagliato anche quell’area.
Faccenda Beatles. Delicata, da affrontare per bene, nonostante l’amore universale che da sempre li lega a tutti noi. A proposito di chiave critica, qual è la tua rilettura del fenomeno beatlesiano?
C’è molta ironia e provocazione nel mio libro… ma quando dico che i Fab Four erano in realtà i Fab Five dico sul serio! Non è stato dato mai abbastanza credito al genio di George Martin, senza di lui non avremmo sentito molti dei capolavori del gruppo. Nel libro analizzo soprattutto la strana serie degli album solisti dopo lo scioglimento, non solo perchè è quella che ho vissuto in diretta ma anche perchè la reputo un’ottima chiave per interpretare i singoli talenti di John, Paul, George, Ringo e… l’altro George! Sono anche fermamente convinto che Sgt Pepper non sia affatto il miglior disco del 1967, e cerco di argomentare le mie idee citando almeno altri 4-5 capolavori che lo superano. Ciò non toglie nulla al grande artigianato dei Beatles che sono stati innovatori in molti campi.
Ascoltando la tua musica, per quanto sfaccettata e eterogenea, viene da pensare che il grande riferimento derivi dal progressive. Non è un caso che ci sia un bel ritratto di tanti “naviganti delle stelle”, da Peter Hammill a Peter Gabriel. Qual è stato il ruolo di queste personalità?
Quel capitolo prende spunto da un album che mi aveva profondamente colpito quand’ero adolescente, Starsailor di Tim Buckley: è stato un pretesto per parlare di alcuni cantanti che hanno ampliato il linguaggio sia vocale che strumentale portandolo ad un livello espressivo superiore.
Il progressive per me oggi rappresenta un vero problema. Essendo cresciuto negli anni ‘70, ho abbracciato con entusiasmo le musiche di Pink Floyd, Genesis, Van Der Graaf, King Crimson, ma quello che oggi si intende per progressive è solo pura nostalgia e mi scontro regolarmente con le idee retrograde e conservatrici degli amanti di quel periodo. Ho scritto un brano per Tim Bowness (che ha gentilmente distribuito i dischi del progetto Unfolk in UK) perchè mi piace molto il suo stile vocale, ma eccetto i dischi dei No-Man non ascolto praticamente nulla di quell’area. Il postrock anni ‘90 è per me la musica che ha maggiormente contribuito a vedere la musica da una nuova ottica progressiva: Talk Talk, Rachel’s, Tortoise, Labradford, perfino un gruppo di sabotatori come i Public Image Ltd (anatema!) inserendo dub, noise e krautrock durante il percorso.
Ascoltando la musica del Collettivo Unfolk o dei miei lavori solisti, credo si evinca che il prog sia solo una delle influenze. Certamente l’idea del concept album in The Venetian Book Of The Dead (dedicato alle vittime del Petrolkimiko della mia città) è di derivazione 70s, ma il suo svolgimento non lo è affatto. La mia collaborazione con un gruppo dichiaratamente prog come Quanah Parker (Suite degli Animali Fantastici) è stata un episodio interessante in cui sono stato motivato a scrivere per una voce splendida come Elisabetta Montino, che non a caso è stata scelta da Tony Pagliuca per il suo nuovo lavoro Rosa Mystica. Lo scrittore Massimo Salari ha recentemente inserito i nostri dischi in ben due libri di quell’area, ma le sue vedute aperte sembrano una rarità nel mondo del progressive…
Per me comunque tutto resta “pop music”: la semplice idea di musica popolare calza ancora a pennello contrapposta alla musica colta. In effetti l’unico capitolo in cui nel mio libro parlo di un gruppo prog è quello dedicato a Henry Cow: mi sono sempre domandato se quella fosse l’unica band realmente progressista sia dal punto di vista musicale che politico; forse la risposta sta nel fatto che era uno dei pochissimi ensemble che traessero ispirazione della musica del XX secolo, quella del ‘900, mentre la maggior parte dei gruppi all’epoca si ispiravano agli autori dei secoli precedenti, la cosiddetta musica classica tradizionale.
Devo ammettere che di quell’epoca oggi amo l’aspetto più estremo: l’hard rock di band come Black Sabbath, Edgar Broughton Band, Groundhogs, i suoni ruvidi che trovo ancora tra i più freschi e influenti e che hanno anticipato l’energia del punk, del metal fino al grunge. E poi parliamoci chiaro: nessuno può nemmeno avvicinarsi a Frank Zappa! La sua musica più che progressiva sembra pura fantascienza… oggi più che mai!
A differenza di tanti tuoi coetanei rimasti legati a suoni e poetica anni ‘60/’70, tu non hai disdegnato la vulgata punk e postpunk, sia nella versione più intellettuale, sia in quella più fisica. Quanto è stata formativa la pars destruens esplosa nel 1977?
Ricordo quell’epoca con molto affetto e ottime vibrazioni: è stato un momento di rottura salutare che ha portato un grande cambiamento in tutti i settori: alcuni musicisti provenienti dal decennio precedente hanno adottato nuovi metodi e nuovi stilemi nei loro progetti, e la successiva new wave si è sviluppata con aspetti diversi sia nel pop che nella musica di ricerca. Nel libro parlo in dettaglio dell’importante contributo femminile nel post punk che è riuscito a creare stimoli nuovi negli anni ‘80, infatti a parte qualche caso isolato (Renaissance, Curved Air, Henry Cow o la ricca scena folk), era stato praticamente assente nel prog. Io sono un tipo curioso di natura e non potevo non essere attratto da quel momento di grande fermento.
I tuoi percorsi d’ascolto non ignorano l’universo jazz e black. Da Carla Bley a Keith Jarrett, da Miles all’hip hop, quanto ti hanno insegnato questi protagonisti, come musicista e più in generale come uomo di pensiero musicale?
Ho voluto dedicare un ampio spazio al jazz e alla musica afrocentrica perchè la ritengo la base di (quasi) tutto quello che abbiamo digerito negli anni. Nulla mi entusiasma di più di una semplice chitarra e una voce: in questo il blues autentico è un’esperienza senza paragoni (vedi la sezione che riguarda Ali Farka Toure), ma consiglio anche il mio reportage da New Orleans sul vero significato del Voodoo! Nel caso di Keith Jarrett invece ho voluto segnalare la sua maestria come polistrumentista, un approccio decisamente diverso da quello di Brian Jones, ma altrettanto straordinario: molti lo considerano solo un pianista ma alcuni dei suoi album più riusciti lo vedono all’opera con altri strumenti.
Più vecchio divento più amo i diversi aspetti della black music: una vera miniera di ispirazione. Suonando uno strumento come il basso, sin da ragazzo avevo colto qualcosa di speciale nel groove del soul e del funk, ma da adolescente ero troppo preso dal rock per apprezzare davvero quell’area. Anche l’ascolto parallelo del jazz mi aveva comunicato qualcosa di speciale: erano mondi che non sentivo contrastanti ma si completavano a vicenda e un genio musicale come Miles Davis era stato l’uomo giusto al momento giusto! Per me resta un esempio di come la musica debba essere interpretata, senza confini e con la giusta dose di provocazione.
L’hip hop è trattato a fondo soprattutto per far capire quanto quell’arte popolare “povera” avesse preso ispirazione dalle radici vere della musica africana: esempi storici come i Last Poets, il primo Gil Scott-Heron o l’immenso Billy Preston (cui dedico un intero capitolo) sono essenziali per capirne l’evoluzione. Grandi protagonisti successivi come Afrika Bambaataa hanno effettuato una vera e propria rivoluzione, inserendo ad esempio i suoni tecnologici dei Kraftwerk nella black music. Ma nulla può essere isolato dal fermento culturale di quegli anni, poi una forza superiore ha improvvisamente fermato tutto e ne ricerco le ragioni. Sono passati pochi anni da quegli ultimi momenti creativi ma se mi volto indietro oggi sembra siano passati secoli.
Stockhausen, Morricone, Brian Eno, Mertens. Alcuni volti della musica colta contemporanea, in qualche caso anche ai confini con la cultura popular. È ancora presto per un parere ponderato o la veloce storicizzazione novecentesca offre strumenti di valutazione rapida?
La musica offre sempre spunti diversi per valutarne l’importanza e il significato: nel libro analizzo alcuni dei miei musicisti colti favoriti ma come giustamente hai fatto notare alcuni sono decisamente in bilico tra cultura popular e serietà. Alcuni di questi escono con le ossa rotte dalle mie pagine: Brian Eno, Wim Mertens, altri emergono dal nulla come Arthur Russell o Tod Dockstader. Va però sottolineato che anche quando parlo in modo critico di alcuni mostri sacri, lo faccio perchè li ritengo comunque personaggi di rilievo.
A parte un gigante come Morricone (di cui analizzo una colonna sonora tra le più oscure), la musica italiana è una sorta di presenza nascosta che affiora qua e là: il Lucio Battisti di Anima Latina, Franco Falsini di Cold Nose o l’indimenticabile Demetrio Stratos di Metrodora. La parte più ampia riguarda però la library music in cui l’Italia ha potuto esprimersi con talenti al di sopra della media internazionale che stanno vivendo giustamente una nuova stagione di interesse.
La musica del futuro, o dell’eterno presente. Cosa gira nel player di Alessandro Monti che vorresti consigliare ai lettori di Jam?
Ah! Mi assegni una grande responsabilità: negli ultimi tempi ascolto molta musica africana o di origine multietnica; i suoni del mondo sono una continua scoperta e nulla mi sorprende di più di quello che è successo fuori dalla sfera della musica occidentale. Una label tedesca come Analog Africa ha un catalogo di materiale favoloso che fotografa i molteplici aspetti del continente africano negli anni ‘70 e ‘80: le uscite sono suddivise per area geografica o stile musicale e a mio parere sono imperdibili.
Dalla musica alla scrittura. Da Unfolk a Riproduzione casuale. Come mai sei passato dagli strumenti alla penna?
Avrei voluto davvero scrivere a penna, ma poi per ovvi motivi ho scelto il computer, anche a causa della mia pessima calligrafia!
Scherzi a parte, tutto è nato da una lunga malattia: ho avuto molto tempo a disposizione e durante la convalescenza si è aggiunta pure la pandemia! Ho cercato di trovare la giusta terapia in un momento di rinascita psicofisica e ha funzionato in tutti i sensi: al mattino ascoltavo e scrivevo, mentre al pomeriggio registravo alcuni esperimenti di musica virtuale che non avrei mai pensato di pubblicare, e invece sono usciti sia il libro Riproduzione Casuale che il disco monti (MP & Records). Credo che dal libro si deduca un grande entusiasmo per la musica che mi ha accompagnato per tutta la vita, ma anche l’amara consapevolezza del periodo attuale.
Il percorso d’ascolto che vuoi offrire al lettore parte da lontano, dai primi ascolti di gioventù, successivamente sedimentati, storicizzati, infine rivisti in chiave critica. Vorrei soffermarmi con te su alcune figure capitali: la prima è quella di Brian Jones, che definisci “padre dei polistrumentisti rock”.
Sì, hai colto perfettamente il sistema con cui ho operato. Nell’introduzione scrivo che, oltre alle musiche che si ascoltavano in famiglia, la prima emozione musicale forte che ricordo era stata l’ascolto di Let’s Spend The Night Together dei Rolling Stones in qualche programma radio dell’epoca. Da lì è iniziato tutto per me, e negli anni ho cercato di approfondire il contributo immenso alla musica di Brian Jones; il problema più grande è che all’epoca nessuno scriveva sulle copertine dei dischi gli strumenti usati. Brian è stato il primo a spaziare in tutte le possibili direzioni: corde, tastiere, fiati e percussioni; se George Harrison aveva avuto l’illuminazione di suonare il sitar in un contesto pop, lui aveva sviluppato ulteriormente il concetto diventando a tutti gli effetti il primo polistrumentista, scelta che avrebbe caratterizzato in modo totale la musica seguente, grazie anche alla tecnologia maneggevole dei registratori multipista che permetteva ai musicisti di sovraincidere a casa le proprie idee e costruire in solitudine vere e proprie opere d’arte come Tubular Bells. Brian aveva la caratteristica di imparare ogni strumento in modo ultraveloce, cosa che all’epoca non era affatto scontata.
Nel libro ho cercato di delineare i suoi contributi come un gioco in cui ognuno deve capire dove inserire quei suoni! Poi l’intuizione finale dell’album registrato in Marocco, pubblicato solo dopo la sua morte, ha aperto un vero e proprio mondo musicale sconosciuto, la world music appunto.
Certamente George e Brian sono stati i veri e propri geni di quegli anni, assieme a Syd Barrett hanno creato tutto, almeno qui in Europa. Per gli States è una situazione che parte da presupposti diversi e infatti quello che è successo ad esempio con i Velvet Underground, Mothers Of Invention, United States Of America è l’altra faccia della medaglia: nel libro analizzo in modo dettagliato anche quell’area.
Faccenda Beatles. Delicata, da affrontare per bene, nonostante l’amore universale che da sempre li lega a tutti noi. A proposito di chiave critica, qual è la tua rilettura del fenomeno beatlesiano?
C’è molta ironia e provocazione nel mio libro… ma quando dico che i Fab Four erano in realtà i Fab Five dico sul serio! Non è stato dato mai abbastanza credito al genio di George Martin, senza di lui non avremmo sentito molti dei capolavori del gruppo. Nel libro analizzo soprattutto la strana serie degli album solisti dopo lo scioglimento, non solo perchè è quella che ho vissuto in diretta ma anche perchè la reputo un’ottima chiave per interpretare i singoli talenti di John, Paul, George, Ringo e… l’altro George! Sono anche fermamente convinto che Sgt Pepper non sia affatto il miglior disco del 1967, e cerco di argomentare le mie idee citando almeno altri 4-5 capolavori che lo superano. Ciò non toglie nulla al grande artigianato dei Beatles che sono stati innovatori in molti campi.
Ascoltando la tua musica, per quanto sfaccettata e eterogenea, viene da pensare che il grande riferimento derivi dal progressive. Non è un caso che ci sia un bel ritratto di tanti “naviganti delle stelle”, da Peter Hammill a Peter Gabriel. Qual è stato il ruolo di queste personalità?
Quel capitolo prende spunto da un album che mi aveva profondamente colpito quand’ero adolescente, Starsailor di Tim Buckley: è stato un pretesto per parlare di alcuni cantanti che hanno ampliato il linguaggio sia vocale che strumentale portandolo ad un livello espressivo superiore.
Il progressive per me oggi rappresenta un vero problema. Essendo cresciuto negli anni ‘70, ho abbracciato con entusiasmo le musiche di Pink Floyd, Genesis, Van Der Graaf, King Crimson, ma quello che oggi si intende per progressive è solo pura nostalgia e mi scontro regolarmente con le idee retrograde e conservatrici degli amanti di quel periodo. Ho scritto un brano per Tim Bowness (che ha gentilmente distribuito i dischi del progetto Unfolk in UK) perchè mi piace molto il suo stile vocale, ma eccetto i dischi dei No-Man non ascolto praticamente nulla di quell’area. Il postrock anni ‘90 è per me la musica che ha maggiormente contribuito a vedere la musica da una nuova ottica progressiva: Talk Talk, Rachel’s, Tortoise, Labradford, perfino un gruppo di sabotatori come i Public Image Ltd (anatema!) inserendo dub, noise e krautrock durante il percorso.
Ascoltando la musica del Collettivo Unfolk o dei miei lavori solisti, credo si evinca che il prog sia solo una delle influenze. Certamente l’idea del concept album in The Venetian Book Of The Dead (dedicato alle vittime del Petrolkimiko della mia città) è di derivazione 70s, ma il suo svolgimento non lo è affatto. La mia collaborazione con un gruppo dichiaratamente prog come Quanah Parker (Suite degli Animali Fantastici) è stata un episodio interessante in cui sono stato motivato a scrivere per una voce splendida come Elisabetta Montino, che non a caso è stata scelta da Tony Pagliuca per il suo nuovo lavoro Rosa Mystica. Lo scrittore Massimo Salari ha recentemente inserito i nostri dischi in ben due libri di quell’area, ma le sue vedute aperte sembrano una rarità nel mondo del progressive…
Per me comunque tutto resta “pop music”: la semplice idea di musica popolare calza ancora a pennello contrapposta alla musica colta. In effetti l’unico capitolo in cui nel mio libro parlo di un gruppo prog è quello dedicato a Henry Cow: mi sono sempre domandato se quella fosse l’unica band realmente progressista sia dal punto di vista musicale che politico; forse la risposta sta nel fatto che era uno dei pochissimi ensemble che traessero ispirazione della musica del XX secolo, quella del ‘900, mentre la maggior parte dei gruppi all’epoca si ispiravano agli autori dei secoli precedenti, la cosiddetta musica classica tradizionale.
Devo ammettere che di quell’epoca oggi amo l’aspetto più estremo: l’hard rock di band come Black Sabbath, Edgar Broughton Band, Groundhogs, i suoni ruvidi che trovo ancora tra i più freschi e influenti e che hanno anticipato l’energia del punk, del metal fino al grunge. E poi parliamoci chiaro: nessuno può nemmeno avvicinarsi a Frank Zappa! La sua musica più che progressiva sembra pura fantascienza… oggi più che mai!
A differenza di tanti tuoi coetanei rimasti legati a suoni e poetica anni ‘60/’70, tu non hai disdegnato la vulgata punk e postpunk, sia nella versione più intellettuale, sia in quella più fisica. Quanto è stata formativa la pars destruens esplosa nel 1977?
Ricordo quell’epoca con molto affetto e ottime vibrazioni: è stato un momento di rottura salutare che ha portato un grande cambiamento in tutti i settori: alcuni musicisti provenienti dal decennio precedente hanno adottato nuovi metodi e nuovi stilemi nei loro progetti, e la successiva new wave si è sviluppata con aspetti diversi sia nel pop che nella musica di ricerca. Nel libro parlo in dettaglio dell’importante contributo femminile nel post punk che è riuscito a creare stimoli nuovi negli anni ‘80, infatti a parte qualche caso isolato (Renaissance, Curved Air, Henry Cow o la ricca scena folk), era stato praticamente assente nel prog. Io sono un tipo curioso di natura e non potevo non essere attratto da quel momento di grande fermento.
I tuoi percorsi d’ascolto non ignorano l’universo jazz e black. Da Carla Bley a Keith Jarrett, da Miles all’hip hop, quanto ti hanno insegnato questi protagonisti, come musicista e più in generale come uomo di pensiero musicale?
Ho voluto dedicare un ampio spazio al jazz e alla musica afrocentrica perchè la ritengo la base di (quasi) tutto quello che abbiamo digerito negli anni. Nulla mi entusiasma di più di una semplice chitarra e una voce: in questo il blues autentico è un’esperienza senza paragoni (vedi la sezione che riguarda Ali Farka Toure), ma consiglio anche il mio reportage da New Orleans sul vero significato del Voodoo! Nel caso di Keith Jarrett invece ho voluto segnalare la sua maestria come polistrumentista, un approccio decisamente diverso da quello di Brian Jones, ma altrettanto straordinario: molti lo considerano solo un pianista ma alcuni dei suoi album più riusciti lo vedono all’opera con altri strumenti.
Più vecchio divento più amo i diversi aspetti della black music: una vera miniera di ispirazione. Suonando uno strumento come il basso, sin da ragazzo avevo colto qualcosa di speciale nel groove del soul e del funk, ma da adolescente ero troppo preso dal rock per apprezzare davvero quell’area. Anche l’ascolto parallelo del jazz mi aveva comunicato qualcosa di speciale: erano mondi che non sentivo contrastanti ma si completavano a vicenda e un genio musicale come Miles Davis era stato l’uomo giusto al momento giusto! Per me resta un esempio di come la musica debba essere interpretata, senza confini e con la giusta dose di provocazione.
L’hip hop è trattato a fondo soprattutto per far capire quanto quell’arte popolare “povera” avesse preso ispirazione dalle radici vere della musica africana: esempi storici come i Last Poets, il primo Gil Scott-Heron o l’immenso Billy Preston (cui dedico un intero capitolo) sono essenziali per capirne l’evoluzione. Grandi protagonisti successivi come Afrika Bambaataa hanno effettuato una vera e propria rivoluzione, inserendo ad esempio i suoni tecnologici dei Kraftwerk nella black music. Ma nulla può essere isolato dal fermento culturale di quegli anni, poi una forza superiore ha improvvisamente fermato tutto e ne ricerco le ragioni. Sono passati pochi anni da quegli ultimi momenti creativi ma se mi volto indietro oggi sembra siano passati secoli.
Stockhausen, Morricone, Brian Eno, Mertens. Alcuni volti della musica colta contemporanea, in qualche caso anche ai confini con la cultura popular. È ancora presto per un parere ponderato o la veloce storicizzazione novecentesca offre strumenti di valutazione rapida?
La musica offre sempre spunti diversi per valutarne l’importanza e il significato: nel libro analizzo alcuni dei miei musicisti colti favoriti ma come giustamente hai fatto notare alcuni sono decisamente in bilico tra cultura popular e serietà. Alcuni di questi escono con le ossa rotte dalle mie pagine: Brian Eno, Wim Mertens, altri emergono dal nulla come Arthur Russell o Tod Dockstader. Va però sottolineato che anche quando parlo in modo critico di alcuni mostri sacri, lo faccio perchè li ritengo comunque personaggi di rilievo.
A parte un gigante come Morricone (di cui analizzo una colonna sonora tra le più oscure), la musica italiana è una sorta di presenza nascosta che affiora qua e là: il Lucio Battisti di Anima Latina, Franco Falsini di Cold Nose o l’indimenticabile Demetrio Stratos di Metrodora. La parte più ampia riguarda però la library music in cui l’Italia ha potuto esprimersi con talenti al di sopra della media internazionale che stanno vivendo giustamente una nuova stagione di interesse.
La musica del futuro, o dell’eterno presente. Cosa gira nel player di Alessandro Monti che vorresti consigliare ai lettori di Jam?
Ah! Mi assegni una grande responsabilità: negli ultimi tempi ascolto molta musica africana o di origine multietnica; i suoni del mondo sono una continua scoperta e nulla mi sorprende di più di quello che è successo fuori dalla sfera della musica occidentale. Una label tedesca come Analog Africa ha un catalogo di materiale favoloso che fotografa i molteplici aspetti del continente africano negli anni ‘70 e ‘80: le uscite sono suddivise per area geografica o stile musicale e a mio parere sono imperdibili.