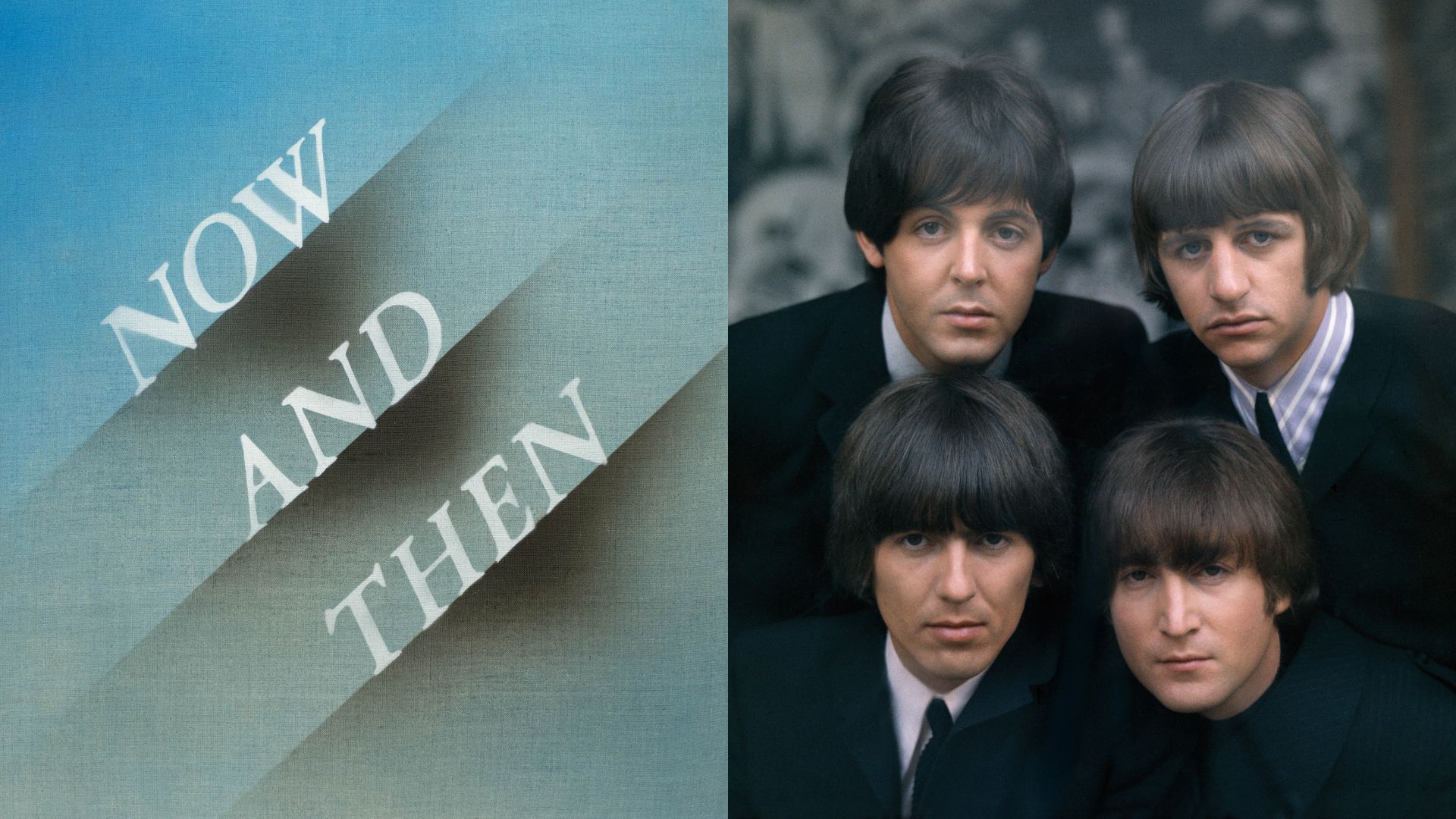Negli ultimi tempi Alberto Rezzi si sta rivelando come uno degli scrittori musicali più preparati, aperti e versatili. Lo abbiamo lasciato con ben due volumi dedicati a Jimi Hendrix, lo ritroviamo fresco autore di La via mistica di George Harrison, classico saggio Mimesis in cui il Beatle mistico viene esplorato nel suo percorso che tanta influenza ha avuto nel pensiero occidentale dell’ultimo mezzo secolo.
Musica, maya, risveglio. Il sottotitolo del tuo nuovo lavoro racchiude pienamente il lungo percorso di George. Stavolta però c’è un elemento autobiografico: è anche il tuo percorso…
Quello con George è stato certamente uno degli incontri più trasformativi, perché mi ha permesso di entrare in profondità in alcune intuizioni e visioni che probabilmente erano silenti in me da tempo e attendevano solo di essere portate alla luce. La chiave autobiografica è certamente rischiosa, ma ho sentito che era l’unica autentica per questo tipo di esperienza, e che al contempo poteva avvicinare chiunque fosse interessato a scoprire qualcosa in più dell’universo Harrison anche dal punto di vista filosofico e spirituale. Sono certo che artisti e uomini come lui, attraverso le canzoni ma anche le scelte di vita e le persone che hanno frequentato, possano davvero essere delle “guide” nell’esplorazione della propria individualità, delle proprie contraddizioni e nella sete di nuove scoperte e nuovi punti di vista sulle cose. Studiare George e provare a entrare un po’ nel suo mondo è stata un’esperienza di profondo coinvolgimento per me, senza dubbio una delle più esaltanti, e la ricerca iniziata “al suo fianco” continuerà in qualche modo anche in futuro.
George è stato il principale ambasciatore del dialogo tra Oriente e Occidente, e la cassa di risonanza beatlesiana non ha fatto altro che amplificare il suo lavoro. Quando George ha avuto davvero consapevolezza del suo ruolo?
Credo che sia stata una consapevolezza maturata nel tempo di pari passo con la sua evoluzione. Senza dubbio la seconda metà degli anni Sessanta è stata molto significativa da questo punto di vista, sia per la scoperta dell’India, sia per il suo tentativo di affermare e affinare la propria identità di songwriter. In alcune canzoni beatlesiane emerge infatti già nitido questo dialogo tra Oriente e Occidente, tanto nelle sonorità e nella strumentazione quanto nei testi. Se però devo individuare uno spartiacque decisivo, penso immediatamente al suo primo lavoro solista post-Beatles, il triplo All Things Must Pass di fine 1970, che rivelò al mondo in tutta la sua portata l’affascinante universo harrisoniano e spalancò le porte a successivi lavori che seguono sostanzialmente la stessa impronta, come Living in the Material World e Dark Horse. Proprio in riferimento a quest’ultimo lavoro e al tour che ne seguì, va però detto che la consapevolezza del suo ruolo di “ambasciatore” non fu certo priva di ostacoli e fraintendimenti da parte del pubblico: da allora, infatti, George rimodulò per certi versi il suo approccio. Nel suo caso, tuttavia, il dialogo tra mondo orientale e occidentale non è stato solo una fase, ma una vera e propria cifra stilistica, compositiva ed esistenziale, a chiaro riflesso del suo percorso di ricerca. Lo testimonia anche il suo lavoro come produttore di opere come Chants of India.
L’ultima canzone incisa storicamente dai Beatles è firmata Harrison, e soprattutto è una delle più esemplari nello spiegare le dinamiche dell’ego. Qual è il punto di forza di I Me Mine?
È una commistione di punti di forza uniti in un unico brano, peraltro piuttosto breve, tra le cui righe si trovano echi dei dissapori e degli egocentrismi interni ai Fab Four ma soprattutto la maturata consapevolezza di Harrison, sulla scia della filosofia indiana, della difficoltà e al contempo della necessità di superare la dimensione del proprio Io. Sotto questo aspetto I Me Mine è anche un invito rivolto a chiunque la ascolti a sondare i limiti della propria autoreferenzialità e a cercare di indagare più a fondo la fonte della propria individualità, per intuirne la connessione con una realtà più profonda e universale.
A testimonianza di quanto fosse per Harrison un nodo cruciale, diede lo stesso paradossale titolo alla sua “autobiografia” e lavorò costantemente su di sé per cercare di sganciarsi dalla relatività delle proprie identificazioni, a cominciare da quella oltremodo ingombrante con “Beatle George”. Emblematiche della sua personalità sono in questo senso le collaborazioni con i Monty Python e l’autoironia con cui rivisitò tutta quell’esperienza. È un tratto che mi ha sempre affascinato molto: la capacità di alcuni artisti, impegnati in un determinato percorso spirituale, di coltivare al contempo uno sguardo ironico e sarcastico sulle cose e sulle esperienze del mondo.
Nel libro approfondisci il cammino solista di George. L’essere ormai da solo, con il fenomeno Beatles alle spalle, ha liberato la sua tensione spirituale oppure fare parte del quartetto lo spingeva ad affermare con maggiore forza i suoi valori mistici?
George ha scoperto l’India e iniziato il suo cammino di ricerca e di trasformazione nel bel mezzo dell’esperienza Beatles e ad un’età ancora giovane, se pensiamo che aveva 22/23 anni quando tutto cominciò. Quel mondo lo attrasse più di ogni altra cosa – tanto che, com’è noto, si mise a studiare sitar con Ravi Shankar per alcuni anni – e certamente cambiò la sua prospettiva rispetto al quartetto, perché quel periodo coincise con la sua crescente consapevolezza e con un’intensa creatività, destinata a non trovare sufficiente ascolto e sbocco all’interno della band. Ci restano dunque alcuni suoi capolavori beatlesiani come The Inner Light o Within You Without You, emblematici della sua ricerca nel misticismo in anni in cui trovava poco spazio d’espressione. La libertà artistica conquistata dopo lo scioglimento fu certamente decisiva per consentirgli di comunicare le sue ricerche, le sue scoperte e il suo mondo musicale: mi riferisco anche ad un certo modo di costruire le canzoni, di usare la sua voce e di sfruttare lo slide per far uscire dalla chitarra melodie e suoni immediatamente riconoscibili. Sotto questo aspetto, la sua produzione solista è davvero una miniera di spunti originali, intuizioni, idee…
Il dialogo allievo-maestro è fondamentale in un percorso iniziatico. Quali sono state le fonti alle quali George si è abbeverato?
Questa è stata una delle mie più forti curiosità iniziali: cercare di scoprire a quali insegnamenti attingesse, a quali figure facesse riferimento. Tra le fonti principali ci sono alcuni maestri conosciuti personalmente e altri incontrati attraverso letture decisive: oltre all’amicizia e alla collaborazione artistica con il grande Ravi Shankar, che George ha sempre riconosciuto come il suo “ponte” diretto con il mondo indiano e vedico, un’altra forte e duratura influenza fu quella di Paramahansa Yogananda e il suo Autobiografia di uno yogi. Un testo che, proprio come ha fatto Harrison, va letto più volte e in momenti diversi, perché contiene diversi livelli e ogni volta rivela qualche nuova intuizione.
Ci sono poi stati altri maestri importanti soprattutto in alcune fasi, come Swami Vivekananda, Swami A.C. Bhaktivedanta e Maharishi Mahesh Yogi: la meditazione, i mantra, il fascino verso la figura di Krishna… Da tutti loro Harrison ha colto aspetti particolari del percorso spirituale che ha cercato di applicare alla propria vita e che spesso hanno trovato riflesso nelle sue canzoni. È proprio a questo intenso dialogo allievo-maestro che mi sono ispirato nella stesura del libro, vestendo in qualche modo i panni del discepolo che cerca risposte alle proprie domande.
George non è stato solo il mistico del quartetto. Alcuni lo chiamavano il “money Beatle” per l’attenzione alla parte finanziaria, inoltre è sempre stato un fine umorista, un inguaribile amante delle belle donne, un uomo di grande successo. Hai compreso qual è stato per lui il veicolo per preservare la sua integrità spirituale?
Il fascino di George sta anche nel non aver mai nascosto a se stesso e agli altri la sua natura contraddittoria e il suo temperamento temerario, il suo essere un “dark horse” proprio come descritto nel brano. Le donne, le tasse, le automobili di lusso, le corse automobilistiche, la produzione cinematografica… Tutto questo ci parla di un uomo molto attivo e presente nelle cose del mondo, ma con un forte anelito alla crescita interiore. In qualunque percorso spirituale si tratta, come diceva lui stesso, di mantenere accesa la fiamma della ricerca, di non dimenticarla e tenerla il più possibile viva. In questo senso, più che di integrità, parlerei di tensione costante, di una ricerca senza fine: continuare a ispirarsi ad alcuni principi spirituali nelle scelte quotidiane quando il mondo con le sue lusinghe ci porta così facilmente nella direzione opposta. Una volta intravista una verità più grande al di là delle apparenze e delle illusioni che costellano le nostre esperienze, non resta che continuare il cammino iniziato, consapevoli degli ostacoli e delle insidie che verranno. È un lavoro di perseveranza, come in molte delle cose più importanti e delicate dell’esistenza. Harrison non ha mai fatto mistero della bellezza e della difficoltà di questo percorso, e anche per questo ha tracciato una strada molto credibile.
George ci ha salutato vent’anni fa. Ha lasciato uno straordinario patrimonio di canzoni. Quali a tuo avviso le più rilevanti per comprendere la forza del suo credo?
È davvero uno straordinario patrimonio, spesso non così conosciuto e approfondito. Mi ha colpito il successo della recente riedizione di All Things Must Pass, un capolavoro senza tempo che non smette di sprigionare la sua forza a oltre 50 anni dall’uscita. Tra le canzoni più emblematiche per le implicazioni filosofico-spirituali e per la splendida tessitura compositiva citerei senza dubbio, oltre a quelle già ricordate, Beware of Darkness e Art of Dying (che nel libro affronto anche in riferimento a Schopenhauer e al tema di Maya, dell’illusione), The Light That Has Lighted the World, Simply Shady, World of Stone, Love Comes to Everyone, Life Itself, Fish on the Sand, per arrivare alle postume Looking for My Life e Stuck Inside a Cloud. Ma se ne potrebbero citare molte altre, a testimonianza della ricchezza di idee che George ha coltivato per tutta la vita e a cui fortunatamente possiamo continuare ad attingere.
Musica, maya, risveglio. Il sottotitolo del tuo nuovo lavoro racchiude pienamente il lungo percorso di George. Stavolta però c’è un elemento autobiografico: è anche il tuo percorso…
Quello con George è stato certamente uno degli incontri più trasformativi, perché mi ha permesso di entrare in profondità in alcune intuizioni e visioni che probabilmente erano silenti in me da tempo e attendevano solo di essere portate alla luce. La chiave autobiografica è certamente rischiosa, ma ho sentito che era l’unica autentica per questo tipo di esperienza, e che al contempo poteva avvicinare chiunque fosse interessato a scoprire qualcosa in più dell’universo Harrison anche dal punto di vista filosofico e spirituale. Sono certo che artisti e uomini come lui, attraverso le canzoni ma anche le scelte di vita e le persone che hanno frequentato, possano davvero essere delle “guide” nell’esplorazione della propria individualità, delle proprie contraddizioni e nella sete di nuove scoperte e nuovi punti di vista sulle cose. Studiare George e provare a entrare un po’ nel suo mondo è stata un’esperienza di profondo coinvolgimento per me, senza dubbio una delle più esaltanti, e la ricerca iniziata “al suo fianco” continuerà in qualche modo anche in futuro.
George è stato il principale ambasciatore del dialogo tra Oriente e Occidente, e la cassa di risonanza beatlesiana non ha fatto altro che amplificare il suo lavoro. Quando George ha avuto davvero consapevolezza del suo ruolo?
Credo che sia stata una consapevolezza maturata nel tempo di pari passo con la sua evoluzione. Senza dubbio la seconda metà degli anni Sessanta è stata molto significativa da questo punto di vista, sia per la scoperta dell’India, sia per il suo tentativo di affermare e affinare la propria identità di songwriter. In alcune canzoni beatlesiane emerge infatti già nitido questo dialogo tra Oriente e Occidente, tanto nelle sonorità e nella strumentazione quanto nei testi. Se però devo individuare uno spartiacque decisivo, penso immediatamente al suo primo lavoro solista post-Beatles, il triplo All Things Must Pass di fine 1970, che rivelò al mondo in tutta la sua portata l’affascinante universo harrisoniano e spalancò le porte a successivi lavori che seguono sostanzialmente la stessa impronta, come Living in the Material World e Dark Horse. Proprio in riferimento a quest’ultimo lavoro e al tour che ne seguì, va però detto che la consapevolezza del suo ruolo di “ambasciatore” non fu certo priva di ostacoli e fraintendimenti da parte del pubblico: da allora, infatti, George rimodulò per certi versi il suo approccio. Nel suo caso, tuttavia, il dialogo tra mondo orientale e occidentale non è stato solo una fase, ma una vera e propria cifra stilistica, compositiva ed esistenziale, a chiaro riflesso del suo percorso di ricerca. Lo testimonia anche il suo lavoro come produttore di opere come Chants of India.
L’ultima canzone incisa storicamente dai Beatles è firmata Harrison, e soprattutto è una delle più esemplari nello spiegare le dinamiche dell’ego. Qual è il punto di forza di I Me Mine?
È una commistione di punti di forza uniti in un unico brano, peraltro piuttosto breve, tra le cui righe si trovano echi dei dissapori e degli egocentrismi interni ai Fab Four ma soprattutto la maturata consapevolezza di Harrison, sulla scia della filosofia indiana, della difficoltà e al contempo della necessità di superare la dimensione del proprio Io. Sotto questo aspetto I Me Mine è anche un invito rivolto a chiunque la ascolti a sondare i limiti della propria autoreferenzialità e a cercare di indagare più a fondo la fonte della propria individualità, per intuirne la connessione con una realtà più profonda e universale.
A testimonianza di quanto fosse per Harrison un nodo cruciale, diede lo stesso paradossale titolo alla sua “autobiografia” e lavorò costantemente su di sé per cercare di sganciarsi dalla relatività delle proprie identificazioni, a cominciare da quella oltremodo ingombrante con “Beatle George”. Emblematiche della sua personalità sono in questo senso le collaborazioni con i Monty Python e l’autoironia con cui rivisitò tutta quell’esperienza. È un tratto che mi ha sempre affascinato molto: la capacità di alcuni artisti, impegnati in un determinato percorso spirituale, di coltivare al contempo uno sguardo ironico e sarcastico sulle cose e sulle esperienze del mondo.
Nel libro approfondisci il cammino solista di George. L’essere ormai da solo, con il fenomeno Beatles alle spalle, ha liberato la sua tensione spirituale oppure fare parte del quartetto lo spingeva ad affermare con maggiore forza i suoi valori mistici?
George ha scoperto l’India e iniziato il suo cammino di ricerca e di trasformazione nel bel mezzo dell’esperienza Beatles e ad un’età ancora giovane, se pensiamo che aveva 22/23 anni quando tutto cominciò. Quel mondo lo attrasse più di ogni altra cosa – tanto che, com’è noto, si mise a studiare sitar con Ravi Shankar per alcuni anni – e certamente cambiò la sua prospettiva rispetto al quartetto, perché quel periodo coincise con la sua crescente consapevolezza e con un’intensa creatività, destinata a non trovare sufficiente ascolto e sbocco all’interno della band. Ci restano dunque alcuni suoi capolavori beatlesiani come The Inner Light o Within You Without You, emblematici della sua ricerca nel misticismo in anni in cui trovava poco spazio d’espressione. La libertà artistica conquistata dopo lo scioglimento fu certamente decisiva per consentirgli di comunicare le sue ricerche, le sue scoperte e il suo mondo musicale: mi riferisco anche ad un certo modo di costruire le canzoni, di usare la sua voce e di sfruttare lo slide per far uscire dalla chitarra melodie e suoni immediatamente riconoscibili. Sotto questo aspetto, la sua produzione solista è davvero una miniera di spunti originali, intuizioni, idee…
Il dialogo allievo-maestro è fondamentale in un percorso iniziatico. Quali sono state le fonti alle quali George si è abbeverato?
Questa è stata una delle mie più forti curiosità iniziali: cercare di scoprire a quali insegnamenti attingesse, a quali figure facesse riferimento. Tra le fonti principali ci sono alcuni maestri conosciuti personalmente e altri incontrati attraverso letture decisive: oltre all’amicizia e alla collaborazione artistica con il grande Ravi Shankar, che George ha sempre riconosciuto come il suo “ponte” diretto con il mondo indiano e vedico, un’altra forte e duratura influenza fu quella di Paramahansa Yogananda e il suo Autobiografia di uno yogi. Un testo che, proprio come ha fatto Harrison, va letto più volte e in momenti diversi, perché contiene diversi livelli e ogni volta rivela qualche nuova intuizione.
Ci sono poi stati altri maestri importanti soprattutto in alcune fasi, come Swami Vivekananda, Swami A.C. Bhaktivedanta e Maharishi Mahesh Yogi: la meditazione, i mantra, il fascino verso la figura di Krishna… Da tutti loro Harrison ha colto aspetti particolari del percorso spirituale che ha cercato di applicare alla propria vita e che spesso hanno trovato riflesso nelle sue canzoni. È proprio a questo intenso dialogo allievo-maestro che mi sono ispirato nella stesura del libro, vestendo in qualche modo i panni del discepolo che cerca risposte alle proprie domande.
George non è stato solo il mistico del quartetto. Alcuni lo chiamavano il “money Beatle” per l’attenzione alla parte finanziaria, inoltre è sempre stato un fine umorista, un inguaribile amante delle belle donne, un uomo di grande successo. Hai compreso qual è stato per lui il veicolo per preservare la sua integrità spirituale?
Il fascino di George sta anche nel non aver mai nascosto a se stesso e agli altri la sua natura contraddittoria e il suo temperamento temerario, il suo essere un “dark horse” proprio come descritto nel brano. Le donne, le tasse, le automobili di lusso, le corse automobilistiche, la produzione cinematografica… Tutto questo ci parla di un uomo molto attivo e presente nelle cose del mondo, ma con un forte anelito alla crescita interiore. In qualunque percorso spirituale si tratta, come diceva lui stesso, di mantenere accesa la fiamma della ricerca, di non dimenticarla e tenerla il più possibile viva. In questo senso, più che di integrità, parlerei di tensione costante, di una ricerca senza fine: continuare a ispirarsi ad alcuni principi spirituali nelle scelte quotidiane quando il mondo con le sue lusinghe ci porta così facilmente nella direzione opposta. Una volta intravista una verità più grande al di là delle apparenze e delle illusioni che costellano le nostre esperienze, non resta che continuare il cammino iniziato, consapevoli degli ostacoli e delle insidie che verranno. È un lavoro di perseveranza, come in molte delle cose più importanti e delicate dell’esistenza. Harrison non ha mai fatto mistero della bellezza e della difficoltà di questo percorso, e anche per questo ha tracciato una strada molto credibile.
George ci ha salutato vent’anni fa. Ha lasciato uno straordinario patrimonio di canzoni. Quali a tuo avviso le più rilevanti per comprendere la forza del suo credo?
È davvero uno straordinario patrimonio, spesso non così conosciuto e approfondito. Mi ha colpito il successo della recente riedizione di All Things Must Pass, un capolavoro senza tempo che non smette di sprigionare la sua forza a oltre 50 anni dall’uscita. Tra le canzoni più emblematiche per le implicazioni filosofico-spirituali e per la splendida tessitura compositiva citerei senza dubbio, oltre a quelle già ricordate, Beware of Darkness e Art of Dying (che nel libro affronto anche in riferimento a Schopenhauer e al tema di Maya, dell’illusione), The Light That Has Lighted the World, Simply Shady, World of Stone, Love Comes to Everyone, Life Itself, Fish on the Sand, per arrivare alle postume Looking for My Life e Stuck Inside a Cloud. Ma se ne potrebbero citare molte altre, a testimonianza della ricchezza di idee che George ha coltivato per tutta la vita e a cui fortunatamente possiamo continuare ad attingere.