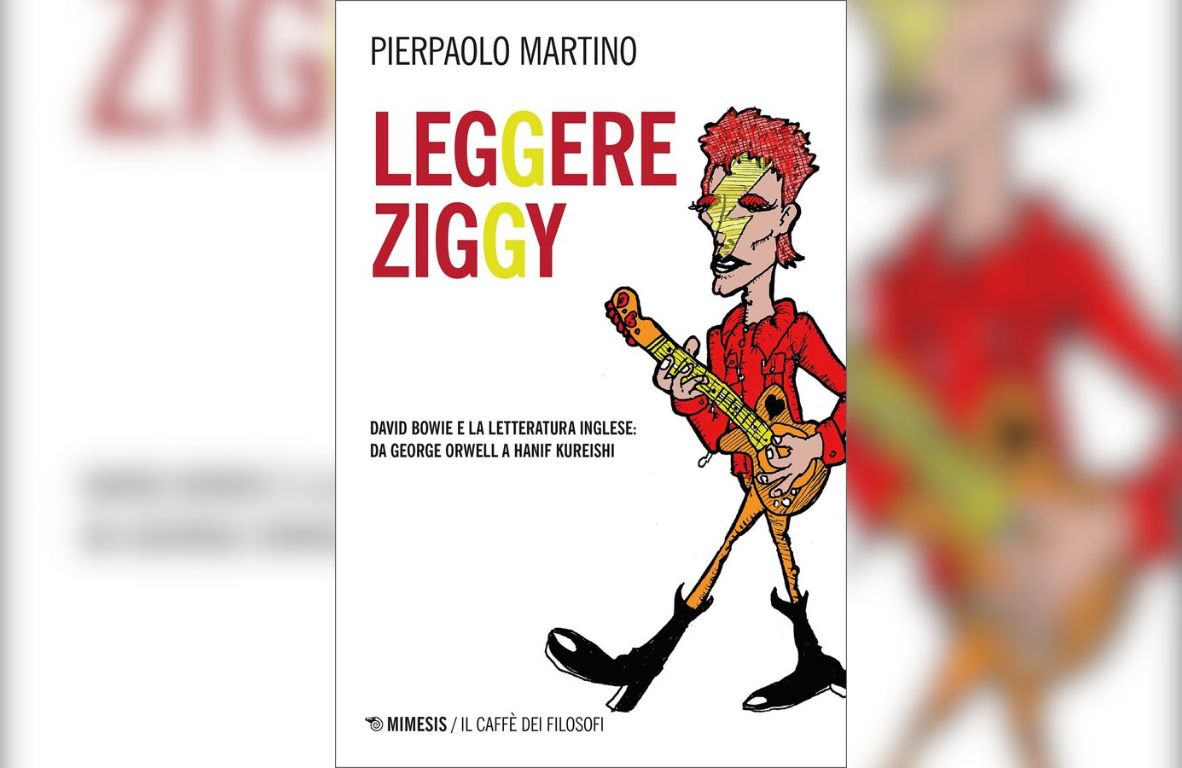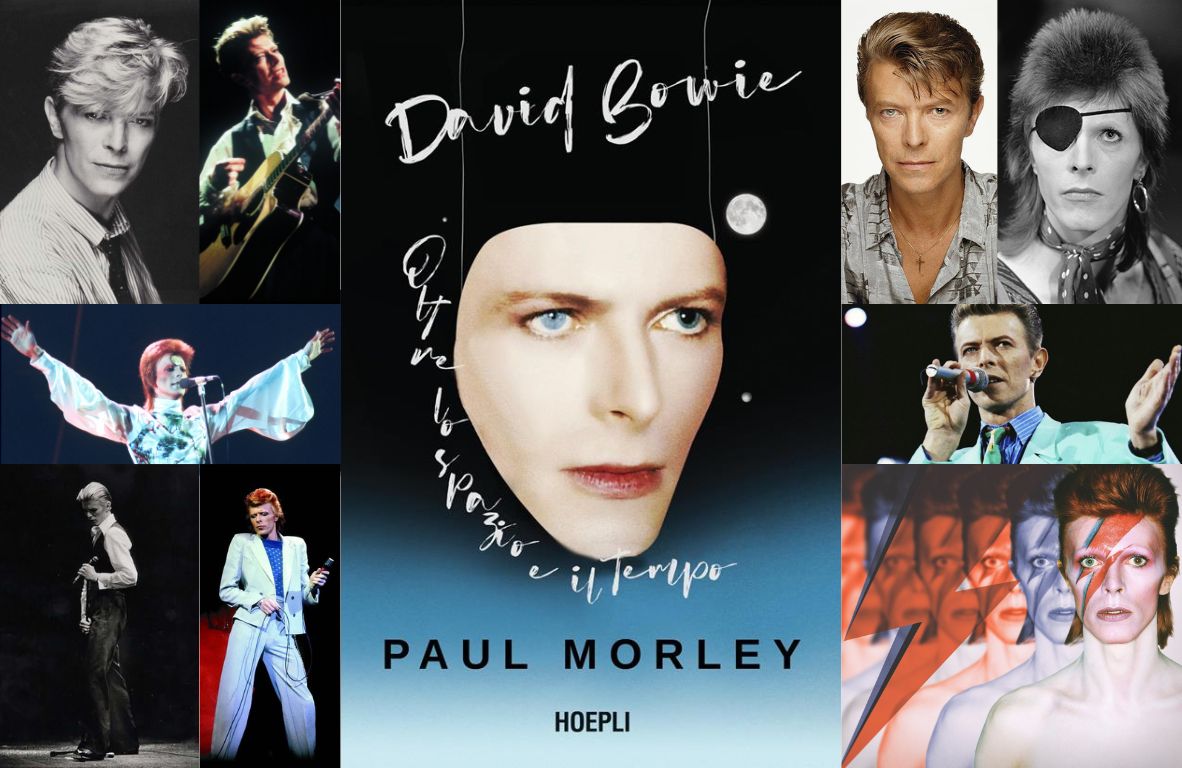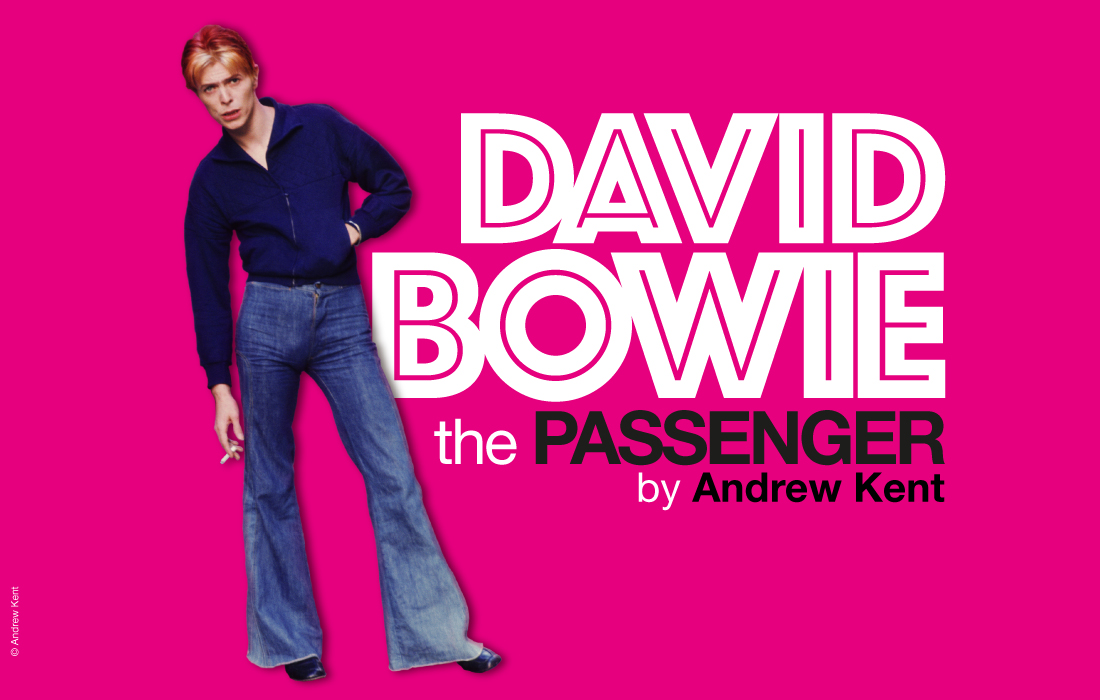I rapporti tra David Bowie e la letteratura inglese in un ottimo testo Mimesis
Leggere Ziggy secondo Pierpaolo Martino
Professore associato di Letteratura inglese all’Università di Bari, nonché musicista poliedrico e trasversale, Pierpaolo Martino non è nuovo ad analisi legate ai rapporti dialettici tra le arti. Anzi, il suo punto di vista sull’universo Bowie è un riferimento per chiunque voglia andare al di là dell’aneddotica scandalistica o del racconto prettamente discografico. David Bowie come oggetto di studio e soprattutto come cartina di tornasole per capire quanto la popular music si sia nutrita – a volte in modo disordinato e vorace, altre volte con misura e approccio chirurgico – di letture, visioni, percezioni. Il suo ultimo libro Leggere Ziggy. David Bowie e la letteratura inglese (Mimesis Edizioni) lo dimostra chiaramente. Ne parliamo con lui.
Facciamo un passo indietro, Pierpaolo, per partire da un dato molto interessante. Credo che David Bowie sia l’artista pop più studiato, soprattutto dopo la sua scomparsa. Secondo te qual è il motivo di tale interesse?
A mio avviso credo che questo abbia, paradossalmente, a che fare con l’incredibile eccedenza e incontenibilità della sua opera. Bowie resiste ad ogni inquadramento dal punto di vista teorico, poetologico e cognitivo; l’incontro e la contaminazione di pratiche e discipline diverse – letterarie, teatrali, musicali, audiovisive – del Bowie talento plurimo (all’insegna del cut-up e del decentramento costante) trasforma la figura di David Bowie in un’insospettata configurazione con cui leggere e recepire i nostri tempi. Di qui la complessità ma anche il fascino legato allo scrivere su Bowie. Ma credo sia davvero importante pensare con Bowie senza ridurlo ad un oggetto di analisi confinato nella musica pop o ad un fenomeno strettamente sociologico o di studi anglistici o comparatistici.
Nel leggere Bowie tra musica e teatro, tra cinema e letteratura, ho scoperto via via come quel tra definisce la logica interstiziale, la filosofia delle soglia come quella più congeniale al grande artista inglese; del resto parlare della musica di Bowie come teatro significa pensare e tradurre il suo discorso artistico in una sorta di dialogo tra dialoghi che coinvolge le molteplici vocazioni dell’autore, in cui la musica interroga altri linguaggi artistici e in cui l’immagine (fotografica, televisiva, cinematografica), la parola letteraria e il suono (musicale) si ridefiniscono a vicenda; in questo senso in Bowie la vita delle arti diventa, come per il suo Maestro Oscar Wilde, la vita come arte. Quello di David fu dunque un talento plurimo, il suo essere musicista (cantante ma anche polistrumentista) si nutriva del suo essere scrittore (autore di quei mini-romanzi che sono le sue songs), ma anche artista visivo e soprattutto attore sia al teatro che al cinema.
La storia del rock ci ha rivelato la voracità degli artisti dell’epoca d’oro. Da McCartney che si interessava di avanguardie alle letture di Syd Barrett e Peter Gabriel, dalla teatralità di Jim Morrison allo studio di Frank Zappa. Bowie non era estraneo a questa temperie, anzi. Come mai quella generazione di ventenni o poco più spalancò così tanto le porte della propria curiosità?
Si tratta a mio avviso di un momento storico in cui le arti dialogavano molto di più tra loro, oggi accade molto meno, c’era molta più apertura al rischio e a una logica del possibile e dell’imprevisto. Oggi si pensa che essere un bravo cantante sia un fatto riconducibile a una mera e rassicurante dimensione tecnica da “fissare” su supporti sonori fedelissimi e diffondere attraverso i potenti canali streaming che conosciamo, in cui spesso la dimensione intermediale (copertine figlie della Pop art, testi con riferimenti letterari ecc) della musica viene persa. A cavallo tra anni sessanta e settanta gli artisti sapevano bene che i linguaggi artistici sono sempre necessariamente in un rapporto di “comprensione rispondente”. Parlando anche solo del dato sonoro/musicale, ogni musicista traeva ispirazione da quello di altri artisti; non dimentichiamo tra l’altro della centralità delle art schools nella formazione di molte star di quel periodo.
Veniamo a Bowie. Parte tutto (o quasi) dalla fantascienza, dall’uomo sulla Luna, dalla tangibilità di mondi altri che restano però irraggiungibili…
Certo, il Bowie degli anni Sessanta, vale a dire quello che scriverà Space Oddity (1969), era un appassionato lettore di fantascienza e nello specifico di autori quali Dick, Bradbury e Asimov. In particolare, come è noto, Space Oddity fu la risposta di Bowie a 2001: Odissea nello spazio di Kubrick; il film in realtà era tratto da una storia di Arthur C. Clarke che colpì molto il giovane Bowie per il senso di isolamento e alienazione che emergeva dalle pagine. La canzone fu pubblicata nel luglio del 1969 quasi in concomitanza dell’allunaggio eppure Space Oddity diceva l’indifferenza di Bowie a quella che Doggett definisce “space fever” e alla convinzione che si trattasse di un viaggio dell’uomo verso il progresso. La reazione bowiana rispetto all’entusiasmo legato allo sbarco sulla Luna fu infatti di disillusione, la vita sulla Luna gli appariva “hollow” ossia vuota, insignificante al pari di quella sulla Terra. In questo senso, il suo Major Tom una volta giunto nello spazio al posto di essere entusiasta per aver varcato il limite terrestre viene dominato da un senso di malinconia che lo porta all’inazione e, come ben dice Critchley, fa della sua missione spaziale un tentativo perfettamente riuscito di suicidio.
Se è vero che Major Tom sembra rimandare allo Shakespeare di Hamlet è anche vero che esso risuona dell’alienazione e del senso di noia di tanta letteratura esistenzialista, ovvero di autori quali Genet, Camus, Sartre che lui conosceva molto bene. E tuttavia Bowie utilizzerà l’idea dello spazio come segno della sua alterità, della sua “other-worldliness”, del suo appartenere a un altro mondo. Così il racconto di una dimensione altra e irraggiungibile diventa possibilità di decostruire visioni del mondo dominate da chiusure o ossessioni identitarie di ogni tipo.
Ziggy Stardust è un disco complesso e stratificato, mi piace leggerlo comparato a Sgt. Pepper. In entrambi il punto di partenza è la riflessione sull’identità, ma se quella beatlesiana riguarda un gruppo all’apice della fama e in rapporto con la propria generazione, il binomio Bowie/Ziggy sembra molto più intrigante. Possiamo considerare l’album del 1972 come una sintesi tra esperienza e studio, tra vicende personali e profondità di lettura?
Certo, la persona di Ziggy sarà una delle massime espressioni della creatività e della capacità di scrittura proprie di Bowie; con Ziggy è la vita stessa dell’artista a farsi scrittura, creando una potente sintesi di influenze e linguaggi molti diversi. Con Ziggy ci mettiamo in ascolto di questa complessità attraverso una comprensione rispondente che non vuole essere un decodificare ma un creare rapporti tra segni iconici sulla base di processi associativi. Il nome stesso “Ziggy Stardust” con-fonde due mondi diametralmente opposti, ovvero rimanda a due artisti profondamente diversi: Legendary Stardust Cowboy e ovviamente Iggy Pop che tanta importanza avrà nella vicenda personale di Bowie.
Quella di Ziggy è una storia affascinante, nutrita da diversi echi letterari, tra cui quelli dell’opera di un visionario della letteratura inglese, ossia l’ H.G. Wells di The Wonderful Visit e The War Of The Worlds. Se i marziani di War Of The Worlds sono “cool and unsympathetic” e moriranno a causa di un batterio terrestre contro il quale i loro sistemi immunitari non erano preparati, gli spider from Mars (e il loro Ziggy) avranno invece la missione di salvare il pianeta con la loro splendida musica e soprattutto con la loro capacità di di-vertire.
È però importante sottolineare come il testo culturale Ziggy Stardust non si esaurisce nella narrazione sonora e letteraria inclusa nel disco, ma si nutre di una complessa dialogica che coinvolge le performance dal vivo e in televisione, le interviste e soprattutto la “iconic appearance” di Bowie “as” Ziggy. In questo senso nella messa in scena, ossia nella performance multimodale di Ziggy, un ruolo centrale lo ebbe soprattutto la fotografia in quanto modalità di scrittura in grado di instaurare un rapporto dialogico con musica e parole. E infatti alcuni dei più bei scatti del periodo glam di Bowie furono firmati da un altro celebre artista giapponese, il fotografo Masayoshi Sukita. Ma non dimentichiamo che Ziggy si affacciò sul mondo anche attraverso la copertina di un album che ritraeva il protagonista per certi versi sulla soglia della “sua” casa in Haddon street (Soho), per dire l’idea di un Bowie che sembra voler accogliere i suoi ascoltatori per condurli nel suo spazio.
Fondamentale fu l’impatto che ebbe la nuova invenzione bowiana in ambito mediatico e in particolare televisivo. Trynka nel suo importante libro dedicato a Bowie, significativamente intitolato Starman, fa riferimento ad un evento storico nell’ambito della televisione britannica dei primi anni Settanta, vale a dire alla puntata di Top of the Pops – il celebre show musicale della BBC – andata in onda nel Luglio del 1972. Com’ è noto è qui che Bowie mise in scena una delle sue performance più celebri, ossia una Starman pensata appositamente per il pubblico della seguitissima trasmissione. Qui Bowie articola un gesto, ossia introduce un’immagine profondamente destabilizzante rispetto all’approccio normativo a questioni di genere e di sessualità imperante nell’austero contesto inglese dei primi anni Settanta. Poco meno di un minuto dal momento dell’ingresso in scena, Bowie alza la sua mano invitando il chitarrista e amico Mick Ronson (dalla folta chioma ossigenata) a raggiungerlo al microfono e cantare con lui: Bowie poggia il suo braccio intorno al collo di Ronson e, come nota Trynka, mentre i due intonano insieme la parola magica del ritornello (“star-man”, appunto) l’invito rivolto agli ascoltatori sembra essere a fuggire non tanto i confini della Terra quanto quelli della sessualità; il postmodernismo musicale di Bowie aprì così le porte di una post-sessualità in cui in molti si identificarono. Quello che resta di questa celebre performance bowiana è il senso di divertimento, di spostamento, di riso accogliente, non prescritto di Bowie; la sua immagine diventa qui soglia, spazio di accesso all’universo trasversale di Ziggy, in cui outsider di ogni tipo finiranno per sentirsi a casa.
Un momento epico nell’ epopea di Ziggy è poi ovviamente legato al suo ritiro definitivo dalle scene, “messo in scena” durante il celebre live allo Hammersmith del 3 luglio del 1973. Diversi erano i motivi che avevano portato Bowie a questa scelta in cui la dimensione privata e quella pubblica ossia commerciale si sovrapposero. Per i fan, tuttavia, l’immagine di Bowie era diventata quella di Ziggy e decretarne la morte da un momento all’altro metteva in discussione quel rapporto di identificazione continua e progressiva con il Ziggy messia del rock; la trasformazione di altri artisti quali ad esempio i Beatles, che ti citavi – da band mod a sperimentatori hippy – era stata molto più graduale. Ma quella di Bowie era una vera e propria strategia in cui passare da un ruolo all’altro significava immergersi in un processo in cui fuggire il self in quanto spazio costrittivo e prevedibile, mettendo in discussione la logica identitaria e l’autenticità cara all’ estetica rock, e che l’avrebbe portato a inventare dopo Ziggy – passando per Aladdin Sane – una nuova interessante maschera Halloween Jack.
Con Diamond Dogs entra in campo un elemento frequente nel rock concettuale, la letteratura distopica. Per quale motivo Bowie e tanti altri colleghi (mi vengono in mente i King Crimson, certi Pink Floyd) guardano a un altrove immaginario per una lettura critica del presente?
Perché credo che in quegli anni certi musicisti erano in grado di mettersi davvero in ascolto di quello che accadeva a livello politico e si trattava molto spesso di un ascolto nutrito da una sensibilità letteraria. Del resto la dark vision di Orwell è stata spessissimo evocata e messa in scena nell’ambito della popular music degli ultimi cinquant’anni in contesti diversissimi (dal punk-rock al rap, dall’indie al jazz e non solo), dunque a cavallo tra anni Sessanta e Settanta ciò risulta particolarmente rilevante se si considera che da sempre – oltre ad essere fonte di intrattenimento – la musica rappresenta uno spazio di resistenza rispetto ad ogni tentativo di controllo verticale della comunicazione, nonché uno spazio di sovversione dell’ordine del discorso.
In questo senso, nel 1973 Stevie Wonder pubblicò una canzone intitolata Big Brother mentre gli Eurhythmics composero nel 1984 la colonna sonora del film di Redford Orwell 1984. Nell’ambito dell’avanguardia, mi piace citare 1984 (pubblicato nel 1973) di Hugh Hopper, Joe’s Garage (1979) di Frank Zappa e per spingerci fino al Nuovo Millennio l’album del 2003 dei Radiohead intitolato Hail to the Thief (in cui il thief, il ladro è G. W. Bush, che notoriamente rubò dei voti durante la campagna presidenziale del 2003) e il cui brano di apertura si intitola 2+2=5, dalla celebre equazione creata da Orwell nel suo romanzo.
Tuttavia il romanzo cult di Orwell assume un significato molto specifico nella vita e nell’opera dello stesso Bowie. Doggett nota come nel 1973 Bowie fu profondamente colpito da un viaggio in treno attraverso il continente russo – in cui “the grim bureaucracy and acute poverty of the fabled Communist paradise stoked his prevailing sense of panic and claustrophobia in the run-up of his final tour as Ziggy Stardust”– e decise di concepire un musical rock sulla raffigurazione orwelliana della società stalinistica nel suo romanzo del 1949. La vedova di Orwell non avallò il progetto, di qui la scelta di Bowie di concepire la sua opera rock come un lavoro ugualmente apocalittico che – sebbene non identificabile con un musical vero e proprio – finì per dar corpo a un complesso spazio ipertestuale composto al tempo stesso da Diamond Dogs e dallo show con cui Bowie lo promosse. Il lavoro che fu pubblicato eccedeva alla fine i confini del romanzo di Orwell – include infatti solo alcune songs direttamente ispirate a Orwell, quali ad esempio Big Bro, We are the Dead e 1984 – per nutrirsi di echi di altri romanzi cult quali A Clockwork Orange (1962) di Anthony Burgess e The Wild Boys (1971) di William Burroughs.
Nel capitolo su Heroes riassumi un momento della storia bowiana di grande sintesi, dalla nascita del Duca Bianco all’elaborazione della trilogia berlinese. Quali sono i principali stimoli per l’artista in una fase di cambiamento del rock? Tra nuovi posizionamenti dell’industria discografica, emersioni di novità e riflusso, Bowie sembra non solo impermeabile agli scossoni ma anche particolarmente “poroso”.
Bowie come uno dei suoi Maestri – su cui mi soffermo in La Filosofia di David Bowie (Mimesis 2016) e nel mio ultimo libro Wilde Now (Palgrave 2023) – ossia Oscar Wilde sapeva che è impossibile pensare l’arte al di fuori del marketplace, di qui la fisionomia complessa di un disco come Heroes che, tuttavia, se è vero che include una super hit riflette anche un particolare sentire politico e un’apertura alla sperimentazione che nasce dalla collaborazione con Eno e dal contesto berlinese, ecco la porosità a cui fai riferimento.
Ma come dici tu il capitolo parte da Station to Station (1976), album davvero importante in cui Bowie dismesse definitivamente le sue maschere glam, si trasformò nel Sottile Duca Bianco, maschera complessa e intrigante che se da un lato rimanda al suo interesse per l’immaginario nazista dall’altro si pone come riferimento al Duca di Milano, Prospero, protagonista di The Tempest (ultimo dramma di Shakespeare), un personaggio complesso, dalle mille qualità e dai mille volti in grado di interrogare e problematizzare (come farà Bowie) alcuni aspetti della sua contemporaneità. La molteplicità di Prospero sembra avere molto a che fare con quella del cantante inglese. Nell’album Bowie appare, tra l’altro al pari di Prospero, un vero e proprio mago, in grado di dirigere un complesso teatro sonoro. L’intenzione teatrale portò infatti Bowie a operare una sintesi di tutte le sue influenze musicali in un elogio dell’idea stessa di arte come processo, prendendo probabilmente spunto da un play di Shakespeare in cui la musica assume un ruolo centrale.
È importante sottolineare come sarà, insieme ad altri fattori, la lettura di Christopher Isherwoood, con le sue affascinanti descrizioni della Berlino prebellica – che tuttavia come insisteva lo scrittore stesso erano legate più all’ immaginazione letteraria che ad un resoconto realistico – a spingere Bowie (che invece credeva di ritrovarvi il mondo isherwoodiano) a trasferirvisi nel 1976 e a “riscrivere” la città nei suoi tre capolavori pensati con Tony Visconti e Brian Eno, vale a dire Low, (1977) Lodger (1979) e appunto Heroes. Del resto nel mondo bowiano le illusioni diventano realtà o almeno il suo aspetto più interessante. Berlino sembrava essere il luogo o meglio lo spazio ideale per le enunciazioni e invenzioni sonore di almeno due dei tre capolavori della trilogia, si trattava infatti di una città fratturata, come lo era il Bowie di questo periodo.
Il book club di David Bowie di John O’Connell elenca i suoi 100 libri consigliati. Alla luce dei tuoi studi sui suoi rapporti con la letteratura inglese, in quali testi pensi si possa trovare la massima fonte di ispirazione bowiana?
Direi senz’altro Orwell (e intendo anche il critico), T.S. Eliot, ovviamente la science fiction, ma credo soprattutto la capacità stessa di pensare la letteratura come viaggio sempre imprevisto e imprevedibile – come sarà la musica di Bowie – un viaggio in cui mettere in rapporto cultura alta e bassa (penso all’inclusione nella Top 100 di Viz ad esempio), storie e geografie diverse, in un processo necessariamente incompibile.
Mi viene in mente Virginia Woolf, che Bowie non include nella sua celebre classifica ma che nel suo romanzo forse più noto, Gita al Faro, ci insegna chiaramente, per riprendere le parole di suo marito Leonard, come “The Journey not the arrival matters”. In questo senso grazie a Bowie, alla sua musica e alle sue letture, riusciamo finalmente a intraprendere un viaggio che non potrà mai concludersi. “Saying No but Meaning YES”, ci ritroviamo al suo fianco in un percorso che ci porta necessariamente fuori, verso quello spazio irraggiungibile, metafora di quella salvifica alterità che dovrebbe definire al meglio ciascuno di noi.